
Photo credit: Alessandra Capodacqua
COME CHIEDERMI LA MANO ALLA TOMBA DI MIA NONNA
“Che spreco di spazio,” sussurri mentre il treno taglia in due
un cimitero le cui metà riposano come ali sonnolente
tra due pinete, poi “che paura” mentre sul finestrino
scorrono volti che sorridono da targhe di ceramica incollate alle croci.
Hai varcato l’oceano per sposarmi, perciò non posso dire
Ne conosco solo una, ma sono tutti miei,
questi morti fatti vampiri che non torneranno
ai loro corpi perché la terra è troppo rumorosa
e la città li ha traditi.
Ma devo avvertirti –
Portiamo cimiteri nella testa,
nella pancia, intorno alle caviglie,
li portiamo al lavoro
e li portiamo a dormire
e quando facciamo l’amore
gemono, sferragliano, cantano.
Quando la schiena affonda sputiamo
imprechiamo e danziamo per allontanare la pena.
Quando ti porterò alla tomba della nonna,
dietro alla fortezza dacia, sarà armata
di domande: quanto è solido il tuo amore, quanto morbide le tue dita,
e i tuoi morti, cosa fai per viziarli?
“Dopo che metti le mani a coppa per afferrare l’anima,”
vorrà sapere, “come la lasci poi andare?”
Non le dire delle ceneri sparse al vento, non dire
che non hai mai versato del vino rosso sulla terra
per soddisfare la sete di tuo padre, o che non gli leggi mai
il giornale della domenica. Non dirle che lo ami
ma non hai mai visto la sua tomba. Tradurrò il tuo silenzio
e stenderò un panno bianco sotto la pergola di rose. Offriremo
pane di noci e chiacchiere, e lei perdonerà, e ci benedirà,
poi mi rispedirà oltre oceano con una bisaccia di spettri.
LUNA
A differenza di te, Khaled, a me hanno detto di guardare
la luna, conoscerla a fondo, decifrare
il suo aspetto cangiante per imparare
a conoscermi, ma ho disobbedito anche a quella
imposizione, adorando invece la sua gemella inferiore.
La mia lingua nativa ha una parola sola
sia per luna sia per mese, luna
che comincia in una scaglia di carne, sboccia
nella bellezza incomparabile di una donna,
poi si accartoccia in se stessa,
la stessa luna che, invisible nelle ali del sole,
registra i nostri desideri, cadenza i nostri sospiri, preserva
il cordone ombelicale della sorellanza. Ma non sapevo nulla di desiderio
o di sangue. Così quando, a quattordici anni, emersi
dal bagno in penombra con strisce cremisi su ambo le cosce,
ero convinta che il mio corpo si fosse squarciato
per far entrare la morte. A quella vista mia nonna e le zie
scoppiarono in un giubilo lacrimoso rialimentato per tutta la sera
con sorsi di grappa alla prugna, danze sfrenate, e brindisi
alla sorella Luna e alla sua visita a casa nostra. Nessuno
mi ha detto che andava tutto bene.
Più tardi, ingobbita tra gli ubriaconi sui sudici treni,
riposerò gli occhi tra drappi di fumo
sulla sua luminosità sagomata, evocherò la mia gemella
dissoluta che fa festa dietro la Cortina di Ferro.
Da questo continente nuovo a cui ho allacciato
la vita, certe notti mi pare di vedere mia figlia,
ancora incompleta, nel cratere cinereo sotto l’occhio destro della luna — ma il mio libro di miti rumeni
insiste che è solo Caino che rimesta la sua caraffa di sangue.
A OVIDIU, DI CUI ANCORA NON RICORDO LA VOCE
Ho rotto una volta una finestra e per tre mesi
ho dovuto dividere con te il primo banco, Ovidiu,
zingarello la cui compagnia
gli insegnanti usavano come punizione.
Avevo dimenticato te e i tuoi otto anni
a portata di bacchetta dalla cattedra
fino a quella notte alle 3 quando il bimbo che spuntava
non era affatto un bimbo, ma la secca spinta
di un terrore nuovo: quando ho cancellato
il ricordo di essere crudele?
perché devo esserlo stata…
Ho fatto attenzione che la mia gamba non sfiorasse mai
la tua, ho schivato il tuo sguardo per convincermi
che le macchie d’inchiostro sul mio palmo richiedessero
piena attenzione, ho creduto alle rozze accuse
o mi sono interrogata, una volta almeno, su tua madre,
infermiera, pubblicamente redarguita agli incontri bisettimanali?
Avrei dovuto avere abbastanza cura per far sì che perfino l’indifferenza
avesse importanza, fargli emettere il suo fantasma. Ma vent’anni dopo
non c’è nessun fantasma, e potrei dirti questo:
abbiamo sofferto tutti. A dieci anni avevamo almeno
un genitore alcolista (tuo padre l’unico conclamato),
a dodici usavamo poche parole per sigillare l’amicizia,
temendoci a vicenda – chiunque poteva essere l’informatore
– perfino questo bimbo in attesa di affiorare dal canale uterino.
CANTO DI NATALE
per Mihai (Jan. 17, 1980-Dec.25, 2007)
Dopo aver detto che non sarebbe entrato
Dopo aver detto che avrebbe mangiato solo cose fatte di ali d’angelo
Dopo aver detto che la faceva nel letto e non poteva dormire sulle mie lenzuola
Dopo aver detto che indossava solo giacche fatte di ali smesse di angelo
Dopo aver detto che non era nato da madre, da padre, o da stella cadente
Dopo aver cantato ancora e seminato riso sul linoleum splendente
Dopo aver mangiato pecan e bevuto brodo d’ortica e sparso il miele
[sulle sue croste
Dopo aver fatto il bagno e pregato rimettendosi i vestiti sporchi
Dopo essersi raggomitolato sotto il lettino vuoto e aver abbracciato
[un cuscino
Dopo essersi alzato per ringraziarmi e avermi chiamato madre, dopo io prego
ma non mi fido, dopo La mia pancia è piena di paura ma non sono un ladro
ha messo in valigia le ali e un cucchiaio d’argento ed è tornato alle strade.
MEMOIR I
I dittatori rumeni Elena e Nicolae Ceausescu sono stati giustiziati il 25 dicembre 1989, dopo vent’anni di regime spietato.
La storia di un popolo è quella delle sue negazioni.
Se impallinassi la storia adesso, non sapreste come asciugarvi
il sudore dai palmi. I vostri poveri palmi, timorosi di metter giù il telecomando.
Devi aver visto, almeno una volta, la notizia dei due dittatori
che negano, finché i proiettili non li zittiscono, il genocidio del loro stesso popolo,
e devi aver visto, più di una volta, lo speciale della PBS sui reparti infami
suppuranti, lettini pieni di fasci d’ossa, provvisti di spettrali sorrisi.
Chi avrebbe immaginato che gli architetti del terrore
sarebbero andati a finire in una caserma improvvisata, i corpi crivellati
così piccoli e rigidi come bambole, non fosse che per le braccia che s’agitano
istericamente. Dodici milioni di noi, per venticinque anni.
Ci hanno guardato strisciare all’unisono verso la mano
che teneva due briciole: una per la spia, una per lo spiato.
Penso che abbiate capito la storia del plotone di esecuzione,
di come, temendo dei sosia, misurammo e rimisurammo i cadaveri,
gli sparammo e gli risparammo. Bramavamo tutti un pezzetto di sangue rappreso,
una pellicina staccata, il pelo di un sopracciglio, un dito sul
grilletto, perciò abbiamo rivisto l’esecuzione per tutto il natale,
abbiamo baciato i nostri informatori, spezzato il pane con gli sconosciuti,
smesso di lapidare i randagi, chiesto perdono agli Zingari.
Abbiamo amato come solo un popolo mai sazio di morte può amare,
abbiamo amato senza condizioni per un lungo giorno in quel natale del 1989.
nello stile di Vijay Seshadri
CANTO DEL PROFUGO
Sedici scomparsi in mare sopravvissuti
al suo seno.
Quando la sua mente s’intrecciò alle alghe,
le labbra fecero scorrere il latte:
donne e uomini morenti, fantasmi di neonati
galleggiano tra i pesci donzella.
La costa li respinse
verso terre avvelenate di guerra.
Il latte ha esaurito i corpi.
*
Padre, tutto ciò che hai mai fatto
è ingozzarti della mia carne.
Mi son cresciuti gli occhi nella pancia
ma il bacino è sprofondato,
assottigliato dall’aceto
e dalle unghie che graffiano.
Come devo chiamare
la tua fame,
i segni dei denti
raggrumati di latte,
la costa che ho raggiunto a stento?
RAPE ROSSE
Diventano più dolci con l’età. Più audaci,
sorprendentemente salde quando le griglio, integre,
nel primo inverno, i rossi carnali come sempre,
ma meno soggette a sanguinare alla più piccola incisione.
Quando apro la stagnola, la lingua calda della rapa
mi fa aprire la bocca. Prendo tutto: fumo terrestre intrecciato,
vapori che s’alzano dal marcio del cuore.
Quando trasferisco il tubero fumante sul tuo piatto
e mi offro di spalmarlo di burro, miele, formaggio di capra,
tu rifiuti, la sola vista ti sembra sgradevole.
Difendo la solitudine delle sue pieghe flosce: un puro cuore che pulsa.
Provo con Afrodite, la dea della rapa rossa, le sue labbra di lava,
Provo con l’Oracolo di Delfi secondo cui le rape valgono tanto argento quanto pesano,
provo con guerrieri alimentati a rape, idromele dell’ispirazione del dio Kvasir,
protégé di Rasputin (glielo leggevi negli occhi),
poi, vedendomi persa, faccio una brutta battuta sul Rap.
Con le dita e il coltello, scarti la buccia bruciacchiata
e tagli la polpa dura in robusti pezzi.
Mangia mangia, non preoccuparti di me, mi piace vederti mangiare.
Mi cibi col tuo stesso cuore baffuto,
poi col mio, le dita macchiate e le rape sono una cosa sola.
RITORNO IN ROMANIA
Il primo giorno, un vecchio scarno e gentile mi attira a sé,
battando col palmo sul sedile accanto a lui. Prima che le parole
imburrino l’aria, si è preso un pezzo del mio pane. Viaggio
da stazione a stazione, su storie sulla moglie del pianista
morta da venti giorni, politici dalla zampa caprina,
uova di ragno che si schiudono nei solchi del cervello,
i giri vani e l’animazione dei tram dai numeri dispari.
Mai soli, almeno, canta lui.
Reimparo freneticamente, benché le suole sudino
ogni volta che si stringono sui cottoli sconnessi.
Un giorno, quasi inciampo
sull’uomo disteso nello scolo
lurido, privo di conoscenza. Mentre aspetto, per abitudine,
l’ambulanza, una donna toglie le formiche
che gli attraversano la faccia, e le deposita
una a una nelle fessure dell’asfalto.
I chioschi del pane rendono semplice la generosità
– una mano paga, l’altra dona.
Un mendicante respinge la pagnotta calda, tuona
Che il pane sia tutto ciò che conosci finché i vermi non ti avranno.
Dopo un mese ho individuato e tracciato
i cassonetti della città, disegnato strisce gialle
su quelli che più probabilmente contengono cibo integro.
La donna che sbuca dal cassonetto
col mio vecchio vestito Free People mi porge
il bastone con cui rovista e pretende la mia pelle.
Corpo, ti ho riportato alla terra che ci ha fatto
senza traduttore, ma non temere
di inciampare e ferirti.
Una volta tornati alle comodità dell’America
il pane, di nuovo, non sarà altro che pane.
Il primo giorno, un vecchio scarno e gentile mi attira a sé,
battando col palmo sul sedile accanto a lui. Prima che le parole
imburrino l’aria, si è preso un pezzo del mio pane. Viaggio
da stazione a stazione, su storie sulla moglie del pianista
morta da venti giorni, politici dalla zampa caprina
uova di ragno che si schiudono nei solchi del cervello,
i giri vani e l’animazione dei tram dai numeri dispari.
Mai soli, almeno, canta lui.
Reimparo freneticamente, benché le suole sudino
ogni volta che si stringono sui cottoli sconnessi.
Un giorno, quasi inciampo
sull’uomo disteso nello scolo
lurido, privo di conoscenza. Mentre aspetto, per abitudine,
l’ambulanza, una donna toglie le formiche
che gli attraversano la faccia, e le deposita
una a una nelle fessure dell’asfalto.
I chioschi del pane rendono semplice la generosità
– una mano paga, l’altra dona.
Un mendicante respinge la pagnotta calda, tuona
Che il pane sia tutto ciò che conosci finché i vermi non ti avranno.
Dopo un mese ho individuato e tracciato
i cassonetti della città, disegnato strisce gialle
su quelli che più probabilmente contengono cibo integro.
La donna che sbuca dal cassonetto
col mio vecchio vestito Free People mi porge
il bastone con cui rovista e pretende la mia pelle.
Corpo, ti ho riportato alla terra che ci ha fatto
senza traduttore, ma non temere
di inciampare e ferirti.
Una volta tornati alle comodità dell’America
il pane, di nuovo, non sarà altro che pane.
Traduzioni di Andrea Sirotti
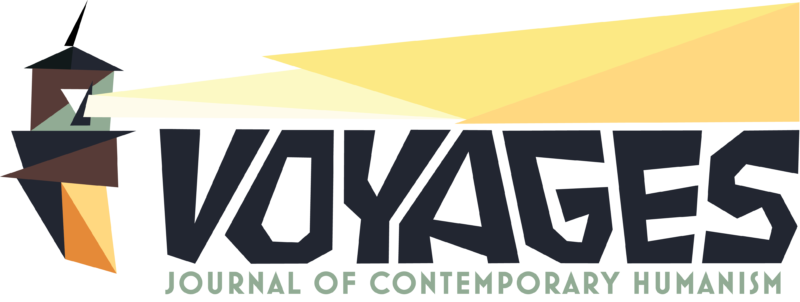

You must be logged in to post a comment.