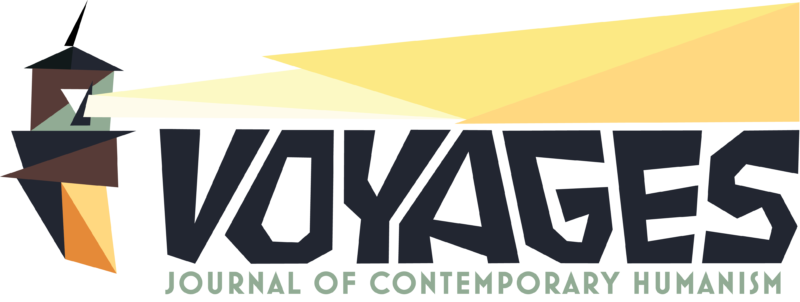Se c’è mai stato un momento per pensare seriamente al fallimento, quello è proprio adesso.
Siamo in un’era di progresso accelerato. Siamo testimoni di progresso nella scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella medicina e in quasi tutte le forme delle conquiste umane che si succedono ad una velocità mai vista prima. Sul funzionamento del cervello umano e delle galassie lontane sappiamo più di quanto i nostri antenati avrebbero mai immaginato. Il progetto di un essere umano superiore – più sano, più forte, più sveglio, più bello, più longevo – sembra essere in cantiere. Perfino l’immortalità sembra fattibile, il possibile risultato di un’ingegneria genetica sempre migliore.
Certamente la promessa del progresso e del miglioramento umano continuo è attraente. Ma c’è anche un pericolo in ciò – che in questo futuro più ‘perfetto’, il fallimento diventi obsoleto.
Perché dovremmo curarci ? E perché dovrebbe proprio la filosofia preoccuparsi del fallimento? Non ha di meglio da fare? La risposta è semplice: la filosofia si trova in una posizione privilegiata per occuparsi del fallimento, perché lo conosce intimamente. Infondo la storia della filosofia occidentale non è altro che una lunga successione di fallimenti, seppur fecondi e affascinanti. Tutti i maggiori filosofi si affermano tipicamente prendendo di mira i “fallimenti”, gli “errori,” ragionamenti falsi, o le “ingenuità” di altri filosofi, solo per essere poi a loro volta liquidati dopo da altri come un altro fallimento. Ogni nuova generazione di filosofi considera suo dovere indicare gli errori di quella precedente, come se qualsiasi cosa la filosofia faccia, questa sia destinata a fallire. Tuttavia di fallimento in fallimento ha prosperato per secoli. Per dirla con Emmanuel Levinas (in un’intervista a Richard Kearney), “la migliore cosa della filosofia è che fallisce”. Il fallimento sembra nutrire la filosofia, tenerla viva. In altre parole, la filosofia riesce solo in quanto fallisce.
Permettetemi di fare un elogio del fallimento.
Il fallimento è significativo per diverse ragioni, tre delle quali vorrei discutere.
Il fallimento ci permette di vedere la nostra esistenza nella sua nuda condizione.
Ogni volta che accade, il fallimento ci rivela quanto la nostra esistenza sia vicina al suo opposto. Per istinto di sopravvivenza, o per semplice cecità, tendiamo a vedere il mondo come un luogo solido, affidabile, indistruttibile. E troviamo estremamente difficile concepire che questo mondo esista senza di noi. “È assolutamente impossibile per un essere pensante concepire la propria non-esistenza, la fine del proprio pensiero e della propria vita,” notava Goethe. Poiché tendiamo ad autoingannarci, dimentichiamo quanto siamo vicini a non essere ciò che sempre siamo. Il guasto del motore di un aereo potrebbe essere più che sufficiente a porre fine a tutto; perfino un sasso che cade o i freni difettosi di una macchina possono sortire questo risultato. E, benché il fallimento non debba essere sempre fatale, porta sempre con sé un certo grado di minaccia esistenziale.
Il fallimento è l’irruzione improvvisa del nulla nel pieno dell’esistenza. Sperimentare il fallimento significa iniziare a vedere le lacerazioni nel tessuto dell’essere, e questo è il momento esatto in cui metabolizzato adeguatamente, il fallimento si dimostra come una benedizione mascherata, giacché c’è proprio questa minaccia costante, in agguato, che dovrebbe renderci consapevoli delle straordinarietà del nostro essere: il miracolo di esistere comunque anche quando non c’è nessuna ragione che questo accada. Saperlo ci dà qualche dignità.
Letto in questo ruolo il fallimento ha una funzione distintamente terapeutica. La maggior parte di noi (eccezione fatta per quelli più consapevoli di se stessi o per quelli illuminati) soffre cronicamente di uno scarso adattamento all’esistenza; ci immaginiamo compulsivamente molto più importanti di quanto siamo, e ci comportiamo come se il mondo esistesse per amor nostro; nei nostri momenti peggiori ci piazziamo come bambini al centro di tutto e aspettiamo che il resto dell’universo si metta al nostro servizio. Insaziabilmente divoriamo altre specie, priviamo il pianeta di vita e lo colmiamo di rifiuti. Il fallimento potrebbe essere una medicina contro tanta arroganza e hubris, poiché spesso porta con sé l’umiltà.
La nostra capacità di fallire è essenziale per quello che siamo.
Dobbiamo conservare, coltivare, tenerci cara questa capacità. E’ cruciale che rimaniamo fondamentalmente creature imperfette, incomplete, soggette all’errore. In altre parole, è cruciale che ci sia sempre un divario fra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Qualsiasi realizzazione è stata resa possibile nella storia, precisamente grazie a questo spazio vuoto. E’ solo in questo interstizio che la gente, individui e società, può realizzare qualcosa. Con questo non siamo diventati qualcosa di meglio; rimaniamo lo stesso materiale debole, difettoso. Ma lo spettacolo dei nostri difetti può essere così insopportabile che talvolta ci svergogna e ci spinge a fare del bene. Ironicamente, la lotta con i nostri fallimenti può far emergere la nostra parte migliore.
La differenza fra quello che siamo e ciò che possiamo essere è anche il luogo in cui vengono concepite le utopie. La letteratura utopica, nella sua parte migliore, può documentare dettagliatamente la nostra lotta con il fallimento personale e della società. Sebbene spesso costruite in mondi di eccesso e pienezza, le utopie sono una reazione alle mancanze e alla precarietà dell’esistenza; sono la miglior espressione di ciò che ci manca di più. L’opera di Thomas More non tratta di un’isola immaginaria, ma dell’Inghilterra del suo tempo. Le utopie possono sembrare celebrazioni della perfezione umana, ma lette al rovescio sono ammissioni spettacolari del fallimento, dell’imperfezione e dell’imbarazzo.
Eppure è cruciale continuare a sognare e tessere utopie. Se non fosse per alcuni sognatori, oggi vivremmo in un mondo molto più brutto. Ma soprattutto, senza sogni e utopie ci estingueremmo come specie. Supponiamo che un giorno la scienza risolva tutti i nostri problemi: saremo perfettamente sani, vivremo un tempo indefinito e i nostri cervelli, grazie ad alcuni miglioramenti, lavoreranno come i computer. Quel giorno saremo una cosa molto interessante, ma non sono sicuro che avremo ciò per cui valga la pena vivere. Saremo virtualmente perfetti ed essenzialmente morti.
In definitiva è proprio la nostra capacità di fallire che ci fa umani; il nostro essere essenzialmente creature fallimentari, soggiace ogni aspirazione. Il fallimento, la paura di fallire e imparare come evitarlo nel futuro sono parti di un processo attraverso il quale vengono decisi la forma e il destino dell’umanità. Ecco perché, come suggerivo prima, la capacità di fallire è qualcosa che dobbiamo assolutamente conservare, indipendentemente da quello che dicono gli ottimisti di professione. Tale cosa è un valore da preservare, più ancora dei capolavori, dei monumenti e di altri compimenti, poiché, in qualche modo, la capacità di fallire è molto più importante di qualsiasi successo umano individuale: è ciò che lo rende possibile.
Siamo progettati per fallire
Indipendentemente da come si svolgano le nostre vite, da quanto svegli, operosi o diligenti siamo, la stessa fine attende tutti noi: “il fallimento biologico”. La “minaccia esistenziale” di quel fallimento è stata sempre con noi, anche se per sopravvivere in uno stato di relativa contentezza, la maggior parte di noi ha finto di non vederla. Questa pretesa non ci ha fermati dall’avanzare verso la nostra destinazione; sempre più velocemente, “in proporzione inversa al quadrato della distanza dalla morte”, come magistralmente descrive il processo l’Ivan Il’ic di Tolstoj. Tuttavia, il personaggio di Tolstoj non ci è ora di grande aiuto. La questione essenziale è piuttosto come rapportarsi al grande fallimento, come affrontarlo, abbracciarlo e possederlo – qualcosa che il povero Ivan non riesce a fare.
Un modello migliore può essere Antonius Block nel film “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman. Block, un cavaliere di ritorno dalle crociate caduto in una crisi di fede, è messo a confronto con il grande fallimento che assume sembianze umane. Non esita a affrontare la Morte a testa alta. Non scappa via, non implora misericordia, ma la sfida semplicemente ad una partita a scacchi. Inutile dire che non può vincere in un tale gioco – nessuno può – ma la vittoria non è il punto. Si gioca contro il grande fallimento finale non per vincere, ma per imparare a fallire.
Bergman filosofo ci dà una grande lezione. Tutti noi finiamo con un fallimento, ma questa non è la cosa più importante. Ciò che conta è come falliamo e cosa guadagniamo nel processo. Nel breve intervallo del suo gioco con la Morte, Antonius Block deve aver sperimentato più di quanto l’abbia fatto in una vita intera. Alla fine, certamente perde, ma realizza qualcosa di raro. Non solo trasforma il fallimento in un’arte, ma riesce a rendere l’arte di fallire una parte profonda dell’arte di vivere.
Voyages offre la versione italiana di alcune sue riflessioni apparse sotto il titolo In Praise of Failure in New York Times, The Stone series; online edition, 15 Dicembre 2013.
Traduzione: Gabriela Dragnea Horvath
Editing: Monica Merli