
Photo Credit: Rocco Rorandelli
Gocce
Pioveva, ad aghi sottili e taglienti. Le gocce si confondevano col grigio uniforme della nuvolaglia compatta e liscia. Cadevano appena inclinate, senza sosta, e sembrava che la pioggia non dovesse mai cessare. Ma una goccia si stancò, con gran sorpresa delle altre che, nella caduta verticale per un attimo la scorgevano, tremante, ma risolutamente sospesa a mezz’aria, e si arrestò. Altre, più curiose, osarono fermarsi alla sua altezza per osservarla, seguite da altre ancora, finché lentamente si formò ad una ventina di metri dal suolo uno strato di gocce non cadute e non cadenti, che, addensandosi quelle che sopraggiunte dall’alto non riuscivano a passare e si affollavano sopra di loro, oscillavano alla brezza lieve che ne aveva inclinato la traiettoria poco prima. Ora una sorta di tappeto umido, vibrante e traslucido incombeva su un intero isolato e forse oltre, anche se non è dato aver certezze al riguardo. Stavano lì, le gocce, apparentemente non affaticate dal rifiuto di cadere al suolo, come se la forza di gravità non le riguardasse. In basso i passanti, che si erano appena resi conto dell’improvvisa interruzione del diluvio, avevano volto distrattamente lo sguardo all’insù, in cerca di conferme. Anziché imbattersi nel turgore grigio del cielo che si prende una pausa, si erano trovati attoniti a contemplare una superficie vitrea, sospesa a pochi metri dai loro nasi, frusciante come un campo di grano accarezzato dal vento e mutevole come quello stesso campo attraversato a gran galoppo dall’ombra di una nuvola. Fu più la sorpresa che il senso di una minaccia. A tratti una goccia cadeva, non foss’altro che per il peso di quelle che gravavano sulle prime file, ma era evidente che si trattava di un effetto non voluto, del cedimento occasionale d’una volontà concorde. Più strana ancora era la sensazione inspiegabile che a tener sospese in aria quelle gocce infinite ed unanimi fosse una sorta di curiosità, se mai tale categoria sia applicabile a minuscole quantità di liquido raccolte in un gas. Come se anziché limitarsi a cadere a terra per non esser più, senza aver avuto il tempo di riflettere nulla, avessero voluto prendersi il tempo d’osservare la loro destinazione, non diversamente da un viaggiatore che si ferma a contemplare dall’alto di una collina la città che lo attende al termine di un viaggio lungo ed incerto, perché sa che solo la distanza protegge le speranze e le illusioni.Irruppe il vento che in alto, ancora a gran distanza da quel vibrante specchio che si inspessiva, mise in fuga le nuvole aprendo grandi squarci celesti. Impiegò poco il sole a insinuare i suoi raggi e a raggiungere le gocce ribelli che accese di colori infiniti e cangianti. Quel che era apparso uno specchio brulicante mutò in un immenso caleidoscopio, un canto della luce e una danza breve e disperata. Uno scoppiettio gentile, come di bolle di sapone trafitte dalle dita di un bambino, iniziò a farsi sentire e annunciò la fine. Una ad una e poi fila dopo fila le gocce si dissolsero in un soffio marezzando l’aria e lasciando nelle retine di chi – tutti – non aveva distolto lo sguardo un solo attimo dall’insolito fenomeno, striature policrome, di effimera, irripetibile bellezza. Tutto durò molto poco, ma non fu dimenticato. Lasciò nella gente, anche nei più cinici, la sensazione di non essere soli e quella, lancinante, di poter essere osservati da un mondo che, creduto insensibile, aveva preso vita. Da quel giorno in poi la vita, per quei testimoni, fu l’attesa vana che accadesse di nuovo.
Lettera e lettere
Un tale, che aveva cambiato alcune volte la sua vita e, irrimediabilmente, quelle di chi gli stava accanto, un giorno decise di scrivere a suo figlio.
Il figlio diciottenne, che pare avesse assai sofferto per la decisione del padre di andarsene, attenuatosi forse il rancore, lo osservava con disincanto e limitava i suoi contatti con lui ad occasionali telefonate, ancor più occasionali incontri e alla rituale condivisione dei dolori.
Da questa latitanza e dalla reticenza non più che paziente del figlio nasceva l’urgenza della lettera. Non che fosse la prima, ma il cinquantenne, incline alle illusioni, nutriva la speranza che si rivelasse decisiva, come una chiave ritrovata.
Incapace di ascolto e meditazione, J. (l’iniziale è più che sufficiente ed evita ripetizioni) pensava che parlare fosse la soluzione, che manifestarsi, anziché assistere alle altrui epifanie, potesse indurre il mondo a cambiare, in suo onore e a suo vantaggio. Sapeva, in teoria, dell’importanza del saper ascoltare, ma quando vi si cimentava, non ne ricavava che silenzi, più prolungati che grati. Scrisse dunque la lettera, per contenuto non molto dissimile da altre, e la spedì con l’animo di un naufrago che, ormai alla fame, su una zattera malferma, infila un messaggio nella bottiglia e lo affida al mare.
Tra i pochi pregi della missiva, una certa sua brevità, la presenza di alcuni punti interrogativi e la dolente rinuncia ad aggettivi ed avverbi.
Le poste del paese in cui padre e figlio vivevano non erano note per sollecitudine e affidabilità. Durante il tortuoso tragitto del plico, probabilmente a causa del cattivo stato delle strade, della poca cura per le sospensioni dei veicoli addetti al recapito e dello stile di guida di autisti inclini al bere e alla malinconia, si persero quasi tutte le lettere che componevano le parole e le frasi faticosamente tornite in settimane di indugi. I caratteri scivolarono con brevi squittii staccandosi dal foglio di carta ed uscirono semplicemente dalla busta mal insalivata, depositandosi forse sul lurido pianale di un furgone, sul fondo del sacco del postino o nel fango invernale di quei giorni. Alcuni entrarono di soppiatto nel tepore di altre buste e, aggiungendosi a parole e frasi lì alloggiate, crearono equivoci di cui nulla è dato sapere.Il foglio arrivò bianco, senza neppur l’ombra dell’inchiostro che lo aveva solcato, non fosse per una J aggrappata al suo margine inferiore, come il naufrago di poche righe fa alla zattera. Lì, accartocciata e tremante, il ricciolo, cui tanto teneva il padre, piegato, la trovò il figlio dopo aver aperto la busta sotto lo sguardo inquisitore della madre. Non ebbe dubbi sul mittente.
Non mancò di rassicurare la madre nel congedarla. Poi, camminando nella nebbia del paese che avrebbe presto lasciato, pensò alla garrula vanità del padre e alla voce di una lettera quando è sola per miglia, quando non è preceduta né seguita da una sua simile. Immaginò il suono di una mano sola e provò un breve turbamento. Nell’assedio di quel pensiero indugiò fra due soluzioni, spegnere quella voce sottile come il sospiro di una freccia stanca o dare a quella freccia un bersaglio. Perso in quella nebbia fitta gli venne di paragonarsi alla J sul bianco del foglio, intuì forse che non siamo altro che iniziali e si convinse che finalmente e suo malgrado il padre aveva raggiunto il silenzio che da lui si attendeva.
Il Bambino Verde
Un bambino verde uscì da un prato, dove si era fino a quel momento confuso fra l’erba. Sbucò sull’asfalto e al suo apparire persone debitamente grigie lo decretarono, se ben disposte, malato o, più sbrigativamente, estraneo al consorzio locale, pervertitore dell’ordine e pericoloso, invocandone la soppressione o l’espulsione verso la terra d’origine. Alla quale il bimbo, ruotato e messo nella giusta direzione, da mani incolori e decise, dovette avviarsi. Nel frattempo un’estate asciutta come un no aveva seccato l’erba. Uomini gialli, emersi da quello sterpame, non riconobbero nel fanciullo il passato abitante di quella stessa landa e, incerti sul da farsi, lo rinchiusero in una gabbia di canne dorate e secche. Si riunirono per stabilirne la sorte, ma il cielo, fin lì d’un abbagliante azzurro, si coprì di una scura coltre di nuvole, compatte e irrevocabili. Da bionda che era la scena degradò ad un cupo, intristito marrone percorso dal blu, del che non ebbe sollievo il bambino che verde era e verde, ad onta del clima, rimaneva. Cani ringhianti color terra di Siena, emersi dalle zolle e come queste duri e affilati, si posero al suo inseguimento nel vento che spingendo via le nuvole consentì però al sole di toccare quella terra condannata a non adagiarsi mai su una tinta, schiarendola d’improvviso. I cani scomparvero nell’improvvisa argilla. Il sole era basso e, anziché tornare all’impietoso giallo di prima, il suolo si fece di un morbido, pagano arancione, colore notoriamente tollerante e amichevole in particolare con i verdi. Il fanciullo, che nel frattempo le fughe avevano smagrito e allungato come uno stelo, si addormentò fra le braccia di quell’incendio tardivo. Giunse la notte senza luna e cancellò ogni tinta nel suo inchiostro, come una madre che spenge la luce sul litigio dei figli piccoli obbligandoli al silenzio. Terminò lo spettacolo. La terrà respirò libera, finalmente sveglia dall’incubo del giorno, che è la sua notte. Il verde del bambino non scomparve. Si addormentò con lui in attesa di tempi migliori. Dormono ancora.
Il Colore negli Occhi
Si tramanda, da pochi e a beneficio di pochi, la storia di un bambino i cui occhi cambiavano colore a seconda di quel che osservava. Sia chiaro, non si parla del riflesso di quel che vedeva – una banana, un tramonto o lo sportello metallico di una cassetta di sicurezza – ma dell’iride che dal comune color nocciola impostogli da madre natura trasfigurava assumendo una colorazione compatta in rapporto diretto ma variabile con l’oggetto della sua attenzione.
Infatti, non necessariamente la relazione era speculare, ossia non sempre l’occhio si faceva nero la notte o verde in un bosco. Capitava che al blu del mare l’iride reagisse in termini complementari facendosi gialla o con l’imprevedibilità delle emozioni virasse al rosa. Talvolta la durata della mutazione trascendeva, spesso di molto, quella dello stimolo e occorreva tempo perché l’occhio tornasse al familiare e comunissimo marrone. Trattandosi di un bambino molto sensibile al mondo esterno i suoi occhi finirono col variare di tinta tanto spesso da non consentire né a lui, né ai suoi genitori né tanto meno ad altri, di stabilire di quale colore fossero. Un caleidoscopio instancabile e ostinato.
Esempio fra i molti, all’atto della prima emissione della carta d’identità l’imbarazzo fu palpabile anche perché la formalità dovette svolgersi in un ufficio dell’anagrafe le cui pareti, al fine di favorire la benevolenza di utenti irascibili e, con meno probabilità di successo, lo zelo degli impiegati, erano state verniciate di ogni colore cui competesse una lunghezza d’onda. Il problema si fece insolubile allorquando, pur affidandosi alla memoria dei genitori (gli occhi sono, erano marroni e lo diverranno nuovamente, belavano, ormai prossimi al pianto), si dovette constatare che sulla fotografia prodotta dal fanciullo e scattata in un comune fotomaton, reagendo alla lente incassata del congegno le iridi si erano frammentate in schegge innumerevoli e policrome.
In breve, nessun pubblico ufficiale potè asseverare di quale colore avesse gli occhi e se questi avessero una tinta indipendente da quel che vedevano.
Fenomeno da bambino, zimbello durante l’adolescenza, U. fu dimenticato già in gioventù. Genitori saggi gli evitarono i dolori che toccano in sorte alle celebrità precoci ed effimere, rifiutandolo a show televisivi e serate in discoteche. Lo salvarono dalla tristezza dei freak dimenticati e seppero offrirgli anni in apparenza sereni per quantosommessi e vagamente remoti, come vissuti in un luogo in cui non penetrasse, se non in forma di brusio indistinto, il battito del mondo. Crebbe, distratto e gentile, spesso curvo, sempre pallido, pressochè incolore, quasi le tinte avessero deciso di ritrarsi e concentrarsi negli occhi, che aveva grandi e ombreggiati da ciglia lunghe, femminili.
Il suo lavoro, burocratico e svolto con trasognata diligenza, non fu d’ostacolo alla sua natura, né lo furono colleghi, oscillanti fra l’indifferenza e la benevolenza che, talvolta, si riservano a chi ha il buon gusto d’appartarsi.
Ma fu amato – e molto – da una donna che gli occhi li usava per mestiere e che, vincendo la timidezza di quel semaforo vivente, seppe sposarlo, proteggerlo senza separarlo dal mondo ed osservarlo instancabilmente. Non è escluso che parte di quel sentimento cui dava il nome di amore fosse un’ostinata curiosità. E non è del resto anche questo l’amore?
Lei si chiedeva, tormentandosi, se chi gli era stato attorno non avesse sbagliato tutto, perché se tutti si erano concentrati, come falene catturate dalla luce, sui colori dei suoi occhi, nessuno sembrava aver cercato di capire come e quel che i suoi occhi vedevano.
Quello strano sguardo, solo apparentemente rivolto al mondo esterno, forse era l’effetto del suo tentativo di guardare i suoi stessi occhi, vederli da dietro, con occhi più interni ed intimi, annidati in una qualche insondabile profondità, tra la retina e il nervo ottico, non dissimile da quella del prigioniero che dal fondo della sua cella non può che vedere un rettangolo di cielo attraverso una finestrella alta, irraggiungibile.
La cecità, inavvertita dagli altri, lo raggiunse portandogli in dono il primo, autentico sorriso della sua vita, una risata silenziosa e larga di sollievo, come si fosse liberato, finalmente, del peso di essere ad un tempo finestra e specchio.
La morte lo colse, senza scosse, e non meno generosa: fu trovato, pallido come sempre, accasciato sulla sua logora poltrona, davanti ad una finestra, gli occhi spalancati, quasi trasparenti come stagni appena solcati da una brezza, abbandonati da ogni colore eppure vivi, frementi. Chi lo vide, uno dei suoi pochi amici, ebbe l’impressione che gli occhi, quei suoi occhi immemori come balconi al vento, si fossero spogliati delle maschere innumerevoli che il mondo aveva posato sulla loro acqua innocente e respirassero leggeri.Pare, in base ad una discussa etimologia, che colore possa derivare, per vie traverse, dal latino celare e che entrambi abbiano un’origine comune in un’antichissima radice sanscrita traducibile con “oscuro”.
Se ne deduca ciò che si può.
Dalla serie “Città nelle città”
Città dei disoccupati
Che le città siano misurabili è tanto ragionevole quanto assurdo.
Lo sa bene chi ha a che fare, dolorosamente, ogni giorno, con la vera materia di cui sono fatte. Li chiamano disoccupati, come fossero non occupati, senza alcunchè da fare. In realtà nessun tempo è occupato come quello di chi ne ha in eccesso. Li si vede aggirarsi per strade e piazze divenute all’improvviso più lunghe, ampie e spoglie. Si sentono osservati in tanto spazio libero e cercano disperatamente, per nascondervisi, gli ostacoli che gli occupati altrettanto furiosamente evitano o la finzione d’un lavoro verso il quale si avviano, ogni mattina, nella folla, con una cartella vuota sotto braccio, in una tuta da lavoro con macchie che son quelle d’ieri e dell’altro ieri.
Prima o poi tutti comprendono che il vero problema è il tempo, che apparentemente non trascorre. Solo i più avveduti hanno imparato che persino il passar del tempo è illusione se nulla accade. E nulla accade, salva la lotta corpo a corpo con l’orologio, con la renitenza delle lancette che del resto si limitano a girare in tondo senza condurre in alcun dove.
Alcuni smettono di attendere e scompaiono. Altri hanno cercato di risolvere metonimicamente il problema del tempo liberandosi degli orologi e della portatile condanna a contemplarne il vuoto. Da questo si riconoscono, dal polso libero, che nella pelle di una tonalità chiara in corrispondenza del cinturino reca ancora traccia di un passato diverso. In queste città è frequente vedere vecchi orologi appesi come strani frutti scintillanti e spesso ancora ticchettanti ai rami degli alberi, sui quali, terrorizzati, gli uccelli non si posano più.
Città degli impratici
In questa città uomini e donne non sanno usare le mani. Per la precisione, non sanno fisiologicamente utilizzarle e rifiutano ideologicamente di farlo per costruire o riparare alcunchè.
Benchè cauti nel muoversi non hanno invece difficoltà a rompere – con eleganza e impensabile fantasia – oggetti di ogni sorta. Della dissezione, della decostruzione involontaria o meno, della distruzione o dello smantellamento hanno fatto un’etichetta indiscussa.
Sono però costretti ad ingaggiare stranieri, provenienti da terre di tradizione opposta, perché costruiscano i congegni – non pochi – di cui la loro civiltà ha bisogno.
È noto che considerino questi costruttori non più che utili barbari e sé stessi, beneficiari dell’altrui talento, incarnazioni di un’irraggiungibile nobiltà.
Delicati, rarefatti, fragili e pallidi come carta velina, esigono dai costruttori opere solide e durevoli, quasi eterne per le quali sono disposti a pagare cifre altissime, per gli artigiani, non per loro che, misteriosamente prosperano nella disutilità.
Che, venerando la fragilità, pretendano tanta robustezza è ovvio e le ragioni non mancano.
La funzionalità della macchina è quella di minore importanza. Ciò che conta è la durata e la complessità della costruzione, binomio non facile da ottenere.
Dalla complessità si attendono una sfida all’altezza della loro inclinazione. Dalla durata la certezza che non avranno a lungo a che fare con quegli ottusi creatori, incapaci di comprendere che, se ideare e costruire è attività brutale contaminata dal nulla che la precede, usare, abusare e dissolvere quei manufatti, riconducendoli al nulla da cui vengono, è espressione di altissima consapevolezza e superiore disincanto.
Città e nuvole
Per cause meteorologiche vanamente indagate le nuvole, a queste latitudini, viaggiano in greggi radi e molto bassi, ad altezza d’albero. Si direbbe che cerchino nutrimento o svago tra i rami fra cui pascolano errabonde e distratte. Tanta è la disinvoltura che spesso vi rimangono impigliate e debbono attendere il vento e la ferita dello strappo per liberarsene. Non si fanno invece farsi illusioni sulla solidarietà dei locali che amano perdutamente lo spettacolo di quel candore nella non sempre rada prigione degli alberi, soprattutto d’inverno, quando i rami sono spogli e disegnano sul bianco immacolato trame irregolari e nette, interi sistemi venosi, ideogrammi che gli immancabili mistici si ostinano a voler decifrare prima che il vento cancelli tutto.
C’è sempre stato qualche temerario che, a dispetto della proibizione, ha osato avventurarsi fra quei rami e immergersi nell’impalpabile, vibrante cotone della nuvola prigioniera. Le cronache recenti smentiscono remote leggende di sparizioni. Chi era salito è sempre sceso, ma senza memoria, candido come alla nascita. Inutile chiedergli di raccontare l’esperienza. Non offre in genere che un sorriso vago.
Quando la nuvola riesce a liberarsi, grazie ad un colpo di vento che spesso la lacera, l’albero freme, la luce – se ce n’è – avvolge tronco e rami, ma la memoria non torna a chi ha avuto in dono di potersene disfare.
Città che non c’è
Il lotto di terreno, immenso, è vuoto. Uomini – minuscole silhouette viste da lontano, dalle colline circostanti, ché oltre non è permesso avvicinarsi – misurano qualcosa.
Paletti vengono piantati e tolti in indecifrabili ripensamenti. Non una pianta, né albero né arbusto, si leva su quella tabula rasa. È comprensibile che chi inizi a scrivere pretenda un foglio bianco. Ma a parte questo ben poco accade e il sospetto è che il progetto di insediamento, ormai remoto, sia stato lasciato cadere nel nulla o dimenticato dalle autorità. Si filosofeggia alludendo con un cenno del capo sconsolato a una città che già priva di un passato ha forse perso un futuro, a suo tempo annunciato con fasto. Ha diritto un foglio bianco al ricordo, per il solo fatto d’essere stato collocato su un tavolo ed esposto all’ombra di una penna che mai l’ha toccato?
Ne rimane il nome, che a quanto pare le fu dato, un nome breve e significativo.
Qualcuno deve pur ricordarlo.
Città ventosa (o su ruote)
I padri fondatori erano inclini alla noia. La città, appena fondata, aveva tendenza all’immobilità. Tedio infinito derivò da quel panorama immutabile e non particolarmente vario che trovava sollievo solo nella peculiare ventosità di quella zona di mondo, pressochè disabitata.
La soluzione fu semplice: anziché attendere da spettatori che il vento animasse il cielo, spettacolo sublime ma alla lunga ripetitivo, si decise di sfruttare l’ottusa costanza di quello stesso vento per far cambiare aria alla città. Spianato il terreno per miglia e miglia, si munirono gli edifici, rigorosamente in legno e alluminio, leggeri e durevoli, di ruote robuste e di grandi velami, di dimensioni proporzionate alla massa da spostare, così garantendo una velocità uniforme. Li si attrezzò anche con profondi balconi retrattili e ricreativi. La raffinatezza dei calcoli svolti da quegli insigni velisti consentì di assicurare non solo il controllo sulla velocità di crociera, ma persino l’invariabilità, durante la marcia, delle reciproche distanze fra un gran numero di edifici, a tal punto che vie e piazze, aeree anziché d’asfalto, mantennero nel tempo e in movimento, ubicazione e dimensioni. La vita dei suoi abitanti fu varia e felice per alcuni anni. Generazioni di uccelli videro quel che doveva apparire da lassù, oltre il velo di polvere, come un gran branco pascolante di strani colossi geometrici dalle immense orecchie bianche.
La città si estinse all’improvviso. Nell’entusiasmo tipico dei pionieri e confidando nell’infinitezza della superficie i progettisti non avevano congegnato un sistema di frenatura efficiente. La terra, assai meno entusiasta, si era invece astenuta dal prevedere un rimedio alla sua improvvisa interruzione in coincidenza con un lunghissimo tratto di falesia.
La città angosciata (Mardin)
La piccola città è l’attesa fatta pietra. Il suo merletto di calcare, dal versante di un’alta collina, isolata al centro di un altipiano, domina una vasta, pallida pianura, e ne è dominato. Sulla sua sommità un vecchio castello e una bandiera percossa dal vento, che nessuno guarda.
L’ambiguità che connota il suo rapporto con l’infinita distesa gialla, sempre velata da un sudario che pare nascondere pudicamente gli orrori che vi si consumano, si riflette sulle attitudini dei suoi abitanti. Hanno origini diverse, diverse sono le tradizioni che, a turno, celebrano o nascondono. Il sangue delle vittime di antichi massacri si è insinuato nelle vene dei carnefici e nessuno sa più chi è. Osservano la pianura ritagliata in bizzarri quadrangoli, un tempo campi, abbandonati per paura, in attesa di qualcosa o qualcuno che finalmente suggerisca loro se piangere gli antenati o temere i discendenti delle vittime e il giudizio del mondo.
La montagna alle loro spalle li rende ciechi al passato, l’infinitezza della pianura al futuro. Attendono e, poiché l’attesa rende tutto possibile, vivono nel timore.
Città onda
È forse l’unica città di un paese che la contiene e ne è contenuto, poiché, come spesso accade, i suoi abitanti, in fuga da miserie e pericoli, hanno iniziato a cercarvi rifugio, disertando i confini, le pianure ossute e i solchi infertili dei campi.
Attorno a questa città, enfiata disordinatamente, sono scomparsi i segni dell’uomo e la terra che la circonda, svuotata, è tornata ad essere deserto o foresta. Al suo interno i nuovi arrivati, mal digeriti hanno in un primo tempo colmato i pochi spazi disponibili.
Successivamente, fuggendo la densità eccessiva, vecchi o nuovi residenti hanno cercato respiro ai margini, violando l’antico pomerio e spingendo sempre più oltre i limiti dell’abitato fino a bonificare le terre poco prima tornate ad essere deserti o foreste.
Molti prevedono, alcuni negano e i vecchi sanno che presto o tardi i nuovi quartieri e l’immemore illusione di novità e pienezza che hanno generato appassiranno per la lontananza dal centro, la lentezza nell’arrivare ai bordi di notizie e decisioni e, in ultimo, l’interruzione di quella sorta di cinghia di trasmissione che fa di corpi diversi un corpo.
Allora e solo allora si rinnoveranno l’abbandono, l’inurbamento e la fuga dalla densità che soffoca. Tutto ricomincerà da capo.
Qui si sa che la vita è un dipinto – lo stesso dipinto – senza posa cancellato e ribadito.
Non si coltivano illusioni circa la spazio sacro della città, il suo rango o i privilegi di chi la abita. La città è un’onda che arriva e si ritrae lasciando dietro di sé un paesaggio di rovine o cantieri, termini, questi ultimi, che sul dizionario locale sono indicati come sinonimi.
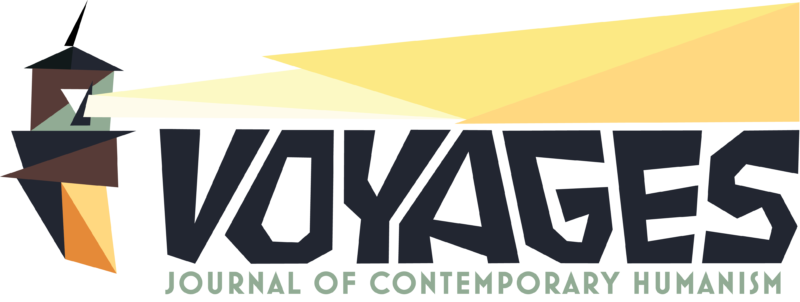

You must be logged in to post a comment.