
Photo Credit: Alessandra Capodacqua
Drrrrrrr…Drrrrrrr…Drrrrrrr… Lo smartphone vibrava derapando sul piano della scrivania come un insetto ferito. Per un attimo fui indeciso se schiacciarlo con un pietoso pugno sulla corazza nera di silicone o lasciarlo agonizzare fino all’ultimo ronzio che non avrebbe tardato ad arrivare. Avrei dovuto spegnerlo del tutto invece di concedergli la possibilità di interrompere un momento così prezioso di entusiasmo come non me ne capitavano da mesi. Avevo finalmente messo il punto finale ad un racconto che mi sembrava quanto di meglio avessi scritto negli ultimi cinque anni di faticosi, quanto vani tentativi di ritrovare l’antica ispirazione. Avevo avuto anche qualche buona idea durante questi cinque anni, ma quasi nessuna aveva avuto quella carica intrinseca per valicare il confine dell’abbozzo e diventare uno valido scritto compiuto. Le poche, pochissime cose che avevo portato a termine e pubblicato avevano avuto scarsissima fortuna, anzi, per essere completamente sinceri, avevano compromesso quella dignitosa, seppur modesta, posizione nel panorama letterario nazionale che avevo faticosamente raggiunto con i miei primi due romanzi.
Drrrrrrr…Drrrrrrr… Guardai lo schermo, era una chiamata di F., il mio agente. Risposi. Mi invitavano a presiedere la giuria di un concorso letterario di provincia. Non era una di quelle esperienze da mettere in evidenza sul curriculum, ammise, ma avrebbe potuto darmi qualche visibilità sui quotidiani locali ed era previsto anche un gettone di cinquecento euro, «e, con i tempi che corrono, meglio non rifiutare nulla», aggiunse. Aveva già concordato con l’organizzazione e con la mia casa editrice la possibilità di allestire un banchetto per vendere qualche copia del mio secondo romanzo “Amelete”, concluse.
Per non ferire il mio orgoglio suppongo, omise di dire che ero stato scelto per sostituire Gianni C., il quale aveva dato forfait all’ultimo. I tempi così stretti (la premiazione era prevista di lì a otto giorni) avrebbero dovuto insospettirmi, ma ero troppo preso dal mio entusiasmo in quel momento per speculare su dettagli del genere. Seppi solo in seguito dallo stesso Gianni C. che aveva rifiutato perché riteneva offensivo quel compenso da fame.
In ogni caso, credo che F. si aspettasse sulle prime un deciso rifiuto, o quantomeno un’orgogliosa riluttanza, da vincere dapprima a colpi di pazienti esortazioni e poi, in caso di insuccesso, con argomenti dolorosi per il mio già ridimensionato ego. Percepii infatti chiaramente la sua sorpresa quando dissi senza esitare un solo istante che accettavo l’invito, pregandolo di occuparsi di tutto e mettermi al corrente a cose fatte. Desideravo solo porre fine a quella telefonata e tornare alla mia euforia, e sapevo che un’obiezione o un rifiuto l’avrebbero resa interminabile.
Aspettavo che rispondesse qualcosa e intanto guardavo con un bizzarro senso di nostalgia la prima pagina del racconto che avevo appena concluso, come se quella telefonata potesse frapporre tra noi una distanza incolmabile. Lo avevo scritto a macchina: una Olympia Carrera de Luxe, eredità di mio padre. Il computer, che avevo sempre osannato come il fattore decisivo della mia produttività, si era trasformato da qualche anno in una costante fonte di distrazione e gli imputavo la mia scarsa vena creativa. Così avevo lasciato il computer a casa di mia madre e avevo disattivato i dati sullo smartphone in modo da usarlo solo per le chiamate.
«Stai scrivendo?», mi chiese infine F. rompendo il suo interdetto silenzio.
Riagganciai senza rispondere e provai a rituffarmi nel mio entusiasmo, ma l’incanto era irrimediabilmente svanito, come quei piacevoli sogni interrotti che si prova a riannodare senza successo. F. con la sua telefonata mi aveva messo di malumore e mi dissi che potevo provare ad allontanarlo pensando a cosa avrei fatto di quel racconto. Continuai a fissare quei caratteri che agli inizi del secolo scorso avevano rappresentato un fulgido esempio del progresso tecnico, e che ora, paragonati ai nitidi caratteri degli schermi, apparivano artigianali, tanto che perfino quelle lettere che occupavano la stessa posizione nella sequenza dell’alfabeto e dei martelletti lasciavano impronte mai perfettamente uguali quando incontravano la porosità della carta.
Guardavo le undici lettere del titolo e pensavo che forse si poteva provare a pubblicarlo su qualche rivista, magari sotto pseudonimo. Temevo che, visti gli insuccessi delle mie ultime pubblicazioni, il mio vero nome avrebbe procurato pregiudizio al racconto, a cui non potevo certo imputare i miei precedenti fallimenti.
Caro lettore, so bene che prima ancora di iniziare a leggere l’incipit di questo racconto ti sei installato per consuetudine (forse anche con piacevole curiosità) nel tuo ruolo e, obbedendo al patto tra scrittore e lettore, hai sospeso l’esercizio del dubbio. So che trovi del tutto naturale in questo caso identificare nella stessa persona narratore e protagonista (che sarei io). L’espediente del racconto in prima persona è notoriamente funzionale a questo antico e comunemente accettato inganno.
Tuttavia, per rispetto della verità dei fatti che qui si raccontano, sento l’obbligo di metterti in guardia e ti consiglio di diffidare, almeno in questo caso, dell’autorità onnisciente che suoli accordare ai narratori e considerare la possibilità che i fatti non siano esattamente andati come qui si pretende descrivere. Farò il possibile, nei limiti della mia ristretta autonomia, per aiutarti in questo compito. Quest’ultima scusa approntata per giustificare la ricerca di uno pseudonimo, ad esempio, è una balla bella e buona. In realtà la preoccupazione di questo cerretano (chiamarlo autore, è un onore che non merita) era esclusivamente rivolta alla sua reputazione.
Continua pure a leggere se vuoi, ma ti consiglio di non smettere mai di dubitare di questo impostore…
La chiamata di F. a proposito del concorso letterario mi aveva fatto tornare alla mente Romain Gary (alias Roman Kacew), un vero affezionato dello pseudonyme; l’unico scrittore a vincere due volte il premio Goncourt, proprio grazie all’artificio dello pseudonimo: una prima volta con il suo nom de plume ufficiale e una seconda con quello di Émil Ajar. Pensai che lo pseudonimo era un espediente eminentemente letterario. Cercai tra i miei ricordi sbiaditi di storia dell’arte se vi era stato qualche artista che aveva usato uno pseudonimo. Non me ne venne in mente nessuno; di soprannomi ve n’erano a bizzeffe, e a volte erano stati usati dagli stessi artisti per firmarsi, ma nessuno di essi, a quanto mi era dato ricordare, era mai stato impiegato per camuffare un’identità. Al contrario, tutti fornivano in qualche misura un dato biografico in più, un attributo dell’identità, di cui il nome in sé difettava. Iniziai a scriverne alcuni sul taccuino, senza un ordine preciso, seguiti dai nomi e dal motivo del loro soprannome:
Caravaggio = Michelangelo Merisi (luogo di provenienza)
Parmigianino = Francesco Maria Mazzola (luogo di provenienza)
Tintoretto = Jacopo Robusti (mestiere del padre)
Correggio = Antonio Allegri (luogo di provenienza)
Sodoma = Giovanni Antonio Bazzi (tendenze sessuali, almeno stando al Vasari)
Pontormo = Jacopo Carucci (luogo di provenienza)
Guercino = Giovanni Francesco (o era Giovanni Maria?) Barbieri (difetto fisico)
Andrea del Sarto = Andrea (? Non ricordo il cognome – Mestiere del padre).
Poi ricordai che Churchill adottò come nom de palette per la sua prima esposizione pubblica il nome di un pittore realmente esistito, Charles Morin, morto qualche anno prima. Churchill era probabilmente preoccupato che la sua attività di pittore potesse arrecare pregiudizio alla sua carriera diplomatica, o chissà, forse viceversa.
Era l’unico pseudonimo che ricordai nel campo delle arti visive. Lo aggiunsi alla lista.
Ero deciso a trovare uno pseudonimo, ne ero convinto: era il primo necessario passo per tentare di pubblicare il racconto.
Scartai subito l’ipotesi dell’anagramma, mi pareva un espediente superficiale e vacuo.
Scartai anche la possibilità di creare un vero e proprio eteronimo alla Pessoa: troppo impegnativo. L’ipotesi di usare il nome di un autore realmente esistito, come aveva fatto Churchill per il suo nom de palette, mi pareva addirittura nefasto.
Anche in questo caso ho un paio di cose da dire, caro lettore. D., amica di vecchia data e storica dell’arte, ci disse che vi erano stati casi di pseudonimia nelle arti visive. Ad esempio alcune espressioniste astratte avevano usato nomi maschili, nel tentativo di aggirare i pregiudizi di un mercato dell’arte dominato dagli uomini e da un atavico maschilismo. Ma ovviamente il nostro imbonitore ha preferito omettere questo dettaglio perché non funzionale alla narrazione. Altra cosa: avevamo deciso di comune accordo di usare uno pseudonimo, sebbene per ragioni diverse. Io, in veste di protagonista, facevo il mio ingresso ufficiale nella letteratura e chiamarmi con lo stesso nome del mio autore mi pareva davvero poco adatto a un debutto che immaginavo glorioso. Lui cercava un paravento dietro cui nascondersi dopo la triste sequenza di insuccessi, ma che non fosse troppo difficile girarci intorno e risalire alla sua vera identità, nel caso il racconto avesse ottenuto il successo che secondo noi (grazie al mio contributo su questo potevo concordare) meritava.
L’idea di un nome che facesse riferimento al mestiere di mio padre, come per Andrea del Sarto e Tintoretto, mi sembrava ottima. Avevo dichiarato più volte pubblicamente che Michele, il protagonista del mio romanzo di maggior successo, era ispirato alla figura di mio padre, agente segreto appartenente al nucleo informativo dell’organizzazione Gladio. Eureka: infilai il primo foglio nella macchina per scrivere e dattilografai in calce: Michele Gladio.
La chiamata di F. arrivò una sera mentre prendevo un aperitivo con alcuni amici in un bar ristorante del centro. Per il mio ruolo di presidente del concorso letterario era tutto confermato, mi assicurò. Il gettone di cinquecento euro sarebbe stato versato direttamente sul mio conto entro trenta giorni dalla proclamazione del vincitore. L’organizzazione mi avrebbe fatto pervenire il biglietto del treno nei prossimi giorni e sarei stato ospitato in un albergo a 4 stelle con vista mare. Fui meno contento di sapere che non era previsto nessun contributo per il vitto, eccezion fatta per un buffet che sarebbe stato offerto la sera della proclamazione del vincitore dalla compagnia di catering che sponsorizzava il concorso.
«La buona notizia è che non dovrai leggere tutti i racconti partecipanti», aggiunse per smorzare la mia delusione riguardo al vitto. Una giuria mista di lettori ed esperti avrebbe selezionato tre racconti finalisti e tra questi proclamato il vincitore. A me, in quanto presidente della giuria, restava solo il compito di leggerne davanti al pubblico il fortunato racconto e poi consegnargli il premio (un assegno di mille euro e un prosciutto di Parma). Insomma, i cinquecento euro erano una remunerazione più che generosa, visto l’esiguo sforzo richiesto, e avevo solo da scongiurare il pericolo di un ex-equo, aggiunse F. col suo consueto e irritante risolino.
Mi guardavo nel grande specchio collocato sulla parete accanto al nostro tavolo, che recava sovraimpressa la scritta “OSBORNE – Pedro Ximenez – 1827”: la mano destra teneva lo smartphone all’orecchio, mentre la sinistra faceva ruotare il calice di vino bianco, la fronte corrugata. Mi tornò alla memoria una frase di Antonio Machado “No hay nadie tan atado a su propia cara que no albergue la esperanza de presentarle otra al mundo.” Salutai F. e riagganciai.
L’aperitivo si era trasformato in una lunga cena tra i soliti sterili mugugni sulla situazione politico-sociale del paese e numerosi bicchieri di vino. Volli parlare ai miei due amici del racconto e dell’idea di aggiungere in epigrafe la frase di Machado che continuava a ronzarmi nella testa tra i fumi dell’alcol: “No hay nadie tan atado a su propia cara que no albergue la esperanza de presentarle otra al mundo”. R. parve particolarmente entusiasta sia del racconto in sé sia dell’idea dell’epigrafe e a fine serata si offrì di chiamare un taxi per accompagnarmi a casa, dato che ero visibilmente il più alticcio dei tre. Da quel momento in poi i miei ricordi sono vaghi, solo pochi nebulosi residui intervallati da lunghi vuoti.
Protesto ancora: non ero affatto alticcio, non avevo bevuto neanche un goccio d’alcol, anzi non avevo partecipato a nessun aperitivo; tantomeno avevo cenato con amici quella sera. Lascio a te, lettore, decidere se attribuire questa ennesima menzogna ad un artificio narrativo per conferire mistero a quella altrimenti noiosissima serata o un ingenuo diversivo per farti credere che ciò che accadde quella sera e il giorno seguente fu dovuto a un momento di sospensione della (nostra) coscienza. La frase di Machado in realtà l’avevo letta, comodamente sdraiato sul divano in un libro di aforismi.
Non ricordo ad esempio nulla del tragitto in taxi al punto che non posso neanche affermare con certezza se accettai la gentile offerta di R.
Ricordo invece ad esempio che arrivato a casa (ero solo?) dovetti sedere sulla soglia per alcuni minuti per recuperare un minimo di lucidità prima di riuscire ad affrontare la serratura della porta, che prese a schivare i colpi di chiave con una destrezza sorprendente. Ricordo anche che quando finalmente riuscii a varcare la soglia e feci per premere l’interruttore della luce d’ingresso, realizzai che era già accesa. Non vi posi speciale attenzione, in parte a causa delle mie ridotte facoltà razionali e un po’ perché mi era capitato altre volte di lasciarla accesa.
Non ricordo ovviamente di aver congedato R., semmai davvero mi accompagnò. Ricordo che a un certo punto mi trovai davanti alla scrivania (quanto tempo era passato dal mio ingresso nell’appartamento?) e ricordo la mia enorme sorpresa nel constatare che il racconto era sparito. Ricordo anche che fui preso dal panico e cominciai a frugare nei cassetti e tra gli scaffali; forse E., la signora delle pulizie, aveva voluto fare ordine, nonostante le avessi intimato sin dal primo giorno di non toccare nulla sulla scrivania. Guardai anche nel cestino della carta nel caso a E. fosse venuta la malaugurata idea che si trattasse di fogli da gettare: niente, nada, nichts, delle preziose pagine nessuna traccia. Confesso che pensai anche che le avesse rubate E., d’altronde era la sola ad avere le chiavi del mio appartamento e sapevo che lavorava anche per altri scrittori. Un furto su commissione non era poi un’ipotesi del tutto strampalata. Credo che ebbi un mancamento o forse mi arresi alla sbornia, fatto sta che persi conoscenza e quando mi svegliai, il mattino seguente, verso le undici, ero sul letto, vestito, e con ancora le scarpe ai piedi. Mi ci volle qualche istante per recuperare il ricordo e l’inquietudine per la sparizione del dattiloscritto, quindi mi alzai di scatto per andare alla scrivania e fui quasi sul punto di cadere tanto mi girava la testa. Finalmente a piccoli passi aggirai la parete del corridoio, scorsi il piano della scrivania e, sorpresa delle sorprese: il racconto era di nuovo lì, nella stessa identica posizione dove l’avevo lasciato il giorno prima. Se quella sparizione fu un’allucinazione dovuta agli effetti dell’alcol o la visione di un brutto sogno non seppi dire, in ogni caso mi convinsi che il racconto non si era mai mosso di lì. Andai a sciacquarmi la faccia, poi mi preparai una tazza di caffè con la quale tornai alla scrivania. Ero ancora intenzionato ad aggiungere la frase di Machado in epigrafe. Voltai il frontespizio e considerai nuovamente la possibilità che una sparizione, seppure momentanea, si era effettivamente verificata quando vidi sulla pagina, fissato con una graffetta, un bigliettino con la seguente nota: “Non esiste nessuno così affezionato al suo volto che non accarezzi l’idea di presentarne un altro al mondo”.
Era proprio la frase di Machado, tradotta in italiano e scritta a matita, con una grafia che non era la mia.
Caro lettore, se sei arrivato a leggere fin qui, sarai convinto anche tu a questo punto che questo maldestro cagliostro, usurpatore seriale d’identità è un frequentatore assiduo della menzogna. Che goffo tentativo di gettare fumo negli occhi! Si aspetta che ora tu ti chieda: Il racconto è stato davvero sottratto? Da chi? E chi ha scritto la nota e perché? Non mi è concesso svelare tutti questi sciocchi misteri né contraddire tutte le menzogne qui narrate, ma mi prendo la licenza di affermare, e spero tu voglia credermi, che in nessun momento ho sospettato della donna delle pulizie, ne mai ho avuto bisogno di una simile vigliaccata, semplicemente perché sapevo benissimo quello che era successo.
Anche se l’idea di apporre quella frase era farina del mio sacco, non potevo accettare che qualcun altro si fosse preso la libertà di aggiungerla senza il mio espresso consenso. Decisi quindi che avrei rinunciato all’epigrafe. Tolsi il bigliettino, lo strappai e lo gettai nel cestino, senza riuscire a rimuovere però il senso d’inquietudine che mi si era installato nella schiena per la comparsa misteriosa di quella nota. Poi presi a fotografare con lo smartphone tutte le pagine. Volevo assicurarmi di avere una copia del racconto. Non appena possibile, con più calma, sarei passato da mia madre per digitalizzare il testo sul computer.
Dovevo chiamare R., dovevo sapere cosa era successo la sera prima dopo il ristorante.
Dovetti prima vincere l’imbarazzo e prepararmi a fare domande come “ieri mi hai accompagnato tu a casa?”, “sei stato tu a mettermi a letto?” e soprattutto “Sei stato tu ad aggiungere il bigliettino con la nota?”. Avviai la chiamata: “il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile”. Capitava spesso con R., lui era uno di quelli che spengono sempre il telefono quando si mettono a scrivere. Invidiavo la sua disciplina.
Menzogna: nel nostro gruppo di amici, R. veniva chiamato “il quacchero”, giacché il suo rigore non si manifestava solo nella disciplina quotidiana ma anche in un tedioso conformismo morale. Prova, caro lettore, a indovinare chi fu ad affibbiargli questo nomignolo! Non mi vergogno di dire qui che ho sempre trovato la sua prosa una coerente emanazione del suo ordinario rigorismo.
Chiamai F. per parlargli del racconto e dell’intenzione di pubblicarlo sotto pseudonimo. F. mi chiese di mandarglielo: se era davvero valido come credevo, forse c’era la possibilità di farlo pubblicare. F. aveva sempre un modo particolarmente irritante di dire le cose. Infilai il racconto in una busta, mi recai da F. in autobus e gli lasciai il plico nella cassetta delle lettere. F. mi chiamò il giorno dopo: «Hey, Michele Gladio, cos’è, ci vergogniamo del proprio nome adesso?». Sapevo che non avrebbe perso l’occasione per fare del grossolano sarcasmo. «In ogni caso» aggiunse «davvero niente male. L’ho già fatto avere a G.B., spero non ti dispiaccia». G.B., il direttore editoriale della più importante rivista letteraria del paese, come poteva dispiacermi! «Avresti almeno potuto avvertirmi, è l’unica copia che ho» protestai, cercando di nascondere la soddisfazione. «Tranquillo, lo sospettavo, non avevi mai scritto a macchina prima. Gliel’ho spedito via fax, l’originale ce l’ho io…Sai, G.B. è uno di quelli che trova chic continuare ad usare mezzi antidiluviani: ricevere via fax un racconto scritto a macchina è già un primo passo per conquistarlo». A volte la sua ironia era involontaria ed era doppiamente molesta.
«A proposito, sei pronto per distribuire e ricevere gloria domani?», mi chiese infine.
«Certo, ho passato il fine di settimana a intrecciare corone d’alloro», risposi.
Rise sguaiatamente. Ogni tanto provavo a usare la sua stessa scadente ironia nella speranza, sempre frustrata, che sentendola da una bocca altrui, si accorgesse di quanto era mediocre.
Il giorno dopo ero in treno per T. Il giovane nigeriano che condivideva con me lo scompartimento passò l’intero viaggio a “chattare” con una connazionale con brevi messaggi audio. La conversazione era sincrona e serrata: non capivo perché non comunicassero attraverso una normale chiamata. Forse era una conversazione amorosa pensai, anche se dal tono era difficile stabilirlo, e volevano ciascuno avere la possibilità di riascoltare i frammenti registrati dalla voce amata. Uscii dallo scompartimento e provai a chiamare nuovamente R., ma ancora una volta non ebbi risposta.
Arrivai in albergo nel pomeriggio e provai nuovamente, ma senza successo. Ero stanco morto, mangiai una pizza sul lungomare e tornai in albergo. Alle 21:30. ero già a letto.
Il mattino seguente lo passai a camminare sulla spiaggia. Nel pomeriggio raggiunsi la sede del comune a piedi. La sala della premiazione era rettangolare, con sedie di plastica e metallo disposte in file ordinate. In fondo, frettolosamente chiusi a fisarmonica, stavano alcuni pannelli neri, i quali costituivano con ogni probabilità l’elemento che per il personale del comune era sufficiente a giustificare l’altisonante qualificazione di “multifunzionale”, di cui la sala si fregiava con dissimulato orgoglio e caratteri bianchi su etichetta nera di plexiglass affissa all’ingresso. Davanti ai pannelli la tavola riccamente imbandita del buffet. Dal lato opposto due desuete cattedre scolastiche accostate formavano un lungo tavolo sul quale erano disposti da un lato ottanta copie del mio romanzo “Amelete” – numero che giudicai oltremodo ambizioso considerando l’esigua platea (non più di trenta persone), e dall’altro i plichi contenenti i racconti partecipanti disposti in cinque pile. Una delle pile era costituita da tre sole buste. Mi fu spiegato che i tre finalisti erano già stati selezionati e si sarebbe adesso proceduto alla proclamazione del vincitore per votazione dei giurati. In un angolo su un piccolo tavolino, accanto ad alcuni depliant pubblicitari e una piccola busta chiusa era appoggiato il prosciutto. Sul muro dietro al tavolo della giuria, un monitor acceso mostrava una schermata con in alto il logo della compagnia di catering che sponsorizzava il concorso sormontato da un festone formato dalle più disparate vettovaglie: salami, patè, barattoli di conserve, frutta secca. Il resto della schermata era stato lasciato volutamente vuoto per accogliere, come mi fu spiegato dalla procace e zelante M., il nome del vincitore, Il titolo del racconto e i voti ricevuti.
Ci sedemmo, tutti tranne M. che fece una enfatica presentazione, utile soprattutto a ringraziare per la sua preziosa collaborazione la ditta “Fratelli C. – Prodotti Alimentari Freschi e Surgelati” di cui avremmo potuto gustare le delizie in fondo alla sala, a fine premiazione.
Poi M. venne a prendere posto alla mia destra e si procedette alla votazione. Oltre al sottoscritto la giuria era composta dalla stessa M. e un altro funzionario del comune, la direttrice marketing della ditta “Fratelli C.”, il direttore e il responsabile culturale del quotidiano locale e la direttrice del liceo classico cittadino. Avevano a disposizione un unico tablet che si passarono, sul quale selezionavano il nome del racconto finalista preferito. Io guardavo il pubblico presente, mi divertiva la loro eccitazione. Pensai che quelli che apparivano più tesi dovevano essere gli autori partecipanti. Gli altri erano con ogni probabilità familiari e amici. Tutti gli occhi erano puntati sul monitor alle nostre spalle. Quando la direttrice marketing – l’ultima a dare il suo voto – restituì il tablet a M., partì un applauso: il vincitore era stato proclamato. Non ebbi la curiosità di guardare il display, mi divertiva molto di più osservare la reazione del pubblico. Presero tutti a guardarsi intorno, cercando tra le facce che mal celavano la delusione, il fortunato autore.
Poi M. mi passò il plico con il racconto vincitore, accompagnandolo con un compiacente sorriso.
Aprii la busta e ne estrassi il contenuto provando a conferire una qualche solennità al gesto. Il testo in Times New Roman, aveva tutta l’aria di rispettare i requisiti d’impaginazione definiti nel bando di concorso, la cui tediosa lettura mi fu fortunatamente risparmiata. Inforcai gli occhiali, mi schiarii la voce e iniziai a leggere:
“Drrrrrrr…Drrrrrrr…Drrrrrrr… Lo smartphone vibrava derapando sul piano della scrivania come un insetto ferito. Per un attimo fui indeciso se schiacciarlo con un pietoso pugno sulla corazza nera di silicone o lasciarlo agonizzare fino all’ultimo ronzio che non avrebbe tardato ad arrivare…”
Michele Gladio
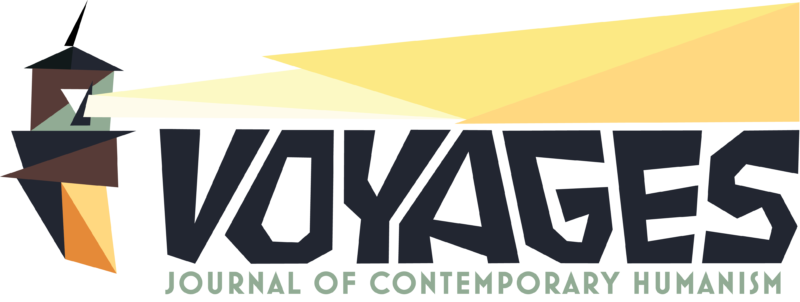

You must be logged in to post a comment.