
Photo credit: Alessandra Capodacqua
Il corpo per cui scrivo
è singolare & plurale, vuole guardare una balena per ore
senza ragione, lucida misteriosa neroblu s’alza
e ricade, ascolta il suo corno eterno e solitario
ammaliante archivio d’oceano.
la liscia pelle bronzea di lagerstroemia
mezza morta dopo il primo vento, adesso sboccia,
lanterne coniche di rosa increspato o petali bianchi
che pendono da corna di corteccia, radicate nei pressi
starace, corniolo e mimosa a volontà
un paese di micelio.
il corpo è figlia e madre, amante e amante,
onda e particella, binario e treno che sfreccia vola attorno alla curva col suo occhio di morte,
lungo gemito e grammatica della perdita. parla all’anna di tolstoi:
non buttarti grida dentro la storia: ama te stessa più del dominato
desiderio per un uomo, sii fiera di aver spezzato la schiena al cavallo sotto di lui.
il corpo bambino viaggiò in treno. a babilonia le ruote scrissero. lei cavalcò la metafora dell’assenza.
cara cheryl, grazie per avermi chiesto di scrivere chi sia il corpo per cui scrivo.
è zuihitsu questo? cerco di adattarmi
dentro il nome di qualcosa
sto imparando a scrivere per i corpi decimati offerti più e più volte da coinquilini felini.
coscia di ratto, zampa di coniglio, topolino trafitto, sapendo che è la lealtà che porta queste parti del corpo.
ancora combatto la schifiltosità e le limitazioni di una mente gentrificata, biforcuta.
cos’è il corpo, quello che scrive o quello per cui o a cui si scrive e, comunque, ha importanza?
il corpo è indebitato a generazioni di corpi i cui nomi non ho imparato, abbracciando una
moltitudine di lingue e luoghi,
spesso timoroso di lasciare la casa.
il corpo scrivente sa che deve scrivere il corpo in modo più onesto. il bianco in cui vive non è un colore vero ma il suo peso è innegabile e se non interrotto continuerà a uccidere.
l’imprecisione dei movimenti della luce.
l’imprecisione della bilancia.
l’imprecisione di un corpo
conoscere un altro corpo.
l’imprecisione dell’amore.
in definitiva il corpo è se stesso
che anela redenzione.
Cavalli, ancora
Una gelida mezzanotte d’aprile quando avevo dieci anni
il contadino della mia vita mi ha svegliato in vestaglina
di flanella e piedi assonnati, per andare a passo felpato lungo
il sentiero fangoso, la cavalla bianca ansimante sulla paglia
gialla. È la storia che racconto sempre;
ne abbiamo tutti una. Chi è stata partorita
quella notte è diventata la mia zoccoluta compagna,
ha calmato il mio cuore ferrovia lacerato fra
località e genitori – ragazza ebrea con
la treccia e una cavalla araba dalla coda alta
e guizzante non erano fatti per stare insieme o saltare
le siepi così siamo scivolati nella nostra grammatica
animale finché sono partita per crescere – sussurro
equino non abbastanza forte per provare il mio valore.
Oggi rifiuto i finimenti, il morso d’acciaio – il cancello si apre
Chiedo scusa alle parti del corpo
Mi dispiace care cosce per avervi dato problemi,
lo so che fate solo il vostro lavoro, non
tenendo conto della taglia. Perché dovrei trascinarvi in basso
quando voi, due stabili carrelli, mi trasportate?
Stomaco, oh cuore tenero in mezzo
al tronco, ti ho fatto grande torto –
scure macinature di caffè a tutte le ore, l’ansia
che rigira e contorce nel punto in cui dovrebbe prosperare il respiro.
Polsi, forti barche alberate, vi flettete, sorreggete,
ancorate queste mani come bobine. Ho ignorato
il vostro aggetto, la vostra fattura, fulcro del
lavoro, stazione per il braccio, con ornamenti inadeguati?
Sbuffi intorno alla bocca, vi ho fatto un torto,
sopravvissuti a generazioni di sorrisi, vi siete
stirate con l’infelicità, uscendo da rughe tremule –
perdonate, vi prego, la mia vanità, volendo non vedervi più.
Lingua, ho cercato di nasconderti, ti ho creduta
orrenda, senza capire che quei minuscoli follicoli
sono armatura, tentacoli che avvertono il pericolo, la tua
peluria. Adesso, fieramente leonina, ti porto nel mondo.
Polmoni, ho imparato che albergate dolore;
Mi scuso per quello che ho causato o non ho
causato, un carico pesante in questi ultimi anni –
ora offro la tenerezza dell’aria.
Cara fronte, spelata, lucidata e
compressa, quando tutto ciò che hai sempre voluto
era una curva, una trasmissione, una visione aperta.
Oggi prometto la grazia della grinza.
Braccia, mie ali, mie amiche, mie compagne
di viaggio, penso che ci capiamo —
portate secchi d’acqua, volantini e
figlie, mia culla, mie ambasciatrici.
Ok, cuore, per te sprofonderò nel cliché –
mi dispiace correre quando dovrei ascoltare,
mi dispiace per le amnesie e per ignorare i consulti;
grazie per aver sopravvissuto ai tuoi nemici.
Per le grinze e per gli innocui puntini rossi
che crescono come volontari nel mio campo, per il non
ammirato, il nascosto, le pieghe che la mia modestia
sceglie di proteggere, cercherò di amarti.
Caffè
| Olio scuro strofinato
a mano: condivido la mia dipendenza con gli amati defunti. Il mio chicco di caffè m’incontra in un favorito ampio recipiente – annunciando dove sono stata o dove spero di andare: Buffalo, Bolivia, Kenya. Quando mio padre mi ha versato la prima tazza avevo otto anni, nello sguardo un luccichio di sfida per Mrs. Renkins, la maestra che sosteneva che mi avrebbe ostacolato la crescita. Ha vergato una poesia sulla caffeina nei suoi ultimi anni, mi ha spedito una copia della Cantata al caffè di Bach. Balzac ne è morto: un diluvio di sanguigno inchiostro mogano irrompe – dalla vena alla pagina. Sogno un’Antologia del Caffè – non filtrata, muschiata. Mahmoud Darwish ha misurato i suoi con esattezza ogni mattina |
a Beirut, nel 1982,
con le bombe che esplodevano, amata fumante tazza di densa nerezza. Nella cucina di Grace sull’undicesima strada donne dai capelli lunghi pianificavano sit-in, pace, e PTA, matite e giornali si accumulavano, una desueta pausa caffè a New York. D dell’isola di Grenada va a tostare il suo nella città vicina. B di Shinnecock Nation chiama il suo intruglio fumante Caffè nativo. Mio padre trangugiava il suo dopo il pane tostato con la marmellata, e nei weekend, i pancake, noci che pestava nel mortaio e farina di mais. Niente caffettiera elettrica per lui. Macinava un chicco bello tosto, bolliva l’acqua in un bollitore, di buon’ora – vecchio accappatoio e pantofole, lunghe chiacchiere a tavola. Dov’è andato mio padre che [amava il caffè?Mia nonna, Henrietta, |
|
| assaporava il suo per ore,
tazza di porcellana e piattino, mani grandi che setacciano e stendono il suo famoso plum cake burroso – da Henry Street alla sessantatreesima, granuli della sua voce trapiantata, come zucchero, o lo Yiddish. Come il lutto. I fondi e la cenere di caffè fanno crescere il cavolo nero. La mattina, prima di spargere il compost, Jon porta la prima tazza a me, di buon’ora, nel letto. |
Ora prego
Volto cinereo, berrettino di lana che sobbalza,
gli occhi di un bambino che dardeggiano verso di me,
poi si alzano verso l’uomo che trascina un trolley
tenendo il bimbo per mano,
poi ancora verso di me. Le sue gambe si muovono
come in assenza di gravità. L’uomo chiede:
conosce una chiesa in questa strada
che serve cibo gratis? Vorrei dire
che la conosco. Che i nomi delle chiese
in un viale chiamato delle Americhe
mi sfuggono. E vorrei dire a voi
che è temporanea, la loro condizione:
valigia, occhi dardeggianti, in cerca di un pasto
gratis alle 9 di sera in una grande città in una notte di scuola.
Vorrei dirvi che non mi domando, per un momento
se quell’uomo è davvero il padre del bimbo
o piuttosto lo zio o il legittimo tutore –
qualcosa nel modo in cui lo tiene per mano
e lo guarda, avendo visto troppi
episodi di Law and Order. Vorrei
dirvi che li porto in un ristorante
e gli offro un pasto caldo o mi svuoto il portafoglio
senza pereoccuparmi di quanto
possa essere offensivo perché
in fin dei conti la fame è la fame.
Vorrei dirvi che chiamo qualcuno
che li ama – che c’è in effetti qualcuno –
dicendogli: i suoi ragazzi si sono persi, può
venire a prenderli? Vorrei dirvi che mi siedo
sul marciapiede all’angolo
della Waverly e prego – che tutte
le scarpe dei passanti anonimi
che segnano il marciapiede, si uniscano
in un coro di preghiere che ronzano
come cicale nel Delta. Vorrei
dirvi che il bambino e l’uomo mangiano
circondati dal calore di corpi.
Vorrei trasformare la notte fredda in un banchetto.
Vi dico che sto pregando.
Traduzioni di Andrea Sirotti
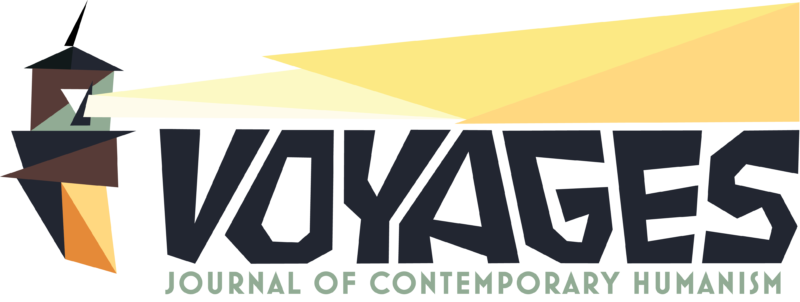

You must be logged in to post a comment.