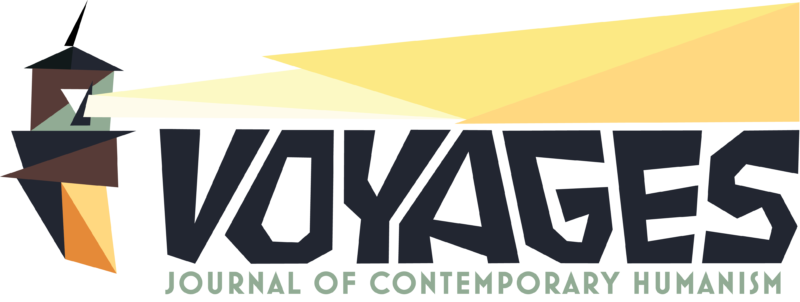Nell’estate del 1916 un gruppo di artisti discute animatamente al caffè delle Giubbe Rosse, in piazza della Repubblica a Firenze. Tra di loro Filippo Tommaso Marinetti, scrittore e giornalista, Giacomo Balla, pittore, Arnaldo Ginna, pittore e suo fratello Bruno Corra (romanziere; in realtà il cognome dei due era Ginanni Corradini), Lucio Venna, pittore. Il tema della discussione è la stesura della sceneggiatura per un film che si chiamerà Vita futurista. Diviso in sequenze, ognuna dedicata a un aspetto del vivere quotidiano – come dorme, mangia, s’innamora, passeggia, lavora il futurista – il film è girato, nei mesi a venire, tra il Piazzale Michelangelo, il parco delle Cascine e i Lungarni, oltre che in teatro di posa. La prima ha luogo al cinema Marconi in piazza Strozzi: in perfetto stile futurista la serata è resa rocambolesca dalle provocazioni del pubblico e degli stessi registi, con lancio di uova e verdure contro lo schermo e gli autori. Dopo una distribuzione in altre città italiane (Bologna, Napoli, Pesaro, Roma), il film scompare. Della pellicola non si hanno più tracce; restano solo alcuni fotogrammi, oltre a una sintesi della sceneggiatura.[1]
Dunque Firenze entra da subito nella storia del cinema, anche se deformata dallo sguardo irrispettoso e irrituale di Marinetti e i suoi, che – a quanto ci è dato immaginare da ciò che resta del film – ai monumenti icone della città preferiscono la natura disordinata del parco delle Cascine o vedute bizzarre riprese dal fiume o dall’alto. E in effetti la presenza di Firenze sugli schermi è sempre segnata da una duplice alternativa; da un lato uno sguardo tradizionale che lavora di preferenza sull’asse Duomo-Piazza della Signoria-Lungarno per fare delle linee pure e severe della città rinascimentale il perfetto sfondo di una romantica storia d’amore, o per vederla, al contrario, segnata dalla storia proprio in quei luoghi che ne sono il simbolo universale; dall’altro una ripresa meno prevedibile e più trasversale che fa perno su spazi meno noti o li rilegge in una prospettiva multicentrica e più oscura; per finire con i territori quasi inesplorati delle periferie disordinate, anonime, lontanissime dalle antiche nobiltà del centro storico.
I segni della storia
Firenze 1935: la guerra è ancora lontana. Luca, figlio illegittimo di un commerciante di stoffe, viene allevato da una ricca e colta signora inglese che fa parte della folta colonia britannica residente in città; attraverso di lei il ragazzino si appassionerà all’arte e alla letteratura fino a diventare – dopo aver attraversato i tragici anni a venire ed essersi confrontato con la durezza della storia – un perfetto gentleman britannico. Non è difficile ravvisare nel giovane Luca un autoritratto di Franco Zeffirelli, regista di Un tè con Mussolini (Italia/GB 1999), forse il lavoro più programmaticamente fiorentino di tutta la sua carriera. Se le turbolenze della guerra e dei bombardamenti hanno per sfondo le cupe torri medievali di San Gimignano, è la prima parte del film a comporre l’immagine di Firenze come città ideale. Il filtro duplice della memoria e dello sguardo di Luca bambino crea un itinerario disteso e luminoso per le vie e le piazze della città: Ponte Vecchio, la cupola del Brunelleschi, Santa Maria Novella, piazza SS. Annunziata sono avvolti dalla luce tenue del ricordo e si disegnano nitidi nella loro perfezione, componenti di un universo armonico e fuori dal tempo. La Firenze zeffirelliana è un luogo senza storia: le sue strade e piazze sembrano vivere in un mondo sospeso in cui lo scorrere del tempo si sia arrestato, destinato a rimanere sempre uguale nella sua composizione ordinata di linee, volumi e superfici.
Il contrasto con le immagini dell’episodio fiorentino di Paisà (R. Rossellini, Italia 1946) non potrebbe essere più stridente. Qui i luoghi-simbolo della città – Pitti, Boboli, gli Uffizi – sono feriti dalla storia, incrinati nella loro perfezione dalla violenza del tempo e degli eventi. Se i soldati inglesi della prima sequenza osservano distaccati il campanile di Giotto dall’alto di un giardino di Boboli ancora luminoso e sereno, la sequenza successiva scompagina subito le linee rinascimentali del paesaggio. Sullo sfondo resta, immota, la cupola del Brunelleschi; ma in primo piano, invadenti e disordinate, le macerie dei palazzi crollati impongono allo spettatore la consapevolezza cruda della guerra, del dolore, della distruzione, in un montaggio nell’inquadratura che non è lontano dalla lezione ejzensteiniana. E ancora: i due protagonisti attraversano il corridoio vasariano e scrutano il paesaggio delle colline fiorentine che s’intravede dalla grande finestra – tra l’altro aperta in occasione della visita di Hitler a Firenze nel ’38; ma quelle linee accomodanti e accoglienti nascondono, per i due, il pericolo dei cecchini; e il magnifico cannocchiale prospettico del cortile degli Uffizi è sfregiato con una diagonale violenta dalle motociclette dei tedeschi che lo attraversano, rompendone l’equilibrio geometrico.
Il segno della storia del secondo Novecento torna nel recente La meglio gioventù (M.T. Giordana, Italia 2003). Novembre 1966: da una piccola televisione in bianco e nero Nicola, il protagonista, vede le immagini di una Firenze sepolta dalle acque dell’Arno; uno stacco e siamo subito in città, tra il fango e i detriti. È ancora il cortile degli Uffizi a rappresentare la città intera, in una raffigurazione dal taglio realistico che insegue i protagonisti lungo i corridoi della Biblioteca nazionale invasi dall’acqua, nelle stradine strette e impraticabili, nelle piazze trasformate in paludi. Ma quasi come in una poesia surrealista, tra l’acqua sporca e i rifiuti una ragazza suona un incongruente pianoforte a coda, nero e lucido; e l’amore tra i due personaggi non tarderà ad arrivare. Firenze è allora, qui, sia – rossellinianamente – protagonista delle immagini, con i suoi monumenti segnati dalla violenza della natura, che, in maniera più convenzionale, sfondo appropriato per una vicenda amorosa. In ogni caso sono comunque i luoghi-icona più celebri a rappresentarla: gli Uffizi, i Lungarni, il Duomo, segnati in modo diverso dal corso degli eventi. Qui Firenze è simbolo di civiltà e di cultura: un valore assoluto e atemporale per Zeffirelli, un segno doloroso della violenza della storia per Rossellini, e infine, per Giordana, il simbolo della capacità di resistenza e reazione della «meglio gioventù» italiana.
Educazione sentimentale
Firenze, 1907. Guardata a vista da Charlotte, una solerte cugina zitella, la giovane Lucy, proveniente da una facoltosa famiglia inglese, arriva in città e prende alloggio alla pensione Bartolini, senza però poter avere la promessa “camera con vista”. Questo l’avvio del racconto di Camera con vista (J. Ivory, GB 1986), che proseguirà con l’incontro e l’innamoramento tra Lucy e il giovane George Emerson, di abitudini più libere e stravaganti, che scombinerà la vita piuttosto compassata imposta alla ragazza dalle rigide usanze vittoriane fino a farle spezzare il fidanzamento con l’impeccabile e noioso Cecil Vyse per tornare a Firenze in viaggio di nozze, insieme a George. Qui la città è la cornice perfetta per l’educazione sentimentale della giovane inglese: la piazza della Signoria e soprattutto la piazza e la chiesa di Santa Croce (ma anche le colline coperte dagli ulivi dei dintorni) formano una quinta tanto calda e levigata quanto stereotipata. Tra la luce rosata dei tramonti e il sole riposante della campagna bucolica, la città è percorsa in un’antologia di vedute incantevoli quanto banali e senza vita, in un’immagine idealizzata e banale vicina piuttosto all’estetica patinata del dépliant pubblicitario.
Più tormentata e meno consolatoria la Firenze che emerge da due film per il resto lontani nei temi e nello stile: La viaccia di Mauro Bolognini (Italia/Francia 1961) e Piano, solo di Riccardo Milani (Italia 2006). Nel primo film sono i Lungarni a dividere in due la città non solo in senso spaziale. Da una parte la Firenze contadina, antica e povera, della Viaccia, il podere tanto amato da Stefano; dall’altra la città moderna delle strade e dei palazzi eleganti, dove il figlio di Stefano, Amerigo, sarà costretto a trasferirsi dopo la perdita del podere. E qui Amerigo (un giovane Jean Paul Belmondo) troverà un’altra “viaccia”, la via del malaffare e delle prostitute, dove conoscerà Bianca (una Claudia Cardinale seducente e tormentata), che perderà nel tragico finale su cui si chiude un’intensa e drammatica educazione sentimentale. Qui la cerchia urbana è icona di una modernità rabbiosa e avara, in cui dominano il denaro e l’avidità; le vie del centro della città sono un universo ostile per il protagonista, contrapposte a un mondo rurale più ospitale e accogliente e tuttavia destinato alla scomparsa.
In Piano, solo Firenze è lo sfondo dell’esistenza breve e irregolare del pianista Luca Flores. la geografia del film si divide tra i ricordi solari del Mozambico, dove il protagonista è vissuto da bambino e dove la madre è morta in un incidente, e il presente fiorentino, che vede il giovane Luca cercare di affrontare le difficoltà e le glorie di una brillante carriera di musicista. Se i flashback africani oscillano tra la luminosità abbagliante degli esterni (la savana, i lunghi pomeriggi oziosi passati ad ascoltare Vivaldi) e l’improvvisa implosione buia della morte della madre, il paesaggio cittadino è quasi sempre slavato e cupo. Dai Lungarni alle strade strette dietro piazza Santa Croce, la città è il luogo di un’esistenza malinconica e depressiva: il colore grigio delle pietre dei palazzi antichi e dell’Arno autunnale riflette l’animo pensieroso e chiuso del pianista, finché il peso dei ricordi non lo spingerà a darsi la morte in un finale dal tono sommessamente tragico.
Dunque Firenze come cartina di tornasole che riflette il gioco talvolta lieve, più spesso amaro dell’esistenza: sfondo bidimensionale per un idillio in Camera con vista, la città diventa immagine di un’esistenza sia in Bolognini che in Milani, in due lavori in cui le atmosfere cupe oscurano la luminosità delle colline e delle grandi piazze solari per creare uno spazio più chiuso e introspettivo.
Dalle pagine allo schermo
Nel confrontare la Firenze letteraria con quella cinematografica è impossibile non partire da uno degli scrittori che con più affetto e attenzione hanno narrato Firenze: nel suo Cronache di poveri amanti Vasco Pratolini ha descritto il microcosmo schietto e vitale di via del Corno, alle spalle di Santa Croce, in un affresco potente e umanissimo ambientato negli anni della presa del potere da parte del fascismo. È Carlo Lizzani, nel film omonimo uscito nel 1953, a portare sullo schermo quell’universo che intreccia in modo indissolubile i destini dei personaggi alla geografia della città.[2] Nonostante via del Corno, troppo stretta per le riprese, sia stata ricostruita in studio, il film è forse – paradossalmente – quello che più di altri restituisce certe atmosfere del centro storico fiorentino che vive alle spalle dei grandi monumenti: viuzze anguste in cui ci si spia dalle finestre tenendo d’occhio i vicini, in cui gli amori e le gelosie, le liti e amicizie nascono, esplodono e si spengono dietro le persiane semiaperte.
Di maggiore respiro la scenografia di Metello, ancora da Pratolini e diretto da Mauro Bolognini nel 1970. Sullo schermo appare la Firenze delle lotte operaie tra la fine dell’Ottocento e il grande sciopero generale del 1902: è una città operosa e anarchica quella ritratta dal regista pistoiese, vitale e popolare, che si muove tra le campagne di Rincine (dove il protagonista trascorre l’infanzia) e le strade e piazze della città ricolme di lavoratori decisi a lottare per i loro diritti, in un ritratto per molti aspetti inedito proprio perché lontano dalla composta eleganza dei luoghi simbolici su cui sembra che la storia non possa fare presa. Più sobri i toni delle scene familiari, in cui le strade e gli interni sono dipinti in colori più smorzati a seguire le vicende private del protagonista (un Massimo Ranieri doppiato con cadenza toscana), tra relazioni amorose complicate e i lunghi giorni in carcere da scontare proprio a causa delle idee politiche rivoluzionarie.
Allargando il campo alla letteratura europea, i fratelli Taviani hanno tratto il loro Le affinità elettive (Italia/Francia 1996) dal capolavoro di Goethe ambientando una delle scene centrali del racconto alla chiesa di San Miniato al Monte. Ripresa in campo lungo, la morbida scalinata ampia e accogliente, la chiesa fa da sfondo alle nozze tra Edoardo e Carlotta. Il bianco della facciata che si staglia contro l’azzurro del cielo fa da contrappunto alle linee pulite dell’architettura per creare uno spazio solare e sereno: è il luogo deputato al compimento dell’incontro amoroso nella sua perfezione spirituale, in cui le “affinità elettive” si manifestano in tutta la loro forza: una sorta di incantesimo provocato dall’unione della razionalità del disegno geometrico con il senso di mistero e di magia che ne emana.
All’estremo opposto, più cavernosa e quasi terrificante è invece la Santa Maria Novella in cui Jane Campion ha scelto di ambientare una delle sequenze più sofisticate del suo Ritratto di signora (Usa 1996), da Henry James. Della chiesa non vediamo la celebre facciata albertiana se non per una ripresa laterale e fortemente angolata, che sottolinea la vertigine interiore in cui la protagonista cadrà di lì a poco. E ancora meno tradizionali sono le riprese nell’interno, quando la giovane Isabel viene sedotta dall’enigmatico Gilbert Osmond. Le alte colonne, le navate profonde, il riecheggiare dei passi nei vasti spazi vuoti della basilica scompaginano la semplice perfezione prospettica dello spazio e lo rendono più simile a una grotta, un antro dell’anima in cui stanno in agguato pulsioni oscure. E del resto tutto il film lavora prorpio sull’idea di città come labirinto interiore, mappa confusa e onirica di un inconscio perturbante.
Il rapporto con la letteratura restituisce allora una Firenze che va al di là dell’illustrazione pedissequa dei monumenti canonici della città, che si trasformano in simboli dell’esistenza, raffigurazioni efficaci e dense (veraci oppure ambigue, letterali o metaforiche) del senso di una vita o di un’idea. La Firenze letteraria passa al cinema senza perdere in profondità ma anzi aggiungendo alla pagina la ricchezza polifonica di immagini che riescono a rileggere gli spazi simbolici fiorentini uscendo dagli stereotipi e trasformandoli in luoghi dello spirito.
Genere: Firenze
Un’altra via d’uscita dalla Firenze formato cartolina si ha nei film che condividono con più decisione i codici di genere, siano commedie, thriller o horror. Capostipite di tutte le commedie ambientate in città è senz’altro Amici miei (M. Monicelli, Italia 1975), che restituisce una Firenze cinerea e umida in sintonia con il sottotesto amaro delle avventure scanzonate e delle beffe crudeli dei quattro protagonisti. La città alla metà degli anni Settanta è mesta e senza vita; la grandezza del passato è ormai persa nei ricordi e il presente è quello plumbeo degli anni del terrorismo. Sarcastici e spettacolari, gli scherzi dei quattro sono un modo – divertente a prima vista, patetico e finanche luttuoso a uno sguardo più attento – per reagire a quel grigiore nebbioso che avvolge ogni cosa: e Firenze è piovosa e amareggiata come i suoi abitanti.
Decisamente più giocata sui timbri squillanti e spaventosi del genere horror la città che fa da sfondo alla prima parte di Hannibal (R. Scott, GB/Usa/Italia 2001), terzo episodio della saga di Hannibal Lecter. Firenze appare qui rinnegare i tratti rinascimentali per avvicinarsi ai caratteri gotici di Londra. Piazza della Signoria è segnata, quasi sfregiata da ombre nere che attraversano la facciata di Palazzo Vecchio; il Ponte Vecchio e il Lungarno si colorano di un inquetante colore rosso scuro, in un tramonto tutt’altro che romantico che ricorda piuttosto il colore del sangue; mentre gli interni (il salone dei Cinquecento, la casa dell’assassino) appaiono scuri, fumosi e intrisi di violenza. E sarà proprio nella vasta sala che affaccia su piazza della Signoria, del resto, che Hannibal porterà a compimento il suo rito macabro, sventrando e impiccando lo sventurato Rinaldo il cui corpo straziato cade in una piazza immersa in un innaturale blu elettrico.
Meno esplicitamente orrorifica e più sottilmente inquietante è la San Miniato di Complesso di colpa di Brian De Palma (Usa 1976, per molti aspetti un remake dell’hitchcochiano La donna che visse due volte). La serenità olimpica della location vista nel film dei fratelli Taviani si stempera qui a favore di un’atmosfera più sinistra e perturbante. La ripresa della facciata esterna è angolata dal basso, a evidenziarne l’imponenza e con la scalinata che incombe nell’inquadratura deformandone la prospettiva. All’interno una serie di carrelli laterali sembrano a prima vista voler sottolineare le solide colonne romaniche e la leggerezza degli affreschi trecenteschi; ma la penombra in cui sono immersi rende quegli spazi inquieti, ambigui, come se celassero segreti inconfessabili dietro l’apparente purezza delle linee e dei colori: una sorta di allucinazione che replica l’andamento dell’intero film, sempre sospeso tra realtà e immaginazione, fantasticheria e concretezza.
Infine, ancora un’atmosfera più vicina all’incubo che al sogno si respira in La sindrome di Stendhal di Dario Argento (Italia 1996). Qui sono i dipinti della galleria degli Uffizi a provocare le violente e improvvise reazioni della protagonista; dallo stordimento nella piazza della Signoria, all’agorafobia nell’avvicinarsi alla folla che si accalca davanti al museo, infine allo svenimento provocato dalla visione delle opere d’arte – in particolare Piero della Francesca, Paolo Uccello, Botticelli, Caravaggio e Bruegel.[3] Il museo e i suoi capolavori sono qui fonte di disarmonia e di sconvolgimento interiore; Argento ribalta i luoghi comuni che legano la melodia delle architetture rinascimentali alla serenità interiore che esse infondono e ne fa gli strumenti di un malessere profondo, di un disagio ostinato che finisce per travolgere la psiche della protagonista.
Dunque il film di genere sceglie di lavorare sulle sfaccettature meno note della città e di portarne alla luce le atmosfere lugubri e luttuose; dietro alla facciata di serena compostezza si agita un mare di flutti agitati che sparigliano le immagini stereotipate di bellezza e perfezione armonica e ne rivelano il volto nascosto, solitario e malato.
Conclusione: lontano dal centro
Ma sono forse i film ambientati nelle periferie, lontanissime sia nello spazio che nello spirito dagli splendori austeri del centro storico, a offrire l’affresco più inedito e inatteso della città. È nei cavalcavia anonimi, nei prati disseminati di erbacce, nelle case del popolo nascoste in palazzoni di cemento di periferia, nelle balere all’aperto della Prato di Giuseppe Bertolucci e Roberto Benigni (Berlinguer ti voglio bene, Italia 1977) che paradossalmente si può leggere, come in un controcampo incongruo, il vero volto di Firenze. È attraverso il suo contrario – gli spazi senza progettualità, le architetture distratte, le prospettive casuali e irregolari – che Firenze appare com’è: accesa, pulsante, anche sbracata nella sua vitalità che cerca senza successo di nascondere dietro il volto severo delle grandi architetture del centro; periferia incolta e brulicante di vita che cerca invano di nobilitarsi mascherandosi dietro alla matematica armoniosa delle proporzioni brunelleschiane.
Note
1. Cfr. M. Verdone, Le avanguardie storiche nel cinema, Sei, Torino, 1977.
2. Dai romanzi di Pratolini sono tratti anche Le ragazze di San Frediano (V. Zurlini, 1954), Cronaca familiare (ancora di Zurlini, 1962), La costanza della ragione (P. Festa Campanile, 1965).
3. Per inciso, qui Argento cade in un’imprecisione dato che il dipinto di Bruegel La caduta di Icaro non si trova agli Uffizi ma al Museo reale delle belle arti di Bruxelles.