
Photo Credit: Alessandra Capodacqua
1. Una nota personale
Mi si permetta di iniziare con una breve nota di carattere personale-politico per spiegare come è nato il mio interesse a questo tema. Negli anni Settanta ho partecipato al movimento delle donne che ha conseguito diversi risultati non solo dal punto di vista politico, sul piano dei diritti civili e di servizi sociali, ma anche in termini di cambiamento della mentalità tradizionale ancora tipica dell’Italia anni Cinquanta e Sessanta, venata di patriarcalismo e maschilismo. Nei decenni successivi ho dato per scontato che gli obiettivi fossero stati raggiunti una volta per tutti e ho in qualche modo messo fra parentesi l’interesse per i temi sollevati dal femminismo. Per questa ragione le discussioni sorte in ambito anglosassone sulla questione del Language and gender e Sexism in language (1) non avevano sollevato in me nessun richiamo. Credevo che fossero un mero esercizio di formalismo linguistico con ricadute più dannose che utili e del tutto inessenziali allo sviluppo positivo e affermativo del ruolo femminile nella società. Oggi penso invece che la questione di come considerare il genere nella lingua italiana sia attuale politicamente e civilmente ed anche scientificamente interessante. Dal punto di vista politico e civile risulta ai miei occhi evidente che l’emancipazione femminile non è un processo condiviso a livello globale e che anche a livello nazionale ci siano controtendenze e resistenze; per questa ragione trovo interessante analizzare come il linguaggio possa influenzare tale resistenza e capire dal punto di vista della ricerca disciplinare se ci siano caratteristiche semantiche e grammaticali che possano essere usate per sostenere tali posizioni.
2. Le idiosincrasie per il purismo linguistico
In effetti alla domanda “si può modificare l’uso linguistico per decreto?” continuerei a rispondere di no. Non è pensabile che la lingua, il cui funzionamento trova alimento nella possibilità di combinare il suo sistema lessicale e grammaticale in infiniti significati pragmatici, comunicativi e metaforici possa essere irrigidita in norme che lascerebbero il tempo che trovano. Le norme di political correctness in uso nell’ambito anglo-americano da questo punto di vista non sono sempre condivisibili. A volte sembrano essere una strategia compensatoria per bilanciare evidenti ingiustizie sociali, altre volte appaiono come ipercorrettismi che rischiano di togliere alla lingua la sua vivezza.
In Italia abbiamo una antica tradizione sia di purismo sia di centralismo linguistico collegata alla questione della lingua. La questione della lingua è un terreno vastissimo di studi e riflessioni su quali sono i caratteri costitutivi dell’italiano, su qual è il suo ruolo di lingua ufficiale o nazionale, su quali sono i suoi rapporti con i dialetti, con le lingue di minoranza o con le lingue straniere. La questione della norma e della identità della lingua italiana era sorta già ai tempi di Dante, ha avuto un primo picco nel secolo XVI e poi dai primi decenni del XIX secolo si è connessa a istanze patriottiche e nazionalistiche. Alessandro Manzoni non era un purista, ma aveva in mente una lingua-modello a cui fare riferimento: il fiorentino colto. In un modo o nell’altro questo è stato il modello che ha ispirato le politiche educative nazionali nel XIX e XX secolo, convivendo e interrogandosi sulla distanza fra lingua scritta e parlata e con la persistenza dei dialetti.
In tema di purismo linguistico in Italia abbiamo inoltre avuto l’esperienza della politica linguistica autoritaria e dirigistica del fascismo con la sua avversione ai dialetti, l’espunzione di vocaboli esteri dalla lingua, l’italianizzazione forzata dei toponimi delle aree non italofone, l’obbligatorio passaggio dal “lei” al “voi”. Con la caduta del fascismo una buona parte di questi obblighi sono scomparsi, mentre sono rimaste soluzioni che possiamo definire “ragionevoli” come la creazione di alcuni neologismi, ad esempio: fr. chauffeur e régisseur => it. autista e regista. Altre soluzioni meno “ragionevoli” come i toponimi tradotti rimangono ancora oggi come memento della arbitrarietà e dell’autoritarismo di soluzioni di questo genere, ad esempio Castelrotto (Kastelruth in tedesco, Ciastel in ladino) nome italianizzato di una cittadina dell’Alto Adige.
Questo tipo di memoria pesa sui parlanti e li rende sospettosi verso politiche linguistiche dirigistiche o persino verso espressioni di gradimento personale da parte di donne-personaggi pubblici a favore di alcune espressioni piuttosto che altre. Il 23 ottobre 2016 Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 ore, nella rubrica Prima Pagina di RadioTre ironizzava sul fatto che Laura Boldrini volesse essere chiamata “Presidente? O Presidentessa? O che altro?”, facendo passare il senso che la richiesta di Laura Boldrini fosse del tutto capricciosa e estemporanea.
Fino a un paio di anni fa non avrei fatto caso a questo commento del giornalista e forse lo avrei condiviso con il retro-pensiero che, se la lingua rappresenta gli atteggiamenti dominanti, non sarà il cambiamento di lessico a segnare una evoluzione socio-politica dei generi. È questo l’approccio che vede nello sforzo di cambiare la lingua un’attività nel migliore dei casi superflua e nel peggiore ridicola.
3. Italiano popolare o Italiano volgare?
Tuttavia negli ultimi decenni l’uso sessista del linguaggio ha conquistato una dimensione pubblica che prima non conosceva. Nel linguaggio politico italiano dell’ultimo ventennio la volgarità è stata contrabbandata come linguaggio antipolitico e popolare. A partire dagli anni Novanta la pratica di utilizzare un linguaggio aggressivo a forte connotazione sessuale diventa frequente nel panorama politico italiano e non sembra incontrare né opposizione netta né censura conclamata. Per un florilegio di citazioni, cominciamo da: Bossi (Lega Nord): “Ehi, Boniver, bonazza, la lega è sempre armata, ma di manico” (comizio a Curno, BG, 26 settembre 1993). E poi passiamo a: De Rosa (M5 stelle) : “Voi donne del PD siete qui solo perché siete brave a fare i pompini (commissione Giustizia, 29 gennaio 2014)”. Per non citare i commenti contro la Presidente Boldrini pubblicati sul web (3).
Laura Boldrini ha raccontato a Repubblica (intervista a Concita De Gregorio, 3 maggio 2013): “Quando una donna riveste incarichi pubblici si scatena contro di lei l’aggressione sessista: che sia apparentemente innocua, semplice gossip, o violenta, assume sempre la forma di minaccia sessuale, usa un lessico che parla di umiliazioni e di sottomissioni”. Un simile linguaggio obbliga a riflettere sulla violenza parlata e sull’uso del linguaggio che, se non tocca il piano fisico delle azioni, invade però il piano simbolico. L’incitamento all’odio – hate speech – è una categoria della giurisprudenza USA – e da pochi anni anche di quella europea – che indica un genere di parole e discorsi che hanno lo scopo di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo – razziale, etnico, religioso, di genere o orientamento sessuale. Tutti noi ascoltiamo e leggiamo esempi di simile violenza verbale nei talk shows o nei social media e spesso – per fortuna – si alzano voci contrarie. Tuttavia, quando è coinvolto il genere femminile, in quanto tale, le stesse donne sono più timide e restie a protestare (4). La diffusione di queste forme di violenza verbale hanno fatto sorgere in me la consapevolezza che in qualche modo in Italia il linguaggio sia ancora segnato da una forte carica di sessismo e mi hanno convinto che una sorta di affermative action in questo settore possa essere necessaria. Non sarebbe un salto in avanti o un intervento autoritario, ma l’adeguamento della lingua a un mutamento dei rapporti fra generi che si è affermato nella società italiana. In un contesto sociale mutato la discriminazione sessista e gli stereotipi di genere pervadono ancora la nostra lingua e possono essere rafforzati da essa.
4. Genere, lingua e lingua italiana
In collegamento alle eventuali caratteristiche sessiste della lingua si apre una questione non nuova della relazione fra lingua e pensiero e in effetti a questi aspetti linguistici di tipo generale alcuni studiosi (Lepschy 1989) si sono ricollegati citando come riferimento scientifico l’ipotesi Sapir-Whorf (2) per cui la lingua condiziona il modo di pensare. Dal punto di vista della teoria linguistica l’ipotesi sviluppata da Sapir e poi ripresa in modo estremizzato da Whorf sottolinea come la lingua non solo manifesti, ma influenzi il pensiero con legami nella sfera culturale più che in quella grammaticale.
Di sessismo linguistico e di gender, grazie anche ai concetti di empowerment e mainstreaming sviluppati a metà degli anni Novanta nel mondo anglosassone, si parla e si scrive oggi anche in Italia fuori dell’accademia: oltre alla stampa, in rete, nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche, nell’editoria scolastica.
D’altra parte Patrizia Violi, studiosa di semantica, scriveva nel 1986 (Violi 1986: 41) che: “Il genere non è soltanto una categoria grammaticale che regola fatti puramente meccanici di concordanza, ma è al contrario una categoria semantica che manifesta entro la lingua un profondo simbolismo”. Benché dagli anni Ottanta ad oggi la riflessione su questi temi si sia variamente sviluppata, tuttavia il simbolismo a cui Violi fa riferimento rimane presente nella lingua. Le categorie collegate al genere possono essere ideologicamente condizionate e contemporaneamente rafforzare discriminazioni e stereotipi. La connessione fra l’immagine della differenza sessuale e l’espressione linguistica (ad esempio nel linguaggio pubblicitario) è uno snodo obbligatorio per comprendere cosa significhi sessismo nella lingua e come è possibile modificarne l’uso.
Prima di proseguire vorrei tuttavia fare il punto sulla terminologia. In contesto linguistico “genere” si usa in senso grammaticale, ma non è possibile separarlo da un contesto più ampio in cui denota la costruzione di identità basata su scelte individuali di adesione o meno a uno dei generi socialmente definiti e collegato referenzialmente al sesso biologico.
La lingua italiana è segnata da due generi: maschile e femminile. La differenziazione dei generi è un processo che ha caratterizzato una fase tarda dell’indoeuropeo ed è interna alla tendenza delle lingue a trovare classificatori nominali. La distinzione originaria nell’indoeuropeo era fra animato e inanimato e la distinzione fra femmina e maschio era rappresentata da termini differenti, come nel latino pater/mater, e non da modifiche flessionali. La nascita di una opposizione maschile/femminile si origina non nei nomi, ma negli aggettivi attraverso l’estensione della differenza presente nei dimostrativi agli altri determinanti. Solo più tardi e all’interno delle singole lingue, e quindi in modo differenziato e non come caratteristica originaria comune, l’opposizione fra maschile e femminile si è estesa ai nomi.
Il genere in Italiano è un carattere “inerente” al nome e in questo senso si differenzia dal numero che per proprietà flessiva consente alla maggior parte dei nomi di essere trasformato dal singolare al plurale. Invece, né con processi flessivi, né con processi derivazionali si possono formare nomi femminili da ogni nome maschile. È possibile invece creare il femminile di quegli elementi come articoli o aggettivi che hanno categoria flessiva e che obbligatoriamente si accordano con il genere del nome italiano.
Tuttavia in italiano per quanto riguarda i nomi animati, per lo più umani e con riferimento alla differenza sessuale, esistono dei suffissi che storicamente sono serviti a formare il femminile partendo da nomi maschili, ad esempio: –a, –essa, –trice. Tornerò in seguito sull’uso di questi suffissi.
Per continuare a parlare della lingua italiana possiamo dire che per gli animati umani il genere grammaticale di riferimento è un genere collegato al sesso del referente, benché ci siano casi che non entrano in questa definizione come ad esempio “il soprano” normalmente di sesso femminile e grammaticalmente maschile (5) o “la sentinella” finora normalmente di sesso maschile e di genere grammaticale femminile.
Segno del percorso storico della lingua è in italiano la presenza di un nutrito gruppo di nomi maschili in -a come atleta/poeta/dentista ecc…, nomi che provengono dal greco e dal latino e che mettono tanto in difficoltà i nostri studenti stranieri. Benché la maggior parte dei nomi femminili termini in –a, la vocale finale –a in italiano non è segno univoco del genere grammaticale femminile. Il genere grammaticale dei nomi si conosce nel testo considerando l’accordo dentro o fuori del sintagma nominale con articoli, dimostrativi, aggettivi, participi passati, pronomi oppure – come ripeto ai miei studenti – consultando il dizionario.
Nelle lingue derivate dall’indoeuropeo come greco e latino lo stato delle opposizioni dei generi era un sistema come mater/pater, con radici differenti, oppure l’uso di un’unica parola come hippos greco che comprendeva entrambi i sessi. Lo sviluppo tardo e secondario dell’opposizione maschile/femminile ha originato un sistema per cui, dove i termini non avevano radici differenti, il femminile si è formato in modo derivato dal maschile, es.: amico => amic-a
Questo sviluppo tardo e secondario ci può far riflettere sul fatto che l’assegnazione dei generi nei nomi non ha dal punto di vista semantico una specifica utilità al funzionamento di una lingua. Villar (1997:281) scrive a proposito della formazione del genere in indoeuropeo: “Infatti per la stragrande maggioranza delle specie viventi, l’uomo non ha nessuna necessità o interesse a distinguere il maschio dalla femmina. Non fa una grande differenza se ci divora uno squalo maschio o femmina; o se il cameriere ci serve un pagello maschio o femmina. In realtà, gli animali di cui ci interessa il sesso sono molto pochi. E per essi, nella maggior parte dei casi abbiamo una parola completamente diversa per il maschio e per la femmina (non la stessa parola con variazione di genere). Cominciando dagli esseri umani abbiamo uomo/donna, padre/madre, nuora/genero, marito/moglie. Tra gli animali maiale/scrofa, toro/vacca, ape/fuco”.
In italiano i nomi degli animali – di solito quelli estranei alla comunità linguistica – possono avere un unico genere grammaticale senza un’immediata referenza semantica al sesso maschile o femminile. Es.: la tigre, la giraffa, il leopardo, il serpente. In questi casi il tratto semantico +/-maschio o femmina deve essere aggiunto esplicitamente. Es.: la tigre maschio, il leopardo femmina.
Per gli animati umani la questione è più delicata. Renzi (1988:318-19) scrive: “Tra gli stessi nomi di animati, non sono rari quelli che non appartengono a coppie fondate sulla differenza di sesso, ma presentano un solo genere (‘epiceno’), maschile o femminile. Un’unica forma non può infatti consentire il realizzarsi dell’opposizione semantica [+maschio] vs [-maschio]:
(35) il giudice; la guida (+ umano , +/- maschio)
(36) il gorilla; la tigre (-umano, +/- maschio)
Il nome di genere epiceno caratterizzati dal tratto [+umano] (v.35)) si riferiscono generalmente alla funzione svolta dal referente; quelli caratterizzati dal tratto [- umano] (v. (36)) indicano spesso animali estranei all’ambito della comunità linguistica.”
Dalla citazione emergono due aspetti, il primo è che la parola “giudice” a fine degli anni ottanta veniva ancora caratterizzata come esistente solo al maschile benché la terminazione in –e possa permettere la creazione della forma femminile “la giudice”. In secondo luogo che il tratto semantico di riferimento era una gradazione del maschile con l’indicazione +/- maschio in quanto anche in una coppia con opposizione maschile/femminile il termine non marcato era definito come maschile.
Scriveva infatti ancora Renzi (1988 :320): “Quando, in un dato contesto, la distinzione [+maschio] vs [-maschio] in nomi animati non è pertinente oppure non è possibile, vien usato un termine non marcato, il cui significato è comune ai termini di coppia:
(44) Un giudice deve essere imparziale.
(45) il bambino ha bisogno di molto affetto.”
Ci sono state nel corso della storia della questione del genere posizioni differenti che lo hanno definito come un fenomeno riflettente una struttura duale presente in natura. Sono le posizioni che partono dalla concezione di Wilhelm von Humboldt formulata nel XIX secolo e arrivano in epoca contemporanea a quelle di Louis T. Hjelmslev che cerca di ancorare il genere a criteri semantici più generali del sesso.
Per un altro linguista come de Saussure il genere era invece un fenomeno esclusivamente formale e privo di contenuto. In questa prospettiva il genere ha senso solo come categoria che ha una funzione a livello sintattico definendo sintagmaticamente le regole di accordo. Il genere del nome comanda il genere degli elementi del sintagma nominale e anche alcuni elementi esterni al sintagma.
Per la lingua italiana possiamo ipotizzare, adattando quanto scrive Corbett 1991: § 1.1.3: “Gender are classes of nouns reflected in the behavior of associated words”, che una funzione specifica del genere sia quella di generare accordo. Dal punto di vista sintattico l’accordo di genere è di grande utilità nel caso di lingue ad ordine libero, come l’italiano, perché fornisce la correlazione fra nome e costituenti. In questi casi il genere come fenomeno di accordo è un fattore di coesione e coerenza del testo e in quanto tale – anche considerato come fenomeno formale – è funzionale alla comunicazione.
Le posizioni più recenti hanno trovato una sintesi fra i due approcci definendo il genere come una categoria in cui si incrociano elementi di sintassi e di semantica (Wienold 1967). Wienold distingue il genere del nome da quello dell’aggettivo (dove il genere è una categoria flessiva che non implica la variazione del semantema, cioè l’elemento della parola portatore del significato). In ambito italiano (Pretto 1985, Simone 1990) la componente sintattica viene definita come essenziale per la definizione del genere, tuttavia rimane l’attenzione alla componente semantica anche se la base naturale non è necessariamente costituita dal sesso, ma può essere offerta da altri parametri come l’animatezza. Simone parla di “iconicità grammaticale” (Simone 1990:312) nel senso che una base naturale (sesso o altro) nel settore nominale aiuterebbe a categorizzare il reale e costituirebbe il riflesso di alcune categorie concettuali.
5. Il genere dei nomi animati
Per tornare alla storia della lingua, l’assegnazione del genere maschile o femminile ai nomi arriva all’italiano passando dal latino in cui erano presenti tre generi: maschile, femminile e neutro. Nel passaggio al volgare la divisione in generi si è semplificata – come è successo per altri aspetti della lingua – e i generi si sono ridotti a due: maschile e femminile. L’assegnazione dei nomi all’uno o all’altro genere è avvenuta per ragioni semantiche (animato di sesso maschile o femminile) e formali (fonologiche o morfologiche). La presenza di questi due criteri di assegnazione si rileva anche oggi nei casi di assegnazione di genere ai prestiti o a neologismi o addirittura a nomi inventati: i nativi assegnano un certo genere ai nomi in modo piuttosto uniforme rispondendo a implicite e inconsce regole (semantiche o formali) che fanno parte della loro competenza grammaticale e lessicale. Non è quindi possibile rintracciare caratteristiche espressamente sessiste nell’evoluzione linguistica e nell’assegnazione dei generi. L’assegnazione del genere va al di là della questione della differenza sessuale, sia perché dal punto di vista semantico l’assegnazione del genere non categorizza semplicemente il sesso, sia perché dal punto di vista formale l’assegnazione si fonda su una serie di regole morfologiche e fonologiche che non hanno relazione con la differenza sessuale.
Teniamo anche presente che il neutro – escluso dalla discussione per la lingua italiana – è mantenuto in altre come il tedesco per indicare il cucciolo della specie di riferimento, umana o animale o comunque il non adulto come in “Mädchen”. Mark Twain in A Tramp abroad (Appendix D) ironizzava sulla lingua tedesca e sul fatto che in tedesco una rapa è femminile mentre una ragazza è neutra. (6) L’ironia di Twain si può ben estendere all’italiano. Immagino che questa impressione di aleatorietà sia la stessa che possano avere i nostri studenti stranieri quando si trovano di fronte all’assegnazione dei generi in italiano dove a un criterio semantico referenziale si aggiungono e alternano criteri morfologici e fonologici. Non solo l’arbitrarietà, ma anche la mancanza di trasparenza, ostacolando la corrispondenza fra funzione grammaticale e significato, blocca quello che è il dispositivo principale per l’acquisizione degli aspetti grammaticali della lingua, cioè la corrispondenza fra forma e funzione.
6. Le valenze socio-culturali della differenza grammaticale
La consapevolezza che nell’evoluzione storica della lingua l’assegnazione dei generi non ha seguito criteri di discriminazione non pregiudica il fatto che oggi nella lingua italiana l’uso della categorizzazione maschile/femminile possa avere delle caratteristiche sessiste e che la polarità femminile/maschile come usata nella lingua italiana possa avere una influenza sullo sviluppo dell’identità di genere.
A questo proposito interessante è uno studio di tipo psicologico che risale agli anni Sessanta svolto su parole italiane sottoposte a bilingui italiani/inglesi che hanno assegnato connotazioni diverse a sostantivi con la stessa radice, ma con genere opposto. Ervin (Ervin 1962) ha esaminato i giudizi di parlanti su parole inventate e prive di senso usando la metodologia del differenziale semantico (Osgood, Suci, e Tannenbaum 1957). Nel suo esperimento Ervin ha presentato a dei soggetti bilingui parole con la desinenza -o tipica del maschile o con la desinenza –a tipica del femminile. I soggetti dovevano assegnare un genere alle parole senza senso e poi collegarli a aggettivi graduati su una scala semantica. Ervin ha trovato che la percezione dei soggetti era collegata alla collocazione di genere. Parole senza senso che terminavano con -o sono state più spesso associate a qualità come ‘forte’, e ‘grande’ mentre parole senza senso che terminavano in –a venivano associate a parole come ‘bello’ e ‘delicato’. Lo studio di Ervin era interessante perché era il primo studio che mostrava che il genere grammaticale aveva significato. (7)
Oggi una critica agli aspetti sessisti dell’uso del genere grammaticale nella referenza a soggetti animati deve partire necessariamente dal fatto che nella lingua italiana il maschile si è configurato come il genere di riferimento usando una funzione che viene definita nelle grammatiche italiane come “maschile non marcato” o “maschile neutro”. Il maschile neutro ha la possibilità di rappresentare un valore non marcato, cioè un valore che ha una maggiore diffusione, una struttura morfologica più semplice e include un maggior numero di lessemi venendosi così a configurare come elemento prototipico del paradigma. Nella lingua italiana la possibilità di rappresentare questo valore non marcato viene riconosciuto esclusivamente al genere maschile. Es.: l’uomo è un essere dotato di ragione (e la povera donna?).
Altro punto grammaticale che può avere una ripercussione socio-culturale è l’uso del maschile plurale come termine generico e includente il femminile. Al plurale i termini maschili includono grammaticalmente i due sessi e si riferiscono, sia a uomini, sia a donne. Il maschile assume il ruolo di funzione di riferimento generico o meglio, diciamo, pseudo-generico. Es.: Giorgio e Maria sono due miei amici.
È questa una prospettiva androcentrica? Il pericolo esiste. Ad esempio quando, facendo riferimento ai maggiori scrittori del XX secolo, la definizione di “scrittori” nasconde il fatto che nel XX secolo ci sono stati scrittori e scrittrici e orienta il lettore/lettrice a pensare che l’uso del genere maschile non sia solo grammaticale, ma possa essere collegato a categorie referenziali e che quindi gli scrittori del XX secolo siano fondamentalmente uomini. Questo è un esempio di come il maschile pseudo-generico divenga nell’uso un riferimento socio-culturale discriminatorio.
7. La politica linguistica in Italia
Alla fine degli anni Ottanta, nel 1986, con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri (interessante notare il diverso processo in Italia e negli Stati Uniti: istituzionale in Italia, accademico e associazionista in USA) Alma Sabatini curò una pubblicazione intitolata Il sessismo nella lingua italiana che doveva fare da punto di riferimento soprattutto per scuole ed editoria scolastica. Il capitolo III della pubblicazione listava una serie di Raccomandazioni che in parte sono state assorbite negli ultimi decenni da diverse istanze dell’amministrazione pubblica e scolastica. A distanza di trent’anni è interessante tornare sul documento per vederne i limiti e i punti di forza. Come punto di forza si può registrare il fatto che le raccomandazioni sono state/sono un passaggio fondamentale per innalzare il livello di attenzione sulle questioni linguistiche e contenere l’influenza negativa che il predominio del genere maschile aveva/ha nell’uso della lingua italiana. Il predominio del maschile ha l’effetto sottile di rendere invisibile dal punto di vista linguistico il genere femminile e questa invisibilità può trascendere dalla sfera linguistica a quella referenziale.
Il fatto che molte donne non si sentano discriminate dal prevalere del genere maschile nella lingua non significa che questa prevalenza non esista. La percezione del fenomeno non necessariamente corrisponde alla realtà del fenomeno stesso. Ad esempio è interessante ricordare come un’inchiesta Istat del 2006 sui 6.740.000 casi di donne vittime di violenza circa il 70% non percepivano la violenza come un reato o come qualcosa su cui esprimere un giudizio negativo e quindi non si rendeva conto della propria condizione (8). L’androcentrismo (per non dire maschilismo e sessismo) della nostra cultura (mediterranea?) è un elemento profondo che può segnare la percezione che molte donne hanno di se stesse.
Per tornare alle Raccomandazioni del capitolo III quali erano le proposte del 1986 di Alma Sabatini?
Possiamo selezionarle e sintetizzarle in tre punti:
- Critica del maschile come termine non marcato quindi generico, neutro e prevalente. Perché la forma maschile deve comprendere sia gli uomini sia le donne? Perché la parola generica “scrittori” deve includere/nascondere le scrittrici? Perché devo dire Marco e Claudia sono italiani? Che cosa giustifica l’uso dell’accordo maschile per i plurali quando sono in presenza di un femminile e di un maschile?
- Critica all’uso di alcuni termini propri dell’area semantica femminile come la famosa coppia signora/signorina che non trovava un equivalente nell’uso maschile. Critica all’uso dell’articolo femminile davanti al cognome delle donne.
- Critica a come sono usati i titoli professionali o istituzionali per uomini e donne. Perché non posso dire la ministra /la rettrice/la prefetta?
Per quello che riguarda il punto 1. dobbiamo considerare che la differenza fra marcato e non marcato è radicato nel modo in cui concepiamo gli opposti e in cui questi sono categorizzati in una lingua. Senza voler e poter approfondire qui i vari significati possiamo dire che il concetto di marcatezza è stato introdotto dalla Scuola di Praga prima nell’ambito fonologico e poi esteso ai livelli morfologici e morfosintattici, lessicali e semantici. Vengono definiti marcati quei tratti meno diffusi, appresi in un secondo tempo, meno resistenti al mutamento linguistico. In lingua italiana si considera che il maschile singolare sia a livello morfologico il tratto non marcato e il femminile quello marcato. La marcatezza non riguarda solo il genere ma attraversa tutta la lingua e un dissolvimento della distinzione fra marcato e non marcato non sembra possibile né auspicabile. Tuttavia esiste un grado dell’estensione e dell’uso. Se l’estensione della non marcatezza maschile è pervasiva anche in situazioni in cui si possono trovare altre soluzioni allora si favorisce un uso linguistico in cui il genere maschile grammaticale diventa il punto di rifermento culturale. Anche se la lingua è un sistema vivo e non è possibile, né desiderabile, che venga orientata da rigide norme politiche, possiamo comunque riflettere e stimolare i nostri studenti a interrogarsi sulla differenza di uso e di percezione dei seguenti termini:
Uomo di strada Donna di strada
Buon uomo Buona donna
Uomo disponibile Donna disponibile
Il valore semantico differente dei termini è indicativo di come nella lingua italiana l’uso del maschile non marcato non significhi immediatamente uso generico e di come ci sia una opposizione in termini non solo grammaticali ma connotativi fra il femminile e il maschile. Facciamo un esempio positivo: l’evoluzione dell’espressione da “i diritti dell’uomo” a “i diritti umani” è stato un passaggio importante, come l’uso dell’appellativo ascoltatrici/ascoltatori nelle trasmissioni radio o signore/signori nelle situazioni ufficiali. In entrambi i casi sono state trovate soluzioni che hanno mitigato la forza della non marcatezza del maschile, o trovando un termine che non avesse un referente semantico univoco, o dando visibilità al femminile.
Per quanto riguarda il punto 2. delle indicazioni precedentemente ricavate dalle Raccomandazioni, l’uso di alcuni termini come signora/signorina sono mutati e altri sono tutt’ora in movimento benché si senta ancora a volte nei mezzi di comunicazione indicare Angela Merkel come “la Merkel” – articolo che non esiste per il cognome maschile – e non semplicemente Merkel, oppure come “la Cancelliera Merkel”.
Per quanto riguarda il punto 3., in italiano ci sono professionisti della comunicazione che continuano a dire “il ministro Pinotti” o “il magistrato Bocassini”, con l’idea che la ministra o la magistrata “suonino male”. In questo settore emerge chiaramente come il problema non sia la lingua che ha difficoltà ad evolvere e ad accettare i cambiamenti della società. Dopotutto abbiamo accettato così tante parole inglesi e per di più pronunciate così male che possono “suonare molto peggio”. Il problema non è la lentezza con cui evolve la lingua, ma la chiusura mentale della società nell’accettare cambi di questo genere. Il femminile non viene usato non perché grammaticalmente scorretto, ma perché ancora “suona male” che una donna possa fare alcuni lavori. Il fatto che alcune donne anche in ruoli direttivi importanti preferiscano i titoli al maschile è secondo me il segno che il femminile viene percepito come portatore di un carattere meno prestigioso del maschile. Ci sono parole che hanno accumulato una serie di connotazioni da cui è difficile districarsi. Come si può interpretare la parola “direttrice”? Come la “Signora direttrice” del Giornalino di Gian Burrasca? Come la direttrice della scuola elementare che era l’unica carica direttoriale accessibile alle donne alla fine degli anni cinquanta? Passerà un po’ di tempo prima che il termine riprenda il suo carattere semantico di indicatore di capacità direzionale per uomini e donne. Una soluzione potrebbe essere quella di usare ad esempio nel caso dei nomi in –ore (maschile) e –trice (femminile) un suffisso definito popolare come -ora, ma fondamentalmente meno usato e quindi meno connotato sessisticamente. È un gusto personale, ma a me “direttora” piace. Per nomi maschili che finiscono in –o la possibilità di formare il femminile è del tutto logica e grammaticalmente corretta, come nel caso di sindaco/sindaca, ministro/ministra.
Nel caso del maschile plurale inclusivo la critica che qualche volta emerge dai media si riferisce al fatto che il termine “ascoltatori/ascoltatrici” può essere pedante. Ho notato alcune volte – sui social media – l’uso di segni diacritici per formare i plurali, la @in spagnolo e l’asterisco* in italiano: “ascoltator*”. Benché l’asterisco sia simpatico, personalmente auspico l’esplicitazione del femminile. Se le donne hanno una posizione nella società, allora ci deve anche essere il corrispettivo di quella posizione in un titolo adeguato. Mi sembra più corretto esplicitare la differenza di genere piuttosto che nasconderla nel maschile generico o negliasterischi. Nei testi amministrativi e giuridici e nei media c’è ancora confusione e incertezza quando è una donna a ricoprire incarichi istituzionali e a svolgere professioni tradizionalmente maschili. Questa confusione conduce a volte a veri e propri errori grammaticali come la discordanza di genere tra il sostantivo e l’articolo, l’aggettivo o il participio passato. Ad esempio: “Una militare italiana”, che è “il maresciallo” ed è “stata ferita”. Altre volte il risultato sono dei fraintendimenti. Come nel caso: “Il sindaco incinta parla con il marito”. Dove “il sindaco” è, in realtà una donna ovvero una sindaca. (9)
8. Femminilizzare
Sulla questione della femminilizzazione dei nomi si è sviluppato un dibattito sia dal punto di vista dei mezzi di comunicazione, sia dal punto di vista scientifico. In ambito mediatico l’uso oscilla. Nella rubrica curata da Concita Di Gregorio su La Repubblica dal titolo “Cosa pensano le ragazze” uno dei video è intitolato “Gli eroi delle ragazze”. Nel video le ragazze parlano di eroi e anche di eroine, ma potremmo chiederci se quella domanda in cui il maschile fa da criterio generale può aver orientato le risposte. È questo un buon esempio per mettere in evidenza come persiste la resistenza verso le forme femminili. Statisticamente le forme non femminilizzate sono quelle di prestigio o nel senso comune ancora bandite alle donne: direttore generale, direttore amministrativo, ingegnere, chirurgo, notaio e cavaliere del lavoro, assessore, consigliere, deputato.
Si può dire che, per quanto riguarda titoli e professioni, l’evoluzione della lingua sta in qualche modo seguendo, anche se non linearmente, quello che avviene nella società e nello stesso tempo mi sembra che emergano in modo abbastanza evidente quali possono essere le linee guida per affermare una gestione paritaria di queste aree semantiche. Volendo attivare delle modifiche all’uso della lingua che non risultino meccaniche e impositive una riflessione bilanciata spinge a fare attenzione al vocabolario e specificamente al lessico dei ruoli istituzionali e delle professioni particolarmente quelle di prestigio. In questo settore infatti si è concentrato il cambiamento sociale del rapporto fra i generi. Professioni e ruoli che in precedenza erano prevalentemente maschili sono diventati ambiti di affermazione femminile qualche volta in modo graduale e condiviso qualche altra volta con attriti e vittorie femminili in sede giudiziaria. Ricordiamo ad esempio l’apertura delle forze armate italiane alle donne 16 anni fa. Oggi ci sono donne comandanti, autiste di carri armati, bersagliere, alpine, paracadutiste e astronaute. In tutti questi casi secondo me diventa obbligatorio usare il femminile e se il femminile ancora non esiste provare a femminilizzare il nome maschile facendo esperimenti e vedendo quale termine la comunità linguistica accetterà. Un’azione orientata a modificare gli usi linguistici può porsi l’obiettivo di far emergere il femminile dove è possibile a partire dalle aree semantiche collegate alle professioni e alle cariche istituzionali. Femminilizzazione che deve fare i conti con una attenta analisi delle varie risorse disponibili nel sistema linguistico. Facciamo l’esempio del suffisso – essa che è stato produttivo per formare femminili di nomi d’agente consolidati dall’uso come studentessa/professoressa/poetessa. Tuttavia il suffisso –essa è stato molte volte iper-caratterizzato in senso ironico ad es. in vigilessa per ridicolizzare la figura della multatrice autoritaria o nelle coppie semanticamente asimmetriche come console/consolessa (la moglie del console).
Le ragioni addotte per opporsi a questa strategia di femminilizzazione dei nomi di professioni e dei titoli vanno, come abbiamo già visto da 1) una presunta cacofonia delle forme femminili; 2) all’affermazione che le stesse donne che ricoprono questi ruoli preferiscono il maschile; 3) al fatto che le forme femminili non sono corrette perché è il maschile ad avere funzione neutra e inclusiva. Ci siamo già soffermate sulla prima e sulla seconda motivazione quindi, a questo punto, mi soffermerei sulla terza ragione che chiama in causa fattori linguistici, grammaticali e morfologici. La mia tesi, che si accorda con le linee guida elaborate da Cecilia Robustelli (10), è che queste nuove forme di femminili non sono agrammaticali o non costituiscono una deviazione dalla norma.
Quali sono i criteri della grammatica italiana per formare i nomi femminili?
La maggior parte dei nomi animati sono composti da una base lessicale (più un eventuale suffisso) e desinenza. Per la maggior parte dei nomi il genere grammaticale ha una corrispondenza con la terminazione in –o (maschile) e –a (femminile); ci sono poi nomi che terminano in –e e già con questi nomi si capisce che il genere, anche se è inerente al nome, non viene segnalato esclusivamente dalla terminazione, ma piuttosto dal determinante, ad esempio dall’articolo. Questo è evidente per alcuni nomi che terminano in –a. Esempi:
il segretario (maschile) /la segretaria (femminile)
il vigile (maschile)/la vigile (femminile)
il collega (maschile)/la collega (femminile)
Nel caso della femminilizzazione dei nomi in –e è attestato nella lingua l’uso del suffisso in -essa, ad esempio il professore/la professoressa. Tuttavia è ugualmente attestato un significato derogatoria del suffisso per cui nel caso di nomi non ancora entrati storicamente nell’uso, possiamo spingere – seguendo anche i consigli dell’Accademia della Crusca – per alcuni neo-femminili (11). In questa direzione vanno anche altre neo-formazioni, ma non solo neo-, di nomi femminili con terminazione in –o/–a e terminazione in –e, come la giudice, la presidente, la deputata, l’avvocata (12).
Per quanto riguarda invece l’uso del genere grammaticale nei casi di maschile generico e inclusivo il discorso si fa più delicato e difficile e non è questa la sede per approfondirlo più di tanto. Certo un approccio razionale e paritario alla questione richiederebbe che perlomeno – seguendo le Raccomandazioni di Alma Sabatini – in presenza di una maggioranza di nomi femminili rispetto a maschili gli aggettivi e i participi passati si accordino al femminile e non al maschile: *Lucia, Roberta, Nicoletta e Mario sono andate al cinema insieme. Tuttavia la lingua non è un sistema razionale e una frase come quella espressa sopra sembra (per ora?) non accettabile a un parlante soprattutto quando sono coinvolti soggetti animati. Il fatto che l’accordo sia più rigido in presenza di soggetti animati rivela tuttavia come le regole non siano indifferenti alla distinzione sessuale.
Per concludere, vorrei dire che sarebbe interessante in ambito dell’insegnamento dell’Italiano L2 di condurre una ricerca per capire come gli apprendenti percepiscano il fatto che la lingua italiana richieda di discriminare fra maschile e femminile e come percepiscano l’uso generico che si fa del maschile: le nostre studentesse e i nostri studenti avvertono un valore semantico in questo uso oppure valutano la costante differenza fra i due generi come una semplice marca di accordo morfologico, casuale e per loro particolarmente complicato?
Note
- Cecilia Robustelli (Il sessismo nella lingua italiana in Treccani.it. L’Enciclopedia Italiana) ricorda che: “Con l’espressione sessismo linguistico si fa riferimento alla nozione linguistic sexism elaborata negli anni ’60-’70 negli Stati Uniti nell’ambito degli studi sulla manifestazione della differenza sessuale nel linguaggio. Era emersa infatti una profonda discriminazione nel modo di rappresentare la donna rispetto all’uomo attraverso l’uso della lingua, e di ciò si discuteva anche in Italia soprattutto in ambito semiotico e filosofico”.
- L’ipotesi Sapir-Whorf si iscrive in un paradigma per cui il pensiero dell’individuo è determinate dalla lingua o dalle lingue che l’individuo parla. La versione “forte” dell’ipotesi afferma che tutte le azioni e I pensieri sono orientati dalla lingua e dalla cultura entro cui il singolo si muove .
- da rappresentanti del M5stelle: Brutta puttana facci un pompino a ingoio zoccola, Sta buttanazza, Succhia il cazzo troia!!!, Credo che anche questa zoccola faccia il bunga bunga con Berlusconi, Boldrini, vadi [trascrizione letterale] a fare la baldracca altrove!
- Senza arrivare ai picchi dell’ hate speech , citato sopra, rimaniamo nell’ambito del linguaggio volgare e riflettiamo sul fatto che : “Che bella gnocca” in Italia non fa scandalo, “negro” sì. La stessa cosa per le differenze di classe: non si dice più “serva” per intendere collaboratrice domestica, ma pare normale esprimersi con un “è passato un bel culo”.
- Nel caso dei nomi come soprano, contralto ecc… il maschile deriva dal fatto che sono nomi definiti nel ‘700 quando i ruoli erano interpretati da cantanti uomini.
- Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. To do this one has to have a memory like a memorandum-book. In German, a young lady has no sex, while a turnip has. Think what overwrought reverence that shows for the turnip, and what callous disrespect for the girl. Mark Twain A Tramp Abroad APPENDIX D. The Awful German Language
- Lo studio The connotations of gender (Ervin 1962) è un classico in vengono esaminati il genere grammaticale e il sistema di classificazione dei nomi e i determinanti e gli aggettivi che devono concordare con il genere del sostantivo. In molte lingue indoeuropee con genere grammaticale, la base della classificazione per referenti animati è il sesso del referente. In generale, i nomi che si riferiscono ai maschi appartengono al genere maschile e i nomi che si riferiscono alle femmine appartengono al genere femminile. Poiché i nomi che si riferiscono a entità astratte o inanimati possono appartenere sia al genere maschile o femminile (o se la lingua ha genere neutro, per il genere neutro), Ervin ha definito il genere grammaticale come “l’esempio di un sistema grammaticale imperfettamente correlata di classificazione. “
- (http://www.istat.it/it/files/2011/07/testointegrale.pdf)
- Le citazioni e gli esempi sono tratti dal libro Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile (Edizioni dell’Orso, 2013) di Stefania Cavagnoli “L’uso del maschile – dice l’autrice – non significa forse un maggior prestigio del maschile, e di conseguenza dell’uomo, sul femminile e sulla donna? La lingua non esprime sempre una realtà concreta a cui ci riferiamo, un’immagine di quello che consideriamo essere il mondo?». In altre parole, usare il maschile per indicare donne impegnate in professioni e in cariche politiche e amministrative rivelerebbe quanto per l’opinione pubblica sia scontato che a svolgerle sia un uomo. “L’obiettivo del volume – spiega Stefania Cavagnoli – è quello di affrontare un tema relativamente nuovo, quello del rispetto della lingua di genere, e spesso considerato di minor importanza rispetto ad altre ricerche sulla lingua e sui linguaggi, cercando di dimostrarne la centralità in vista di modifiche più sostanziali, di cui la lingua è portatrice”.
- Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, 2012, Progetto Accademia della Crusca e Comune di Firenze.
- La Crusca risponde (dalla carta al web) 1995-2005,a cura di M.Biffi e R.Setti 2013 in occasione della cui pubblicazione Nicoletta Maraschio, all’epoca presidente dell’Accademia, ribadisce “l’opportunità di usare il genere grammaticale femminile per indicare ruoli istituzionali (la ministra, la presidente, l’assessora, la senatrice, la deputata, ecc.) e professioni alle quali l’accesso è normale per le donne solo da qualche decennio (chirurga, avvocata o avvocatessa, architetta, magistrata ecc.) così come del resto è avvenuto per mestieri e professioni tradizionali (infermiera, maestra, operaia, attrice, ecc.).
- Ad esempio “avvocata” si trova nel Salve Regina, preghiera mariana dell’XI secolo scritta in latino e poi adottata dalla liturgia cattolica in italiano dopo il Concilio vaticano II: “Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.”
BIBLIOGRAFIA
Biffi M., Setti R. (a cura) 2013. La Crusca risponde (dalla carta al web 1995-2005). Firenze, Le Lettere.
Chini, M. 1995. Genere grammaticale e acquisizione. Aspetti della morfologia nominale in italiano. Milano, Franco Angeli.
Corbisiero F., Maturi P., Ruspini E. (a cura) 2016. Genere e linguaggio. I segni dell’uguaglianza e della diversità. Milano, Franco Angeli.
Dragotto F. (a cura) 2012. Grammatica e sessismo. Questione di dati? Roma, UniversItalia editrice.
Dragotto F. (a cura) 2015. Grammatica e sessismo 2. Lavori del seminario disciplinare (2014-2015). Roma, UniversItalia editrice.
Ervin, S.M. 1962. The connotations of gender, «Word», 18. 1962. 249-261
Lepschy, G. 1989. Lingua e sessismo in Nuovi saggi di linguistica italiana. Bologna Il Mulino.
Luraghi S., Olita A. (a cura) 2006. Linguaggio e genere. Grammatica e usi. Roma, Carocci.
Osgood, C.E., Suci, G., & Tannenbaum, P. 1957. The measurement of meaning. Urbana, IL University of Illinois Press
Renzi L. (a cura) 1988. Grande grammatica di consultazione. Volume I. La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna, Il Mulino.
Robustelli C. 2012. Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo. Progetto Genere e linguaggio svolto in collaborazione con l’Accademia della Crusca. Firenze, Comune di Firenze, scaricabile da http://unimore.academia.edu/CeciliaRobustelli .
Sapegno M.S. (a cura) 2010. Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole. Roma, Carocci.
Sapegno M.S. (a cura) 2014. La differenza insegna. La didattica delle discipline in una prospettiva di genere. Roma, Carocci.
Simone, R. 1990. Fondamenti di linguistica, Roma – Bari, Laterza.
Villar, F. 1987. Gli indoeuropei e le origini dell’Europa. Bologna, Il Mulino.
Violi P. 1986. L’infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio, Verona, Essedue edizioni.
Wienold, G.1967. Genus und Semantik., Meisenheim am Main Glan Verlag
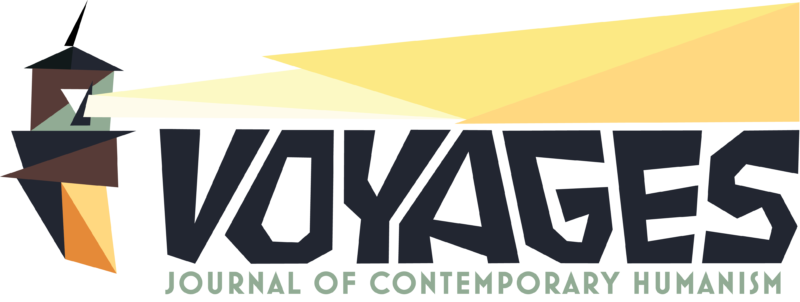

You must be logged in to post a comment.