
Photo credit: Alessandra Capodacqua
Finché c’è guerra c’è speranza…
Finché c’è guerra c’è speranza. Di certo per il cinema. Se ci si volta indietro e si getta uno sguardo anche molto distratto all’immensa produzione del «secolo breve» (senza però trascurare i primi quindici anni del terzo millennio), è impossibile non rendersi conto di come la settima arte non abbia mai smesso di nutrirsi di orrori tappandosi il naso di fronte alle peggiori tragedie su scala planetaria pur di trovare soggetti accettabili per imbastire storie che vendessero.
Prova ne sia che a partire dagli scontri interrazziali e dalle pulizie etniche ante litteram descritte nell’Antico Testamento o anche dalle scaramucce dell’era micenea ingigantite a dimensioni archetipali dall’epos omerico[1] per arrivare fino alle emorragie umanitarie dei giorni nostri passando per il Medioevo di cartapesta reinventato a Hollywood[2], non c’è conflitto o disastro socio-economico connesso a una qualche guerra che tanto il cinema sia a stelle e strisce quanto quelli più culti al di qua dell’Atlantico fino all’estremo Oriente non abbiano vampirizzato per far fronte alle fin troppo frequenti crisi d’ispirazione che ne hanno afflitto le rispettive macchine del business negli ultimi decenni.
Può forse sembrare banale l’affermarlo, ma non è eccessivo il sostenere che quasi tutti i più grandi classici del cinema mondiale abbiano un debito più o meno diretto con situazioni di conflittualità che hanno regalato spunti decisivi per lo sviluppo di sceneggiature poi divenute pietre miliari nella storia del cinema stesso. A tale proposito bastino gli esempi di due generi di culto come il western e la fantascienza intesa in senso lato. Anche se percepito come l’esaltazione inizialmente acritica e trionfalistica del mito della frontiera e della volontà di potenza dell’espansionismo nordamericano verso i paradisi presunti dell’occidente, il western in quanto genere cinematografico a sé stante non avrebbe mai potuto esistere se la lenta e inarrestabile avanzata della cosiddetta civiltà non avesse dovuto ricorrere alla ferramenta pesante e a veri e propri percorsi di pulizia etnica per favorire la propria penetrazione verso le coste ovest del continente decimando le comunità dei nativi prima di ingabbiarle nei ghetti a cielo aperto comunemente noti come riserve[3].
Ancora più emblematico a questo riguardo può forse risultare il caso della fantascienza. Nato come genere in cui la componente visionaria dell’avvenirismo scientifico di matrice letteraria unita a un marcato gusto per i viaggi avventurosi di ambientazione esotica faceva da elemento pivotale intorno al quale ruotava buona parte degli script fin dai tempi del pionierismo del muto[4], ben presto gli autori del cosiddetto cinema di anticipazione si accorsero di quanto fosse penalizzante il dover circoscrivere la propria creatività all’àmbito riduttivo dell’invenzione di mondi possibili o limitarsi a confezionare opere di mero intrattenimento incentrate su viaggi nello spazio e nel tempo o ancora su fanta-demiurgie biologiche di scienziati folli ma ansiosi di entrare in competizione con la Natura per ricreare in proprio il segreto della Vita[5]. Negli anni ’50, sulla scorta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale appena conclusasi con la catastrofe nucleare in Giappone[6], il genere conobbe una sorta di rifondazione radicale: a viaggiare nei recessi dello spazio remoto sulle ali della fantasia più sbrigliata non erano più gli umani assetati di avventure della mente, bensì creature provenienti da altri pianeti e da altri sistemi paralleli a quello noto per lo più animate da intenzioni bellicose spesso portare alle estreme conseguenze della missione di sterminio totale[7]. Un modello — quello della guerra proiettata in futuri possibili e verisimili — incentrato ancora una volta sulla riproduzione di scenari realistici e di eventi realmente avvenuti[8].
Se si eccettua forse il musical (ma anche lì vi sono importanti eccezioni[9]), non c’è genere cinematografico che non abbia fatto le sue fortune creative attingendo a piene mani a guerre mondiali, conflitti intestini, rivoluzioni sfociate in successi decennali oppure represse nel sangue, pulizie etniche, barbarie coloniali su ampia scala, regimi autoritari, violenza terroristica, e chi più ne ha ne metta.
Al punto che il genere bellico, già di per sé oltremodo ipertrofico per la quantità di titoli che vi si possono ascrivere e che non hanno mai smesso di essere sfornati aggiornandone nel corso dei decenni le componenti topiche e le infinite varianti possibili su temi rigorosamente dati, vanta ormai una ricchissima proliferazione di veri e propri sottogeneri che hanno assunto vita propria. Fino a diventare a loro volta contenitori autonomi quasi del tutto scollegati dalla matrice di provenienza, pur mantenendo con essa legami indissolubili costantemente cementati dal comune denominatore dello scontro tra esseri umani e di tutti gli effetti collaterali concausati da tali frizioni portate alle estreme conseguenze.
Uno dei tanti sottogeneri nati per filiazione diretta all’interno del macro contenitore bellico è per l’appunto quello — ugualmente tanto dilatato e vasto quanto lo sono la varietà e le caratteristiche dei conflitti presi in esame — in cui si possono iscrivere a pieno titolo tutti quei titoli che prescindono dall’affrontare in maniera diretta una guerra ma ne sfruttano narrativamente gli effetti collaterali per raccontare la devastazione materiale nelle cose e quella psicofisica negli esseri umani (ovvero lo scotto pagato da ogni comunità al termine di qualsivoglia scontro che l’abbia vista contrapposta a una qualche nemica). Ma anche a questo riguardo — a conferma di come spesso il tentativo di categorizzare la produzione cinematografica riducendola a comparti stagni sulla base dei temi affrontati sia un gioco di matriosche destinato a lasciare il tempo che trova — si dovrebbero effettuare i dovuti distinguo legati a diversi momenti storici ma anche a specifiche condizioni ambientali che abbiano fatto da palcoscenico a determinarti conflitti. Al punto che per ricchezza di prodotti sfornati e per eccellenza di esiti artistici raggiunti si finisce col parlare di sotto-sottogeneri in grado di vivere di vita autonoma propria e di definire una categoria indipendente basata in maniera quasi monomaniaca sullo stesso oggetto dei temi che ne caratterizzano la produzione.
Bastino due esempi quanto mai significativi per chiarire il concetto appena espresso. Tanto il filone del cinema sull’olocausto quanto quello sul reducismo in senso lato vantano ormai un numero così elevato di titoli di grande spessore da aver quasi reciso il cordone ombelicale che li legava all’origine al detonatore bellico imponendosi come sotto-generi autonomi dotati di vita propria. L’ormai sterminata filmografia[10] che fa riferimento alla Shoah in tutte le sue possibili variazioni sul tema centrale dello sterminio di massa nei campi di concentramento susseguente alla persecuzione razziale di stampo nazifascista ha ormai oscurato quella che ne è la causa prima deviando l’attenzione del pubblico dagli scenari del conflitto alla più clamorosa delle sue troppe conseguenze indirette. Più che la ricostruzione accurata dell’occupazione lampo da parte della Germania nazista di mezza Europa conta uno degli effetti collaterali più devastanti che ne sono stati l’effetto indiretto: e cioè il progetto goebbelsiano di sterminio finale che non avrebbe mai visto la luce né sarebbe stato portato a tragico compimento se non fosse stato preceduto dall’avanzata vittoriosa delle truppe della Wermacht.
Lo stesso dicasi per il cosiddetto cinema del reducismo: pur non essendo il conflitto in Vietnam[11] la sola guerra che abbia determinato questo fenomeno di disintegrazione antropologica in soggetti devastati nell’intimo e perciò incapaci di rientrare a pieno diritto nel circuito funzionale della società civile, il numero di lungometraggi dedicati al tema[12] è così preponderante da aver oscurato in toto ogni altra forma di attenzione cinematografica alla tragedia del rientro a casa e del difficile reinserimento nell’ambiente di provenienza. Ma anche in questo àmbito le battaglie di anime piagate e di spettri travestiti da esseri umani in lotta per riconquistare una propria dignità contro la ferocia di un mondo che ha costruito le garanzie del proprio benessere futuro sui sacrifici passati di quelle stesse anime che relega ai margini hanno progressivamente oscurato la vera causa scatenante e la ragione prima di un’emarginazione altrimenti inconcepibile. La guerra in Vietnam passa in secondo piano rispetto agli effetti collaterali causati a migliaia di chilometri e di giorni di distanza dai luoghi e dai tempi in cui si è svolta: al punto che il grande cinema sulla «sporca guerra» yankee nel sudest asiatico non è quello che ha raccontato e racconta ancora oggi il conflitto nel suo svolgersi battaglia dopo battaglia nel fitto della giungla vietnamita, bensì quello che obbliga il pubblico a confrontarsi con gli orrori del dopo e con l’atteggiamento farisaico di chi la guerra l’ha voluta rifiutando poi di occuparsi concretamente di quanti la guerra l’hanno combattuta davvero.
A questa logica dello sfruttamento sul grande e anche sul piccolo schermo dell’orrore post-bellico e dei sommovimenti di massa causati in maniera più o meno indiretta dai conflitti in giro per il mondo non è sfuggita nemmeno la tragedia dei migranti che ormai da anni approdano a diverso titolo e per differenti concause sulle coste di Lampedusa[13] (coi non pochi aspetti collaterali che possono fare da ferale contorno a quella che ormai tutti gli organismi internazionali non esitano a definire «emergenza umanitaria»). Presenza costante a tutti i livelli nel mondo dell’informazione soprattutto di casa nostra per evidenti ragioni di contiguità geografica e di urgenza di soluzione politica, la tragedia degli approdi clandestini sulle coste delle isole pelagie e di Lampedusa in particolare ha però ormai anestetizzato le coscienze dei fruitori di quei diversi canali di distribuzione mediatica convertendosi da shock emotivo in fastidiosa abitudine, e finendo così col diventare ciò che gli effetti collaterali di decine di altre guerre in giro per il pianeta sono stati fin dai primordi di vita del cinema. E cioè fonte di possibile ispirazione al punto da fornire addirittura spunti per quella forma di parziale retrocessione estetico-artistica che in certi casi è la serialità televisiva di casa nostra.
Terraferma tra lirismo fiabesco e ansia di denuncia
A fine primavera del 2010, mentre gli sbarchi di clandestini sulle coste del paradiso lampedusano non accennavano a diminuire per frequenza e numeri non ostante la cosiddetta «politica dei respingimenti» adottata dal governo italiano in carica a partire dal 2009[14] (ma comunque prima che l’emorragia del conflitto civile in Siria e il terrore seminato dal sedicente califfato dell’Isis trasformasse questi approdi ciclici in una delle tante declinazioni possibili dei viaggi della disperazione verso il miraggio dell’asilo europeo nell’ambito della vera e propria emergenza umanitaria ormai tristemente nota a tutti[15]), Emanuele Crialese sceglie l’arcipelago delle Pelagie per girare in dodici settimane di lavorazione quello che sarebbe diventato il quarto lungometraggio di una filmografia a tutt’oggi non particolarmente ricca ma capace di regalargli notorietà internazionale grazie soltanto a due titoli del calibro di Respiro e Nuovomondo.
Basato su un soggetto originale che a sua volta non fa riferimento a un qualche episodio particolare realmente accaduto nelle vicine immediatezze cronologiche, il film sfrutta lo spunto degli sbarchi e il dolente rosario di sofferenze che ne fa da inevitabile corollario per innestarli su una vicenda di finzione costruita a orologeria per fare da contraltare narrativo alla tragedia umanitaria costantemente sullo sfondo. Al centro della vicenda c’è infatti una famiglia di pescatori isolani dal vago sapore verghiano i cui membri sono in lotta tra la rispettosa osservanza dei valori tradizionali e l’urgenza di adeguarsi al presente convertendosi alle leggi di mercato (vedasi lo sfruttamento turistico delle bellezze locali) per evadere da una logica arcaica di arretratezza destinata a travolgere chi non voglia assecondare l’incombere della modernità.
Da una parte ci sono il patriarca Ernesto e il nipote ventenne Filippo (rimasto orfano dopo aver perso in mare il padre) a passarsi il testimone nel loro ideale ruolo di paladini della tradizione e del senso di appartenenza alla terra che ha visto soffrire generazioni di loro antenati combattendo con le forze avverse della Natura. Dall’altra ci sono invece il figlio Nino e la nuora Giulietta, rispettivamente zio e madre vedova di Filippo, i quali sono invece decisi l’uno a convertire la secolare attività peschereccia in business per turisti del nord e l’altra a spiccare il volo verso il continente nell’illusione di potersi rifare una vita a risarcimento postumo di un’esistenza di stenti e delusioni.
È questo lo scenario su cui Crialese innesta l’elemento narrativo destinato a fare da bilanciamento serioso e impegnato di una vicenda di pura finzione che si abbevera alle fonti del Neorealismo ma che ha bisogno di un’iniezione di realtà autentica per scrollarsi di dosso la patina di patetismo bozzettistico sotto la quale avrebbe rischiato di soffocare. Fin dalla solenne sequenza di apertura con la telecamera che inquadra dal di sotto della superficie dell’acqua quelli che poi si capiscono essere resti di un barcone finito in frantumi in uno dei tanti sbarchi di clandestini in zona lo spettatore viene invitato a prepararsi a un evento tragico destinato a sconvolgere le vite della famiglia protagonista sbilanciandone in maniera definitiva i già precari equilibrî interni. Si tratta soltanto di un accenno che in principio l’occhio e la mente tendono a non rubricare come un pacato segnale d’allarme circa quanto accadrà di lì a non molto. E lo stesso accade nella prima sequenza, quella nella quale il nonno Ernesto e il nipote Filippo sono costretti a rientrare in porto durante una battuta di pesca col motore in avaria dopo aver centrato in pieno i resti di un relitto alla deriva. Due indizi fanno una prova: la tragedia è alle porte e infatti non tarda ad abbattersi su nonno e nipote offrendo così il destro per un inatteso scarto nella sceneggiatura ma anche l’occasione per imprimere al bozzetto verista un piglio da cinema impegnato che permetta di trattare l’argomento attualissimo della tragedia degli sbarchi inserendola senza iati eccessivamente bruschi nel tessuto della narrazione filmica.
Dopo aver riparato la barca, nonno e nipote riprendono il largo ma invece di riempire le reti di pesce fresco con cui saziare gli appetiti esigenti dei turisti che altri membri della famiglia (zio e mamma di Filippo) coccolano imbottendoli di attività da resort turistico per evitare che vedano ciò che li circonda, si imbattono in una zattera tracimante di migranti africani che decidono di salvare quando li vedono prossimi all’annegamento e pur essendo perfettamente consci dell’arcigno diktat degli uomini della Guardia Costiera. Che, in perfetta osservanza della legge Bossi-Fini, intimano a tutti i pescherecci di non soccorrere migranti in transito onde evitare di incappare nell’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Da quel momento in poi il film perde di vista gli scenari neorealistici dai quali era partito e imbocca deciso la strada della convinta denuncia civile (sulle cui buone intenzioni non ci sono dubbi di sorta e non solo per quanto Crialese aveva fatto vedere in Respiro e Nuovomondo, ma soprattutto perché tutta la seconda parte del film non pecca di eccessi tribunizi né mostra di essere concepito freddamente a tesi). Per mettere in pratica questi nobili intenti, la sceneggiatura ricorre a un escamotage sospeso tra la scaltrezza di chi ben conosce i meccanismi con cui arrivare al cuore dello spettatore e l’urgenza di parlare di un dramma di dimensioni ormai epiche cercando però di non enfatizzarne eccessivamente i contorni: espediente questo che conferma la bontà delle intenzioni ma che allo stesso tempo scopre le carte in tavola e denuncia in maniera esplicita lo sfruttamento di una tragedia di massa a scopi (melo)drammatici. Tra i migranti che Ernesto e Filippo raccolgono a bordo sfidando le autorità marittime (che di lì a poco applicheranno la normativa vigente sequestrando loro il peschereccio e mettendo così a repentaglio la sopravvivenza stessa di parte della famiglia) c’è anche una giovane etiope in stato avanzatissimo di gravidanza e con al seguito un figlio di non più di cinque anni. Mentre uomini più forti e attrezzati alla sopravvivenza cedono di schianto stremati da mesi di stenti e dalle angustie della traversata, la donna e il bambino riescono invece a sopravvivere per miracolo.
Tratta in segreto a terra e nascosta in fretta e furia col figlio a casa della famiglia di Ernesto (non ostante le vibranti proteste della nuora Giulietta che teme ripercussioni gravi ma che vede messa a repentaglio la sua chance di costruirsi una nuova vita lasciando l’isola e partendo alla volta del continente), la puerpera non solo incrementa in maniera esponenziale le tensioni già esistenti tra i vari membri del clan in progressiva dissoluzione, ma porta anche con sé tutte le stimmate esistenziali che piagano la vita di quasi ogni giovane donna passata nell’inferno dei viaggi della speranza dalle plaghe più remote dell’Africa ai lembi meridionali dell’Europa attraverso gli inferni detentivi della Libia[16]. E cioè abusi e ricatti sessuali di ogni sorta da parte di carcerieri e scafisti, ma anche gravidanze indesiderate frutto di quelle stesse violazioni fisiche di cui sono costantemente vittima. Col procedere del film (e mentre anche il giovane Filippo ha il suo primo incontro ravvicinato con l’orrore dei migranti allo sbaraglio nelle acque del Mediterraneo quando una notte porta in giro in barca lungo le coste dell’isola una bella turista nordica ospite della casa trasformata dalla laboriosa Giulietta in dimora per turisti) e col progressivo aprirsi della donna al resto dei componenti della famiglia dopo aver dato alla luce una bambina che l’altro figlio si rifiuta di riconoscere come sorella perché sa essere il frutto di uno stupro che non è in grado di rubricare ma di cui ritiene responsabile la madre, il catalogo degli orrori si arricchisce progressivamente di elementi in accumulo. Finendo però col sembrare qualcosa di posticcio e un po’ «gridato» non ostante i dettagli dell’odissea di cui la donna è stata protagonista vengano distribuiti col contagocce e filtrati in sordina dalla difficoltà di comunicazione dovute alle barriere della lingua e all’incompiutezza dei segni che le veicolano.
Ed è proprio il personaggio di questa madre coraggio in versione africana il punto nodale dell’intera operazione tentata da Crialese in Terraferma. Deciso come già detto a coniugare il desiderio di raccontare la fine di un mondo travolto dalle bordate della modernità con l’urgenza di denunciare la devastazione interiori di milioni di individui costretti dagli eventi e dalla Storia a rinunciare a se stessi nella speranza di un’ipotesi di futuro altrove, il regista e sceneggiatore di Respiro e Nuovomondo si gioca la carta del realismo spinto per nascondere quelli che forse erano i suoi veri intenti. A interpretare il ruolo di Sara, la giovane eritrea che mette al mondo una bambina nel garage della casa dove Ernesto e i suoi familiari la nascondendone rischiando la galera pur di proteggerne la vita, non è un’attrice professionista bensì una delle poche sopravvissute di uno dei tanti viaggi della morte che dal Corno d’Africa portano alle coste di Lampedusa e che nel suo caso la costrinse a vedere morire più di settanta compagni di viaggio sopravvivendo miracolosamente e riuscendo a ricongiungersi col marito già in Italia da tempo.
L’operazione è però la conferma di un azzardo. Come accadeva negli altri suoi due celebrati titoli (rispettivamente del 2002 e del 2006), anche in Terraferma Crialese non riesce a resistere alle sirene di una sorta di realismo «magico» all’italiana che ne ha caratterizzato fin dai primi passi l’estetica filmica come una specie di marchio di fabbrica. Per quanto buone possano essere state le sue intenzioni di denunciare non solo gli orrori delle migrazioni indotte non da ragioni di urgenza economica bensì da mere istanze di sopravvivenza in contesti che mettono a repentaglio la vita stessa negando ogni forma di futuro ma ugualmente l’ottusità di norme iper-restrittive in materia di immigrazione in vigore nel nostro paese, Terraferma fluttua in un continuo slittamento tra la violenza della realtà che ci circonda e la seduzione di un’alterità fiabesca in cui rifugiarsi per negare l’invadenza cruda di quella stessa autenticità che si vorrebbe raccontare.
E a riprova di questo sta il fatto che il film (girato interamente a Linosa anche se il nome dell’isola non viene mai menzionato) parla sì delle realtà feroci degli sbarchi e di tutto il corollario di orrori che ne accompagna l’ormai nota liturgia, ma fa al contempo di tutto per scrollarsela di dosso evadendo in una dimensione così impalpabile e altra rispetto al mondo di sotto da far quasi pensare a un’allegoria priva di riferimenti concreti all’hic et nunc dell’oggi. Prova ne sia che la famiglia protagonista del film non ha un cognome così come priva di un nome e di toponimi definiti è l’isola che li vede sbattersi per (ri)conquistarsi un posto al sole come risarcimento del bene fatto a quanti conoscono solo il Male del mondo. Tutto sconfina nei territori dell’archetipico con pericolosi sbandamenti verso la dimensione del mito.
Se ci fossero ancora dubbi residui sull’uso lirico che viene fatto di un tema tanto tragico quanto quello degli sbarchi a Lampedusa (mai menzionata non ostante lo spettatore sappia di dover pensare a quel lembo di terra solo in virtù della mera associazione di idee tra quanto noto perché visto con troppa insistenza in TV e il palcoscenico geografico in cui lo show dell’orrore quotidiano si svolge), a fugarli in massa interviene il lungo piano sequenza con cui il film si chiude: dopo aver tentato invano di imbarcarsi con a bordo la giovane etiope, i due figli di lei, la madre e il nonno malato eludendo gli occhiuti controlli di Guardia Costiera e autorità di Polizia a caccia di clandestini, Filippo decide di impossessarsi di nascosto del peschereccio di famiglia ancora sotto sequestro e di partire alla volta di quello che potrebbe essere un nuovo viaggio della speranza verso i territori inesplorati del futuro. Ma invece di seguire la barca che lascia le coste dell’isola e si dirige verso quelle continentali del paese dando così l’impressione che si stia per assistere all’inizio di una nuova odissea marittima da sovrapporre a quella ben più tragica narrata dalla donna etiope, l’immagine si allontana progressivamente verso l’alto e finisce – ormai lontana chilometri dal cobalto un po’ minaccioso della superficie del mare – per convertire il peschereccio in un puntino perso in quell’immensità remota. Come se i suoi occupanti fossero i protagonisti di un epos in minore pronti ad affrontare con coraggio favolistico le asprezze della Vita, e non i resti malconci di tanta miseria terrena destinata a fornire costanti spunti di alterco incivile nei salotti buoni della TV di casa nostra.
Ogni cosa è illuminata (specie se a Lampedusa e in versione docufiction)
A distanza di quasi cinque anni dall’uscita nelle sale di Terraferma, un altro cineasta è tornato ad affrontare di petto il tema dell’esodo umanitario verso le coste di Lampedusa. Trattandosi però di un autore dello spessore di Gianfranco Rosi siamo però lontani anni luce dal lirismo fiabesco di Crialese (pur condividendo con il regista romano di origini siciliane sia il tema trattato che il desiderio intimo di sensibilizzare il pubblico su un argomento tanto delicato quanto abusato dai mass media e dallo sfruttamento televisivo col fine subdolo di gonfiare gli ascolti spingendo sul pedale del patetismo a tutti i costi). Soprattutto per il tipo di approccio alla materia trattata che per Rosi è sempre stato quello del documentarista radicale che prescinde dalla pietas della partecipazione attiva ed emotiva alla narrazione, lasciando invece che l’occhio freddo e distaccato della telecamera registri l’oggetto della sua analisi e cementi un legame profondo tra chi quella realtà la racconta e chi ne deve ricevere la chirurgica notomizzazione in immagini, spesso violenta come un pugno ben dato al plesso solare.
Un metodo di autentica immersione totale che forse sarebbe ormai opportuno chiamare «metodo Rosi». Perché è così che Gianfranco Rosi ha sempre lavorato sin dagli inizi della carriera nel testardo tentativo di raccontare la realtà che lo circonda documentandone le storture con occhio vigile e asettico, lasciando che sia lo spettatore a prendere posizione senza mai sentirsi influenzato dalle prese di posizione più o meno autorali di chi tiene in mano la macchina da presa e poi monta ore e ore di girato. Un metodo questo che Rosi ha puntualmente applicato anche in Fuocoammare, sua ultima fatica documentaristica dedicata all’emergenza umanitaria che gli abitanti di Lampedusa vivono da oltre vent’anni come se fosse per loro l’ordinaria quotidianità mentre agli occhi del resto del mondo appare giorno dopo giorno la resistenza strenua di un manipolo di eroi abbandonati dalle istituzioni e dall’Europa a combattere con l’emorragia dei migranti che convergono sull’ultimo lembo del vecchio continente in cerca di un lasciapassare verso la dignità perduta.
Un metodo che adotta appunto la tecnica dell’immersione totale nelle cose coniugando la sofisticazione documentaristica con la capacità di mimetizzarsi tra gli «attori» delle storie raccontate senza far mai percepire la propria presenza. E soprattutto senza mai accettare le regole del documentario «mordi-e-fuggi» da pseudo inchiesta televisiva nata per il format della TV. Un approccio questo che ha però ormai dimostrato non solo di essere il marchio di fabbrica di un autore degno di questo nome, ma di ripagare con gli interessi per tutti i sacrifici produttivi e realizzativi che esso comporta.
Al punto che, dopo aver vinto del tutto a sorpresa il Leone d’oro a Venezia 2013 con Sacro GRA, Rosi si è regalato un record mai toccato ad alcun suo collega nel campo del cinema documentaristico: unico titolo italiano in concorso all’ultima edizione della kermesse berlinese e pur essendo solo un documentario, Fuocammare ha infatti vinto l’Orso d’Oro ed è entrato ufficialmente — nei giorni in cui il presente articolo è stato scritto — a far parte della cinquina di titoli che si contenderanno la statuetta per il miglior documentario nella notte degli Oscar di Los Angeles (non dopo aver però trascorso un intero anno a rastrellare ogni sorta di premi e riconoscimenti in giro per il mondo). Così che Rosi è adesso il solo autore vivente ad aver vinto a distanza di due soli anni i premi come miglior film in due delle principali vetrine del cinema europeo, sbaragliando però la concorrenza di importanti e ben più facilmente fruibili titoli di finzione.
E dire che Fuocoammare, come anche per gli altri quattro documentari finora girati da Rosi, non aveva certo avuto una genesi tanto facile. Giunto per la prima volta a Lampedusa nell’autunno del 2014 col progetto di girarvi un semplice cortometraggio, il regista nato all’Asmara e poi formatosi cinematograficamente a New York si era sentito come respinto dalla realtà estrema dell’isola, sempre sospesa tra la voglia di una normalità negata e l’emergenza degli sbarchi[17] convertita in ordinarietà dolorosa del quotidiano abituale. Ma dopo essere stato al centro sanitario per curare una bronchite, lì Rosi conobbe Franco Bartòlo, il solo medico operativo sull’isola e da quasi 30 anni testimone accorato dei destini di un mondo alla fine del mondo ma soprattutto della lunga scia di morte a credito che il sogno di una vita migliore non ha mai smesso di lasciarsi alle spalle in tre decenni di derive umane trascinate dal mare e da mezza Africa in fuga da se stessa sulle coste di Lampedusa.
E se Fuocoammare (titolo che trae spunto da una celebre canzone popolare siciliana che si sente a un certo punto nel corso del film) è diventato realtà, Rosi lo deve proprio al Dottor Bartòlo, destinato a diventare una delle star dolenti e involontarie del film stesso. Avendo visto e apprezzato Sacro GRA, fu proprio lui a consegnarli una chiavetta USB piena di documenti fotografici e video relativi alle sue penose esperienze di medico in occasione di decine e decine di salvataggi e tragedie sul mare. Colpito dall’agghiacciante materiale contenuto in quella chiavetta, Rosi decise così di tornare a Lampedusa dove ha poi vissuto per diciotto mesi documentando giorno dopo giorno con la propria cinepresa quella presunta normalità all’insegna dell’emergenza che è la vita dell’esigua comunità residente sull’isola. Un piccolo manipolo di eroi di resistenza umana chiamati ad accettare l’idea di dover vivere in un lembo estremo di mondo convertito dalle leggi della Storia nel portale di accesso a uno straccio di speranza in un domani possibile.
Più complesso nella struttura di quanto non fossero i precedenti lavori di Rosi, Fuocoammare è costituito dal continuo sovrapporsi di diversi assi narrativi: da una parte c’è la cronaca neutralmente oggettiva della vita del dodicenne Samuele (appassionato di caccia agli uccelli con una fionda fai date) e di alcuni membri della sua famiglia e della comunità isolana, e dall’altra la descrizione fredda e distaccata di uno dei tanti sbarchi di cui si seguono le varie fasi dall’avvistamento in mare aperto a notte fonda fino alla schedatura dei sopravvissuti e al loro collocamento nel ribollente centro di prima accoglienza attivo da anni sull’isola.
Ed è proprio l’alternarsi tra l’ordinaria quotidianità dell’esistenza di Samuele e degli altri membri della comunità isolana e l’insorgere quasi quotidiano dell’emergenza dovuta agli arrivi via mare degli «altri» a rappresentare l’elemento di maggiore impatto emotivo per lo spettatore[18]: anestetizzati come ormai siamo a forza di veder scorrere nei TG immagini sempre uguali di barconi carichi di migranti allo stremo corredate dalla contabilità obitoriale di quanti non ce l’hanno fatta, la documentazione programmaticamente oggettiva che Rosi offre di questa tragedia umanitaria colpisce come un pugno nello stomaco proprio perché illustra senza mai commentare. Lasciando che a farlo siano la cronaca asettica di ogni morte annunciata e le testimonianze di quanti sull’isola hanno ormai appreso a convivere col dolore di troppe vite spezzate dall’inconsistenza di un sogno.
Pur potendo dare l’impressione di volerlo fare in maniera programmatica, Rosi (che ha dedicato alla comunità di Lampedusa e alla sua terra l’inatteso Orso d’Oro vinto a Berlino) non sceglie mai la strada della denuncia retorica come spesso accade in tanti documentari visti in TV sullo stesso tema: il suo è un cinema di identificazione radicale col soggetto trattato all’insegna di quello che dovrebbe essere lo spirito più autentico del genere di appartenenza. E cioè la determinazione a risvegliare le coscienze di chi guarda senza mai far credere di voler scatenare la lacrima facile col ricorso all’immagine di forte impatto visivo, limitandosi invece a mostrare con l’occhio della telecamera ciò che tutti guardano ma fingono di non vedere. Uno spirito questo magnificamente compendiato dal lungo monologo di potenza scespiriana[19] che il Dottor Bartòlo pronuncia di fronte all’immagine di uno dei tanti barconi della disperazione su cui è stato chiamato negli anni a esercitare la propria professione di medico tuttofare. Senza un copione né alcuna imbeccata del regista che lo sta inquadrando, questo eroe del silenzio dice che in molti potrebbero pensare che anni di assuefazione al dolore e alla morte (specie di fronte a vite falciate nei loro anni più innocenti) lo abbiano abituato vaccinandogli il cuore e sterilizzandogli la mente. Fisso sull’immagine del barcone stracarico di vite alla deriva e col singhiozzo che gli strozza la voce in gola, come un personaggio sfuggito a una tragedia sofoclea il Dottor Bartolo confessa che a tutto ci si può abituare «ma non a quello».
Crialese e Rosi condividono la stessa materia pur affrontandola in maniera diametralmente opposta (al punto che vi sono alcune scene di Fuocoammare che sembrano quasi ricalcare a titolo di citazione involontaria altrettanti momenti di Terraferma di cui però diventano immediatamente il contraltare doloroso perché documentano l’orrore mentre si compie e non si limitano a sfruttarlo a fini drammatici[20]): da una parte c’è lo sfruttamento lirico di una tragedia immane inserita in un contesto narrativo del tutto alieno a quella tragedia stessa, mentre dall’altra c’è l’occhio scrutatore di un chirurgo del reale che col suo cinema dello sguardo indaga in prima persona sulle grandi e piccole storie che intende raccontare e — come nel caso dell’esodo verso le coste di Lampedusa — le affranca dalla patina di déja-vu che le ammanta rendendole nuove e penosamente vere pur avendole ricevuto già più che lise dall’urgenza della cronaca. Nel suo documentario non c’è aria di sfruttamento alcuno a fini spettacolari. Anche se la presenza degli isolani e la documentazione oggettiva del loro vissuto quotidiano potrebbe far pensare all’ipotesi di un docufiction orchestrato con scaltrezza per far estrarre i fazzoletti dalle tasche, questa presenza antropologica va interpretata come la semplice documentazione dello stato delle cose in un mondo che insiste nel procedere per la propria strada senza apparentemente curarsi dell’immane tragedia che da anni fa da colonna sonora alle vite dei locali: quando Rosi (nessuno sa bene come questo sia stato possibile) si infila con la telecamera negli anfratti fetidi di uno dei barconi dove gli uomini della Guardia Costiera stanno estraendo veri cadaveri che l’odissea in mare e le troppe privazioni hanno accumulato nella stiva della carretta, pur avendole già viste decine e decine di volte in altrettante clip mandate in onda dai telegiornali e rivisitate fino alla nausea sui siti web, lo spettatore annichilisce perché sa che le immagini di quelle buste nere sono la prova inconfutabile di vite spezzate dietro l’uscio di casa.
Lampedusa: vedi alla voce TV.
Data la grande e involontaria popolarità (ci si consenta la terminologia del tutto irrispettosa di fronte alle dimensioni di questa immensa tragedia senza fine) del tema degli sbarchi sulle coste di Lampedusa, sembrava impossibile che la serialità televisiva non individuasse i margini di un possibile sfruttamento sul piccolo schermo di una vicenda che pare orchestrata apposta per garantire buoni ascolti in prima serata senza curarsi minimamente di degradare così a spunto di fiction lucrosa una delle più grosse emergenze umanitarie che l’Europa — e l’Italia ancora più nello specifico — abbia dovuto fronteggiare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri.
Cosa che è puntualmente avvenuta anche se la genesi della miniserie TV Lampedusa — Dall’orizzonte in poi prodotta dalla Rai non è stata affatto facile così come il suo percorso all’interno della programmazione dei palinsesti della TV generalista di Stato. Girata nel 2014[21] in parte a Lampedusa ma soprattutto a Roma e al largo di Civitavecchia (dove sono stati rispettivamente ricostruito il Centro di Prima Accoglienza dell’isola — CPA — e girate tutte le sequenze in mare aperto[22]), questa fiction di grana grossa è stata poi trasmessa su Rai1 in due puntate in prima serata il 20 e il 21 settembre del 2016. Ovvero con due anni di ritardo rispetto all’epoca delle riprese, a conferma di come forse i vertici del servizio pubblico non fossero particolarmente impressionati dal prodotto e aspettassero un momento di stanca nella programmazione come appunto l’inizio di stagione a metà settembre per lanciare un teleplay di cui forse non erano più troppo convinti dopo averne visto la conversione in sceneggiato per il piccolo schermo a partire da un’idea originale che poteva forse essere apprezzabile.
Anche in questo non è sbagliato parlare di buone intenzioni nella genesi creativa del progetto. Che era nato da una proposta fatta direttamente ai vertici Rai dall’attore Claudio Amendola (poi riservatosi il ruolo dello stropicciato protagonista maschile nei panni di un sottufficiale di Marina trasferito a Lampedusa per motivi disciplinari) a seguito della visione di un programma in TV nel quale un vero ufficiale della Guardia Costiera raccontava di un miracoloso salvataggio cui aveva partecipato col proprio equipaggio nel 2008 riuscendo coi suoi uomini a far scampare da morte sicura seicento naufraghi intercettati a bordo di cinque carrette ormai prossime all’affondamento.
Da quella idea di partenza, affidata alla penna di due professionisti del calibro di Andrea Purgatori e Laura Ippoliti, si era subito pensato a una miniserie in due puntate al centro della quale vi fosse l’incrociarsi delle vicende umane e professionali del summenzionato maresciallo e della responsabile del CPA di Lampedusa, incastonandole nel cuore pulsante della narrazione. E cioè la lotta quotidiana delle forze dell’ordine preposte alla vigilanza sulle acque territoriali italiane e impegnate a barcamenarsi tra il rispetto delle norme vigenti e l’urgenza di salvare ogni giorno decine di naufraghi disperati da affidare poi al CPA locale nell’attesa di essere smistati in vari altri punti di raccolta del paese per le rituali procedure di identificazione. Il tutto proiettato sullo sfondo dell’altra Lampedusa, ovvero il paradiso vacanziero al centro del Mediterraneo violato dallo tsunami degli approdi di migranti in massa e per questo in costante flessione di presenze estive con susseguente crisi del settore della sempre trainante industria turistica locale (qui rappresentata da Ninì Bruschetta nei panni dell’untuoso direttore di uno dei più importanti hotel dell’isola, sempre pronto a gettare benzina sul fuoco ogni qual volta i concittadini Lampedusani danno segni di insofferenza perché esasperati dallo stato delle cose in atto).
Decisi ad ambientare la vicenda ai giorni nostri, sceneggiatori e regista (Marco Pontecorvo, figlio del grande Gillo e noto direttore della fotografia negli USA in superproduzioni hollywoodiane prima di passare a sua volta dietro la macchina da presa alternando passi falsi quali il recente Tempo instabile con probabili schiarite a vere e proprie marchette TV del calibro de L’oro di Scampia e La ragion di Stato), accortisi che quanto avevano intenzione di raccontare non corrispondeva più allo stato dei fatti e nulla a Lampedusa aveva più i contorni della tragica concitazione quotidiana che l’ultima versione dello script presupponeva, avevano poi deciso di retrodatare il tutto ambientando l’intera vicenda nel 2010. Ovvero proprio nello stesso periodo in cui si svolgono i fatti al centro di Terraferma di Crialese.
Le intenzioni erano quindi veramente delle migliori, visto che il proposito di base era quello di mescolare accuratezza filologica nella documentazione sullo stato dell’arte nel mondo della migrazione clandestina a Lampedusa a un’attentissima ricostruzione degli ambienti in cui girare (vista l’impossibilità tanto di accedere al CPA vero e proprio per realizzare dal vivo le molte scene ambientate al suo interno quanto lo sfruttamento di molti altri punti dell’isola risultati off limits per via della stagione turistica in pieno svolgimento). Fino a spingersi a inserire nel tessuto della narrazione sequenze che si svolgono invece in Libia e affrontano con coraggio un aspetto laterale di non secondaria importanza troppo spesso trascurato in (quasi) tutti i prodotti che al cinema e in TV abbiano trattato negli ultimi anni il tema della migrazione clandestina dalle coste dell’Africa ai lembi di Europa più prossimi (e quindi non solo l’arcipelago delle Isole Pelagie e il meridione nostrano in genere, ma anche i passaggi obbligati delle due enclavi spagnole in Marocco Ceuta e Melilla, le Cicladi orientali, Creta e la Grecia continentale). E cioè l’orrore della detenzione negli improvvisati centri di raccolta in vari punti del Golfo della Sirte libico dove trafficanti senza scrupoli (tratteggiati nella miniserie TV della Rai con fattezze e rudi modalità comportamentali da stereotipati villain tipici di certi action movie a stelle strisce per palati non troppo fini) ammassano i profughi in attesa di imbarco verso l’Europa trattenendoli a volte anche per mesi e uccidendo quanti si rifiutano di pagare somme extra per il passaggio sui barconi oppure violentando le donne rimaste vedove durante il viaggio o partite da sole col miraggio di raggiungere il proprio consorte già partito da tempo[23].
Come si può facilmente vedere, i temi e gli ambienti geografici sono apparentemente gli stessi affrontati prima da Emanuele Crialese in Terraferma e poi da Gianfranco Rosi in Fuocoammare. Ma in Lampedusa – Dall’orizzonte in poi il dramma dei naufraghi salvati per miracolo dal coraggio e dall’intraprendenza degli uomini della Guardia Costiera e poi rimessi in sesto dalle cure amorevoli prestate loro pur nel clima turbolento e in costante subbuglio del CPA dell’isola si converte sin da subito in irresponsabile specchietto per le allodole e mero pretesto funzionale per conquistare fette di share televisivo facendo leva sull’attualità del tema trattato e sul ricatto implicito che esso convoglia nel momento in cui viene innestato su topoi canonici della serialità televisiva. Più dei disgraziati che approdano a Lampedusa sopravvivendo alle angustie inenarrabili di viaggi che possono durare anche anni, ciò che qui conta maggiormente sono i due protagonisti e il lento viaggio di avvicinamento che li porta dalle scaramucce iniziali in stile screwball al progressivo cementarsi di un legame che nasce sull’intesa professionale e sulla comunione di vedute in materia di accoglienza per poi sfociare nel più telefonato dei finali con l’amore che trionfa e manciate di buonismo a iosa a fare da collante al tutto.
Gli ingredienti tipici delle serie TV che da ormai almeno vent’anni la Rai si ostina a sfornare cercando affannosamente di tenere il passo prima con la concorrenza dei più sgamati prodotti del pianeta Fininvest e più di recente con l’inarrivabile creatività in costante rinnovamento delle varie piattaforme di visioni on demand ci sono tutti: il cinquantenne stropicciato con cui la vita si è accanita (il personaggio del 1° Maresciallo Serra — come detto interpretato da Claudio Amendola —, segnato dalla perdita di un figlio con susseguente separazione dalla moglie nonché indisciplinato e burbero quanto basta per essere in linea coi troppi nipotini di Camilleri in costante proliferazione sul piccolo schermo) ma che nasconde nel petto un cuore nobile che lo porterà non solo a farsi amare dagli uomini della sua squadra dopo esser parso loro un orso scorbutico, ma soprattutto a costringere lo spettatore a fare il tifo per lui. Soprattutto verso la fine della seconda puntata, quando in una lunga sequenza che prelude al profluvio di volemosebene con cui la miniserie chiude i battenti, mette a repentaglio la propria vita e disattende le disposizioni dei propri superiori (un po’ come il nonno Ernesto e il nipote Filippo in Terraferma) per salvare da morte certa un nutrito gruppo di migranti finiti nelle acque in tempesta al largo di Lampedusa in una notte di tregenda ricostruita in tranquillizzanti vasche di fronte al litorale di Civitavecchia.
Ovviamente non manca nemmeno l’eroina di sesso femminile, degna contraltare del Maresciallo Serra: è Viola (che ha il volto fintamente sciupato della bellissima Carolina Crescentini), la responsabile del CPA dell’isola, ugualmente piagata nel cuore per una cronica allergia alle relazioni stabili e durature ma capace di regalare ai migranti che accoglie tutto quell’infinito amore che non ha mai saputo dare all’universo maschile (salvo poi farlo col rude Serra dopo aver battibeccato con lui per buona parte della prima puntata). E infine ci sono i migranti assiepati nel centro diretto da Viola: brutti, sporchi e cattivi quanto basta per far felici gli spettatori politicamente orientati verso l’intolleranza soprattutto nel momento in cui il gruppo eterogeneo di rifugiati inscena una manifestazione violenta (anche questa, come molti altri accadimenti riversati nella sceneggiatura, ricostruita sulla base di eventi realmente avvenuti nel CPA di Lampedusa) protestando contro le lungaggini dei processi di identificazione e il mancato trasferimento in aree meno sovraffollate e accoglienti.
Ma ovviamente – e qui siamo di nuovo in zona Terraferma e Fuocoammare – non manca nemmeno una straziante vicenda di infanzia negata e di adolescenza violata ad aggiungere un ulteriore strato di patetismo di facciata a un’operazione già di per sé fin troppo satura di elementi sovrabbondanti: separato dalla madre e dalla sorella in uno dei centri di raccolta in Libia da scafisti violenti che sembrano caricature di culturisti infoiati, il piccolo Venji si ostina a scappare dal CPA convinto di potersi ricongiungere col resto della famiglia rimasto bloccato aldilà del mare (ma che finirà col riabbracciare nel trionfo di melassa del finale quando madre e sorellina vengono salvate nella già menzionata notte di tregenda in cui il Maresciallo Serra giganteggia michelangiolesco tra i flutti salvando vite come se fosse nel mezzo di una puntata del vetusto «Giochi senza frontiere»).
Opere prese in esame:
Terraferma
Regia
Emanuele Crialese
Soggetto
Emanuele Crialese
Sceneggiatura
Emanuele Crialese, Vittorio Moroni
Fotografia
Fabio Cianchetti
Montaggio
Simona Paggi
Musiche
Franco Piersanti
Scenografia
Paolo Bonfini
Costumi
Eva Coen
Trucco
Ermanno Spera
Interpreti:
Donatella Finocchiaro: Giulietta
Giuseppe Fiorello: Nino
Mimmo Cuticchio: Ernesto
Martina Codecasa: Maura
Filippo Pucillo: Filippo
Tiziana Lodato: Maria
Claudio Santamaria: com. Guardia di Finanza
Timnit T.: Sara
Filippo Scarafia: Marco
Produzione
Cattleya, Rai Cinema, Cinesicilia, Babe Film, France 2 Cinéma, Canal+, CinéCinéma
Distribuzione (Italia)
01 Distribution
Origine:
Italia, Francia
Anno:
2011
Durata:
88 minuti
Fuocoammare
Regia:
Gianfranco Rosi
Soggetto:
Carla Cattani (da un’idea di), Gianfranco Rosi
Sceneggiatura:
Gianfranco Rosi
Fotografia:
Gianfranco Rosi, Aldo Chessari
Montaggio:
Jacopo Quadri, Fabrizio Federico
Suono:
Gianfranco Rosi
Interpreti:
Samuele Pucillo, Samuele Caruana, Mattias Cucino, Pietro Bartòlo
Produzione:
Gianfranco Rosi, Donatella Palermo, Serge Lalou, Camille Laemlé per 21uno Film, Stemal Entertainment, Istituto Luce-Cinecittà, Rai Cinema, Les Films D’ici, Arte France Cinéma
Distribuzione:
Istituto Luce-Cinecittà/01 Distribution
Origine:
Italia
Anno:
2015
Durata:
108 minuti
Lampedusa — Dall’orizzonte in poi
Regia
Marco Pontecorvo
Soggetto
Andrea Purgatori
Sceneggiatura
Laura Ippoliti, Andrea Purgatori
Interpreti:
Claudio Amendola: 1º Mar. Lgt. NP Marco Serra
Carolina Crescentini: Viola
Marta Gastini: C. 2ª cl. NP Giulia
Fabrizio Ferracane: Basile
Ninni Bruschetta: proprietario albergo
Marcello Mazzarella: don Bruno
Gaetano Bruno: Valente
Peppino Mazzotta: TV (CP) Ragusa
Paola Tiziana Cruciani: Lucia
Massimo Wertmüller: CV (CP) Lannes
Fotografia
Enzo Carpineta
Montaggio
Alessio Doglione
Musiche
Maurizio De Angelis
Scenografia
Massimilano Nocente
Costumi
Alfonsina Lettieri
Produzione
Fabula Pictures e Rai Fiction
Origine:
Italia
Anno:
2016
Durata:
100 minuti (serie TV in due puntate trasmesse su rai1 il 20 e il 21 settembre 2016
- Tanto l’Antico e il Nuovo Testamento, quanto la Storia e la mitologia del mondo greco-romano furono materia di costante ispirazione per il cinema fin dai primordi. Prova ne sia che i grandi kolossal dell’èra del muto (da Gli ultimi giorni di Pompei del 1908 a Cabiria del 1914 passando per La caduta di Troia del 1911 e la prima versione di Quo vadis? del 1913) sono adattamenti di celebri feuilleton tardo ottocenteschi a loro volta incentrati su episodi desunti dalla storia romana o dalla tradizione vetero e neo testamentaria. Agli inizi degli anni ’60, il fenomeno del cinema in costume incentrato su tematiche di questo stesso tenore (chiamato peplum a partire da una fortunata intuizione da parte di alcuni esponenti di spicco della redazione dei “Cahiers du Cinéma” che nel maggio del 1961 decisero di dedicare alla nuova ondata di film in costume arrivata dalla Hollywood sul Tevere un numero monografico della rivista) s’impose prima come una tendenza tipica del cinema di casa nostra arrivando poi a contagiare in maniera vistosa anche l’industria hollywoodiana e riscontrando enorme successo di pubblico per un intero quinquennio. Sul peplum in genere si vedano Farassino A., Sanguineti T., Gli uomini forti, Milano, Mazzotta, 1983 e Della Casa S., Giusti M. (a cura di), Il grande libro di Ercole. Il cinema mitologico in Italia, Roma, Edizioni Sabinae – Centro Sperimentale di Cinematografia, 2013. ↑
- Buona parte del XIX secolo fu caratterizzata da un vero e proprio revival del Medioevo responsabile diretto della creazione di un’immagine edulcorata e spesso immaginaria dei cosiddetti secoli bui assai lontana dalla realtà ma utile per creare miti e luoghi comuni fortemente radicati nelle culture nazionali di molti paesi europei (cfr. Bordone R., Lo specchio di Shalot. L’invenzione del Medioevo nella cultura dell’Ottocento, Napoli, Liguori, 1993). Fin dai primi vagiti all’inizio del XIX secolo il cinema dimostrò grande attrazione per questa riedizione di un Medioevo in cartapesta sfornando moltissimi titoli che ne documentano la presenza massiccia a livello di sfruttamento di conflitti ed episodi variamente eclatanti usati come metafore del presente di cui si aveva intenzione di parlare in absentia. Per il Medioevo al cinema si vedano Attolini V., Immagini del Medioevo nel cinema, Bari, Dedalo, 1993; Elliott A., Remaking the Middle Ages: The Methods of Cinema and History in Portraying the Medieval World, Jefferson, McFarland, 2010; Shichtman M.B., Finke L.A., Cinematic Illuminations: The Middle Ages on Film, Baltimore, 2009; Burt R., Medieval and Early Modern Film and Media, New York, Palgrave MacMillan, 2010; Johnston A.J., Rouse M., Hinz P. (a cura di), The Medieval Motion Picture: The Politics of Adaptation, New York, Palgrave MacMillan, 2014 (con ricchissima bibliografia); Merlo M., “Lo Nero Periglio”. Narrazioni cinematografiche della guerra nel Medioevo, in Pisu S. (a cura di), War Films. Interpretazioni storiche del cinema di Guerra, Milano, Società Italiana di Storia Militare – Acies Edizioni Milano, 2015, pp. 313-334. ↑
- Per le molte implicazioni extra cinematografiche (ivi inclusi gli inevitabili rapporti con le guerre tra conquistatori yankee e popolazioni indigene nella penetrazione verso la Frontiera occidentale) che il genere western ha sempre comportato fin dai primordi si veda la recente e più che esaustiva monografia di Joseph Maddrey The Quick, the Dead and the revived: The many Lives of the Western Film, Jefferson, McFarland, 2016. Lo stesso argomento è trattato e approfondito in diverso modo anche nei seguenti contributi di epoche diverse: Nash Smith H., Virgin Land: The American West as Symbol and Myth, New York, Vintage, 1950; Fenin G., Everson K., The Western. From Silents to the Seventie, New York, Oenguin Books, 1977; Kezich T., Il mito del Far West, Milano, Il Formichiere, 1980; Leutrat J.L., Liandrat-Guigues S., Le carte del Western. Percorsi di un genere cinematografico, Recco, Le Mani 1994; Viganò A., Western in cento film, Recco, Le Mani 1994; Mitchell Clark L., Westerns: making the Man in Fiction and Film, University of Chicago Press, Chicago, 1996; D’Angela T. (a cura di), Il cinema western da Griffith a Peckinpah, Alessandria, Falsopiano, 2004; Frasca G., C’era una volta il western. Immagini di una nazione, Utet, Torino, 2007; Rosso S. (a cura di), Le frontiere del far West. Forme di rappresentazione del grande mito americano, Shake Edizioni, Milano, 2008; Bosco A. , Rizzi D., I cavalieri del West, Recco, Le Mani, 2011; Tetro M., Di Marino S., Guida al cinema western, Odoya, Bologna, 2016. ↑
- Se si eccettua l’ancor oggi oggetto misterioso rappresentato da Metropolis di Fritz Lang del 1927, buona parte dei primi esperimenti di quel cinema che mezzo secolo più tardi sarebbe stato incasellato in canoni rigidi validi anche per i decenni futuri ruotano infatti intorno a questo binomio tematico. E se un pioniere del calibro di Georges Méliès nell’arco del biennio 1902-1904 realizzò prima Viaggio nella Luna e poi Viaggio attraverso l’impossibile anticipando in qualche modo questo tipo di ingenue evasioni fantastiche vagamente sorrette da presupposti pseudo-scientifici, nel ventennio successivo furono in molti a seguirne le orme: da L’Atlantide di Jacques Feyder del 1921 (prima versione del fortunato romanzo omonimo di Pierre Benoît) a Parigi che dorme di René Clair del 1923 fino a Una donna nella luna diretto dallo stesso Fritz Lang nel 1928 passando per Aelita di Jakov Aleksandroviç Protazanov del 1924, prima opera di genere prodotta dalla cinematografia sovietica. ↑
- Con Il gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wise del 1920 e Il Dottor Mabuse di Fritz Lang l’espressionismo tedesco aveva già anticipato questo bizzarro mix di elementi orrorifici e follia demiurgica di scienziati relegati ai margini della società e proprio per questo votati alla religione del Male. Tematica questa tornata poi prepotentemente in auge nel pieno furoreggiare della Grande Depressione come specchio deformato e deforme del deragliamento sociale in atto: nel 1931 uscirono contemporaneamente Frankenstein di James Whale e Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian, seguiti a distanza di due anni da L’isola delle anime perdute di Erle C. Klenton e da L’uomo invisibile di James Whale (entrambi tratti da altrettanti fortunati romanzi di H. G. Wells). ↑
- Questa sinistra connessione tra la scioccante conclusione della guerra nel Pacifico e le profonde (ma altamente produttive) ripercussioni nell’industria cinematografica americana è analizzata a fondo in Zinni M., Schermi radioattivi. L’America, Hollywood e l’incubo nucleare da Hiroshima alla crisi di Cuba, Marsilio, Venezia, 2013. ↑
- Tra il 1942 e il 1962 il cinema americano di anticipazione conobbe una crescita ipertrofica arrivando a sfornare più di cinquecento titoli che contribuirono a imporre l’invasione del pianeta Terra da parte di creature provenienti da mondi «altri» come il tema per eccellenza del genere stesso. In preda a uno stato di costante ansia dovuto al terrore per le armi atomiche come possibile soluzione finale del genere umano ma anche per la paura del Comunismo percepito come minaccia esistenziale e rischio di estirpazione dell’individualità, l’americano medio di quegli anni diventò ben presto il target ideale di produzioni che il tema dell’invasione aliena lo mettevano al centro dei propri lungometraggi ricamandoci sopra con variazioni non sempre originali. Pietre miliari di questo percorso sono due titoli usciti non a caso lo stesso anno, il 1951: e cioè La cosa da un altro mondo, diretto da Christian Nyby, e Ultimatum alla terra, firmato invece da Robert Wise, ai quali fece seguito L’invasione degli ultracorpi (diretto da Don Siegel nel 1956 e possibile metafora sia del terrore per il temuto avvento del comunismo in America che del grande conformismo che ne caratterizzava la vita sociale in ogni ambito in quell’epoca). A questo proposito si vedano: Hendershot C., Paranoia, the Bomb, and 1950s Science Fiction Films, Bowling Green, Bowling Green State University Press, 1999; O’Donnell V., Science Fiction Films and Cold War Anxiety, in Lev P. (a cura di), Transforming the Screen, 1950-1959 (history of the American Cinema, Vol. 7), New York, Charles Scribner’s Sons, 2003; Bliss M., Invasions USA: The Essential Science Fiction Films of the 1950s, Lanham, Rowman & Littlefield, 2014. ↑
- La longevità di questo tema incentrato sulla proiezione di conflitti reali su scenari di futuri possibili è dimostrata non solo dal numero di pellicole che lo ripropongono a diverso titolo, ma anche dalla sua evoluzione nel corso dei decenni successivi. Dopo una parentesi di approdi pacifici tra la fine degli anni ’70 e buona parte degli ’80 (con titoli di culto quali i due capolavori spielberghiani di Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1979 ed E.T. L’extraterrestre del 1982), verso la metà degli anni ’90 la figura degli alieni feroci che approdano sulla Terra con intenzioni quanto mai bellicose torna a spopolare. Ad aprire la strada a questo revival è Independence Day del 1996 (giocattolone truce che non a caso si rifà a titoli degli anni ’50 quali La Terra contro i dischi volanti di Fred Sears del 1956), cui farà poi seguito una lunga sequela di prodotti nei quali gli invasori da mondi «altri» approdano dalle nostre parti o per cancellare la razza umana facendo uso di armi e strumenti sconosciuti (si vedano, per esempio, The Avengers del 2012, Transformers: Dark Side of the Moon del 2011), oppure per impossessarsi di risorse presenti sul pianeta (come capita sia in World Invasion: Battle Los Angeles del 2011 che Oblivion del 2013 nei quali gli aggressori alieni sono a caccia di risorse naturali, o ne L’ora nera del 2011 dove la caccia è data invece al rame e ad altri metalli preziosi, o ancora in The War of the Worlds del 2005, nel quale l’oggetto del desiderio extraterrestre è il preziosissimo sangue umano di cui gli invasori marziani si cibano perché provenienti da un pianeta al collasso ematico). A questo proposito si vedano Terzuolo E. R., Gli extraterrestri non leggono Clausewitz, in Pisu S. (a cura di), War Films. Interpretazioni storiche del cinema di Guerra, op. cit., pp. 335-355; Casagrande Napolin F., Fedrigo I., Urisch E., Attacco Alieno! – Guida al cinema d’invasione spaziale 1950-1970, Bologna, Tunnel Edizioni, 1998. ↑
- Anche in questo genere apparentemente così lontano dai fragori dei campi di battaglia vi sono alcuni titoli di culto per i quali è impossibile non pensare all’universo della guerra in senso lato. Se infatti This is the Army diretto da Michael Curtiz nel 1943 (a sua volta basato su un fortunato musical allestito a Broadway due anni prima con gli stessi scopi di mero intrattenimento per l’esercito) vi è legato in maniera diretta perché concepito come spettacolo di propaganda bellica, il legame sembra meno evidente per titoli quali West Side Story del 1961, Grease del 1978 e Hair del 1979 (tutte fortunate versioni cinematografiche di celebri musical andati in scena negli anni precedenti) che fanno invece riferimento agli scontri tra bande rivali a New York e a Los Angeles o addirittura alla reazione anarcoide di un gruppo di hippy alla leva militare coatta per il Vietnam. Per il musical in genere si vedano Fordin H., The World of Entertainment: Hollywood’s Greatest Musicals, New York, Avon Books, 1976; Pruzzo P., Musical americano in 100 film, Recco, Le Mani, 20013; AA.VV. Musica in cinema in 201 film, Firenze, Giunti Demetra, 1998; Lucci G., Musical, Milano, Mondadori Electa, 2006. ↑
- Tanto la bibliografia quanto la filmografia e la sitografia dei contributi dedicati al tema dell’Olocausto hanno ormai raggiunto dimensioni a dir poco colossali. Per quanto concerne i lavori più importanti si vedano: Avisar I., Screening the Holocaust: Cinema’s Images of the Unimaginable, Bloomington, Indiana University Press, 1988; Id. “Holocaust Movies and the Politics of Collective Memory.”, in Rosenfeld A. H. (a cura di) Thinking about the Holocaust: After Half a Century, Bloomington, Indiana University Press, 1997; Baron L., Projecting the Holocaust into the present: the changing focus of contemporary Holocaust cinema, Lanham, Rowman & Littlefield, 2005; Bartov O., The “Jew” in cinema: from the golem to Don’t touch my Holocaust, Bloomington, Indiana University Press, 2005; Id., Murder in our Midst: The Holocaust, Industrial Killing, and Representation, New York, Oxford University Press, 1996; Bernard-Donals M., Between witness and testimony: the Holocaust and the limits of representation, Albany, State University of New York Press, 2001; Colombat A., The Holocaust in French Film, Metuchen, Scarecrow Press, 1993; Doneson, J.E., The Holocaust in American film, Syracuse, Syracuse University Press, 20022; Id., “The Holocaust and Film.”, in Lee L.E., (a cura di), World War II in Asia and the Pacific and the war’s aftermath, with general themes: a handbook of literature and research, Westport, Greenwood Press, 1998; Friedman L.D., “Darkness Visible: Images of Nazis in American Films.”, in Pomerance M. (a cura di), Bad: infamy, darkness, evil, and slime on screen, Albany, State University of New York Press, 2004; Id., The Jewish Image in American Film, Secaucus, Citadel Press, 1987; Friedman, R.M., L’image et Son Juif: Le Juif Dans le Cinema Nazi, Paris, Payot, 1983; Hirsch J.F., Afterimage: film, trauma, and the Holocaust, Philadelphia, Temple University Press, 2004; Haggith T., Newman J. (a cura di), Holocaust and the moving image: representations in film and television since 1933, London-New York, Wallflower, 2005; Picart C.J (a cura di), The Holocaust film sourcebook, Westport, Praeger, 2004; Insdorf A., Indelible Shadows: Film and the Holocaust, Cambridge, Cambridge University Press, 20033; Langer L.L., “The Americanization of the Holocaust on Stage and Screen”, in Admitting the Holocaust: collected essays, New York, Oxford University Press, 1995; Raphael M.L. (a cura di), The Representation of the Holocaust in literature and film, Williamsburg, Department of Religion of the College of William and Mary, 2003; Tegel S., Nazis and the cinema, London-New York, Hambledon Continuum, 2007; Bathrick D., Prager B., Richardson M.D. (a cura di), Visualizing the Holocaust: documents, aesthetics, memory, Rochester, Camden House, 2008. Per il cinema di casa nostra si vedano invece Millicent M., Italian film in the shadow of Auschwitz, Toronto, University of Toronto Press, 2007; Gaetani C., Il cinema e la Shoah, Recco, Le Mani, 2006; Minuz A., Vitiello G., La Shoah nel cinema italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013. ↑
- Anche il tema delle ripercussioni cinematografiche della Guerra in Vietnam sulla società americana e la nascita del fenomeno del reducismo vanta ormai una bibliografia sterminata. Tra i contributi più importanti si vedano Adair G., Vietnam on Film: From The Green Berets to Apocalypse Now, New York, Proteus, 1981; Auster A., How the War Was Remembered: Hollywood & Vietnam, New York, Praeger, 1988; Bates, M.J., The Wars We Took to Vietnam: Cultural Conflict and Storytelling, Berkeley, University of California Press, 1996; Booker M. K., “Apocalypse then: the Vietnam war in American film”, in From box office to ballot box: the American political film, Westport, Praeger, 2007; Boyle, B.M., Masculinity in Vietnam War narratives: a critical study of fiction, films and nonfiction writings, Jefferson, McFarland & Co., 2009; Renny C., The Viet Nam War/The American War: Images and Representations in Euro-American and Vietnamese Exile Narratives, Amherst, University of Massachusetts Press, 1995; Cook D.A., Lost Illusions: American Cinema in the Age of Watergate and Vietnam, 1970-1979, New York, Scribner, 2000; Desser D, ‘Charlie Don’t Surf’: Race and Culture in the Vietnam War Films, in Anderegg M. (a cura di), Inventing Vietnam: the war in film and television, Philadelphia, Temple University Press, 1991; Devine, J.M., Vietnam at 24 Frames a Second: A Critical and Thematic Analysis of Over 400 Films About the Vietnam War, Jefferson, McFarland, 1995; Dornfeld B., “Dear America: Transparency, Authority, and Interpretation in a Vietnam War Documentary”, in Dittmar L., Michaud G., From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, New Brunswick, Rutgers University Press, 1990, pp. 283-97; Grosser D., “‘We Aren’t on the Wrong Side, We Are the Wrong Side’: Peter Davis Targets (American) Hearts and Minds”, in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp: 269-83; Haines, H.W., “‘They Were Called and They Went’: The Political Rehabilitation of The Vietnam Veteran”, in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp: 81-97; Hellmann J., American Myth and the Legacy of Vietnam, New York, Columbia University Press, 1986; Herbison, C.C., IB(l)ack to the world: Explorations of race, trauma illness, and healing in selected Vietnam War films, dissertazione, The University of Kansas, 2006; Higashi S., “Night of the Living Dead: A Horror Film about the Horrors of the Vietnam Era” in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp: 175-88; Hillstrom K., The Vietnam Experience: A Concise Encyclopedia of American Literature, Songs, and Films, Westport, Greenwood Press, 1998; Anderegg M., Inventing Vietnam: The War in Film and Television, Philadelphia, Temple University Press, 1991; Jeffords S., The Remasculinization of America: Gender and the Vietnam War, Bloomington, Indiana University Press, 1989; Karlin W., War movies: journeys to Vietnam: scenes and out-takes, Willimantic, Curbstone Press, 2005; Kinney K., Friendly fire: American images of the Vietnam War, Oxford-New York, Oxford University Press, 2000; Klein M., “Historical Memory, Film, and the Vietnam Era”, in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp. 19-40; Lipkin S., Mitigations of shame: Represented and elicited affect in Vietnam War films of the late 1980s, dissertazione, University of Rhode Island, 2010; Martin A., Receptions of War: Vietnam in American, Norman, University of Oklahoma Press, 1993; McKenzie, A.P., Casualties of war: The demasculinization of the Vietnam veteran in American film, dissertazione, University of Houston-Clear Lake, 2010; Muse, E.J., The Land of Nam: The Vietnam War in American Film, Lanham, Scarecrow Press, 1995; Muraire A., Hollywood-Vietnam: la guerre du Vietnam dans le cinéma américain, mythes et réalités, Paris, M. Houdiard, 2010; Renov M., “Imagining the Other: Representations of Vietnam in Sixties Political Documentary.” in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp. 254-68; Rowe J.C., “‘Bringing It All Back Home’: American Recyclings of the Vietnam War”, Armstrong N., Tennenhouse L. (a cura di), The Violence of Representation: Literature and the History of Violence, New York, Routledge, 1989; Smith J., Looking away; Hollywood and Vietnam, New York, Scribner, 1975; Taylor M., The Vietnam War in history, literature, and film, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2003; Tessier L., Le Vietnam, un cinéma de l’apocalypse, Paris, Corlet, 2009; Jean-Jacques Malo JJ., Williams T. (a cura di), Vietnam War Films: Over 600 Feature, Made-for-TV, Pilot, and Short Movies,1939-1992, From the United States, Vietnam, France, Belgium, Australia, Hong Kong, South Africa, Great Britain, and Other Countries, Jefferson, McFarland, 1994; Walker M., Vietnam Veteran Films, Metuchen, Scarecrow Press, 1991; Weaver G., “The Vietnam War film, victimized veterans, and the disappearing woman”, in Heberle M. (a cura di), Thirty years after : new essays on Vietnam war, literature and film, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Pub, 2009; Williams T., “Missing in Action: The Vietnam Construction of the Movie Star.” in From Hanoi to Hollywood: The Vietnam War in American Film, op. cit., pp. 129-44; Wilson J., Vietnam in Prose and Film, Jefferson, McFarland, 1982; AA.VV., Vietnam. Vincere la Guerra, perdere la pace?, «Il Ponte», XII, numeri 1-2, gennaio-febbraio 1996. ↑
- Uno dei primi esempi di film nel quale il “dopo” guerra conta molto più della guerra è Visitors, diretto nel 1972 da Elia Kazan (nel quale due veterani del Vietnam, usciti di galera dopo aver scontato una condanna per crimini a sfondo sessuale, terrorizzano in maniera sadica un uomo che ha avuto il coraggio di testimoniare contro di loro durante il processo che li ha visti condannati. Col passare degli anni, il tema del reducismo — insieme a quello del marine disperso nella giungla o dimenticato in malsane prigioni vietnamite e quindi recuperato ad anni di distanza dalla fine del conflitto da commandos più o meno autorizzati — ha conosciuto una tale popolarità da imporsi come una sorta di sotto-genere del cosiddetto Vietnam movie (a sua volta sotto-genere del film bellico inteso in senso lato). A questo proposito basti citare titoli quali un altro apripista di tale tendenza del calibro di Taxi Driver, o successivamente lungometraggi di grande spessore e rilevanza quali Tracks, Coming Home, Nato il 4 luglio, Alice’s restaurant, Il cacciatore, Jacknife, Nashville, Americana, Heroes, Birdy, Vanishing Point, Hi Mom, Cutter’s Way, Il grande freddo e via dicendo. Tutti film i cui protagonisti maschili sono reduci del Vietnam mentalmente disturbati o menomati nel corpo. Una fisionomia, quella del veterano scollegato dalla realtà e incapace di essere (re)integrabile nel tessuto sociale, che in molti casi deraglia ulteriormente convertendosi in profili dichiaratamente criminali: non è infatti una sorpresa che alcuni dei più sinistri criminali del cinema USA degli anni ’90 siano appunto dei reduci della «sporca guerra» in Vietnam (e a questo proposito basterebbe citare il Clint Eastwood di Firefox, Il Chuck Norris di Forced Vengeance, il giovanissimo Richard Gere di Looking for Mr. Goodbar, il Roy Schider di Blue Thunder, il Willem Dafoe di Cuore selvaggio o ancora l’ambiguo poliziotto Mickey Rourke de L’anno del Dragone). Per una dettagliata analisi di questo tipo di personaggio all’interno del pianeta Vietnam movie si veda Zagarrio V., Coppola e il Vietnam Movie, in Pisu S. (a cura di), War Films. Interpretazioni storiche del cinema di Guerra, op. cit., pp. 293-312. ↑
- Anche in questo caso la pubblicistica a vario titolo (in video, su carta stampata e soprattutto sulla rete) nonché la bibliografia e la filmografia hanno raggiunto ormai dimensioni talmente importanti da esser diventate un comparto quasi autonomo all’interno degli studi sulle migrazioni. Per un’informazione sempre aggiornata sulla contabilità dei decessi ma su ogni altro aspetto concernente gli spostamenti di massa da parte di immigrati irregolari verso l’Italia ma anche verso gli atri hotspot del Mediterraneo tramite i quali si vorrebbe raggiungere l’Europa settentrionale, la fonte più autorevole resta a tutt’oggi l’osservatorio «Fortress Europe». Fondato nel 2006 dal giornalista lucchese free lance Gabriele Del Grande con lo scopo di raccogliere informazioni su tutti i singoli eventi di decessi o di naufragi censiti dai mezzi di informazione in Europa e nel Maghreb a partire dal 1988 (eventi che Del Grande collega sempre a fonti affidabili relative all’episodio per consentirne una verifica più approfondita a ogni tipo di utente), ha nel blog da lui stesso diretto — http://fortresseurope.blogspot.it/ — un punto di riferimento ineludibile per chiunque voglia fare ricerca in questo àmbito. Al punto che l’attività di Del Grande è a tutt’oggi il monitoraggio del fenomeno realizzato su scala europea maggiormente affidabile e punto di riferimento per la maggior parte dei dati diffusi da organizzazioni governative e non. Sulla questione di Lampedusa e su tutto ciò che vi ruota intorno a livello economico, sociale, storico e culturale si vedano per lo meno: Gatti F., Io, clandestino a Lampedusa, «L’Espresso», 7.10.2005 (http://espresso.repubblica.it/palazzo/2005/10/07/news/io-clandestino-a-lampedusa-1.594), agghiacciante inchiesta di cui fu protagonista il giornalista de «L’Espresso» che nel 2005 si finse migrante curdo e trascorse otto giorni all’interno del Centro di Permanenza Temporanea di Lampedusa per denunciare le condizioni inumane in cui vivevano i rifugiati in violazione di ogni forma di diritto umano; Del Grande G., Il mare di mezzo, Roma, Infinito, 2010; Coluccello S., Massey S., “Out of Africa: The Human Trade between Libya and Lampedusa”, «Trends in Organized Crime», 10, 2007, pp. 77-90; Triulzi A., “Marching out from the Horn: Migrant Narratives from the Libya-Lampedusa Route”, in McKenzie R., Triulzi A. (a cura di), Long Journeys. African Migrants on the Road to Europe, Leiden, Brill, 2012; Id., “Per un archivio delle memorie migranti, Made in Italy. Migrazioni e identità”, «Zapruder», 28, 2012, pp. 118-123; Liberti S., Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo, Roma, Minimum Fax, 2011; Id., A Sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti, Roma, Minimum Fax, 20112; Wright S., “Lampedusa’s Gaze: Messages from the Outpost of Europe”, «Italica», Volume 91, n. 4, 2014, pp. 775-802. ↑
- Wright S., “Lampedusa’s Gaze: Messages from the Outpost of Europe”, op. cit., pp. 784-786 ↑
- “Dal 1994, nel Canale di Sicilia sono morte almeno 13.318 persone, lungo le rotte che vanno dalla Libia (Zuwarah, Tripoli, Misratah), dalla Tunisia (Kelibia, Sousse, Chebba e Mahdia) e dall’Egitto (Alexandria, Kafr Sheikh) verso le isole di Lampedusa, Pantelleria, Malta, la Sicilia e parte della costa ionica calabrese. Pe più di metà delle vittime (9.965) le salme non sono state recuperate e giacciono in fondo al mare. Soltanto nel 2015 le vittime sono state 3.106. Una media di 250 morti al mese, 8 al giorno: un’ecatombe. Senza tenere conto di tutti i naufragi fantasma, di cui non sapremo mai niente. Altri 229 giovani sono annegati navigando dalla città di Annaba, in Algeria, alla Sardegna” (cfr. http://fortresseurope.blogspot.it/2006/02/nel-canale-di-sicilia.html). ↑
- Un tema questo che, trattato in ben altra maniera e con un approccio di devastante realisticità, è al centro di buona parte della produzione documentaristica di Dagmawi Yimer. Fuggito dall’Etiopia a seguito del colpo di Stato del 2005 e dell’instaurazione della dittatura, dopo un interminabile viaggio negli inferni subsahariani costellato da detenzioni e vessazioni in vari centri di raccolta in Libia prima di ottenere un passaggio in «nave» per l’Europa, Yimer arrivò a Lampedusa il 30 luglio del 2006 insieme a molti connazionali in uno dei tanti viaggi della speranza sulla rotta che dal Golfo della Sirte porta all’arcipelago delle Pelagie. Arrivato per caso al documentario (grazie a un corso di video-narrazione offerto dalla scuola per stranieri della onlus Asinitas a Roma, cfr. Corsetti M., Triulzi A., Come un uomo sulla terra, Libro e DVD, Roma, Infinito, 2009), con C.A.R.A. Italia realizzò il suo primo documentario raccontando dal di dentro la realtà infernale dei cosiddetti Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo. Un metodo usato poi nei suoi due più maturi e riusciti lavori successivi, ovvero Come un uomo sulla terra (co-diretto nel 2008 insieme a Andrea Segre) e Soltanto il mare (realizzato due anni dopo con Fabrizio Barraco e Giulio Cederna). Nel primo Yimer racconta la terribile odissea di cui è stato protagonista in prima persona fino all’approdo a Lampedusa intervistando poi quanti come lui hanno dovuto sottostare allo stesso tipo di vessazioni e di brutalità da parte della polizia libica (coadiuvata in questo dallo stesso Governo italiano in ottemperanza agli accordi firmati dall’allora Primo Ministro Silvio Berlusconi con il dittatore Muhammar Gheddafi). Nel secondo l’ex-immigrato illegale torna a Lampedusa a quattro anni di distanza dai tragici giorni trascorsi nel centro di permanenza temporanea per esprimere la propria gratitudine alla terra e i suoi abitanti che di fatto gli hanno salvato la vita. E in questo suo secondo approdo sull’isola, attraverso una serie di interviste solo apparentemente casuali con pescatori, esponenti delle autorità locali, effettivi della Guardia Costiera e lampedusani qualunque, Yimar scopre non solo che ormai buona parte dei locali non fa più figli, ma che tutti i residenti sono accomunati da una profonda frustrazione dovuta al senso di abbandono da parte di uno Stato capace solo di enfatizzare coi media il fenomeno degli sbarchi per autocelebrare la propria politica relegando la realtà di fatto alla marginalità isolana di un lembo di mondo troppo lontano dal cuore del paese per poter contare davvero. ↑
- Come però accaduto anche a molti altri visitatori giunti sull’isola per ragioni di ricerca e non per mero svago o, ancor peggio, nell’ottica della nefasta moda del turismo dell’orrore, anche Rosi al suo arrivo a Lampedusa rimase sbalordito al vedere che sull’isola non vi era quasi traccia alcuna dei migranti (e caso volle che in quel periodo di Centro di prima accoglienza fosse chiuso per ristrutturazioni in corso), la cui presenza era limitata soltanto a echi passeggeri che facevano riferimento a un «oltre» molto lontano dagli angusti confini dell’isola (cfr. Boille F., Fuocoammare raccontato da Gianfranco Rosi, intervista apparsa su «Internazionale» il 23 febbraio 2016, http://www.internazionale.it/opinione/francesco-boille/2016/02/23/fuocoammare-gianfranco-rosi-intervista). ↑
- Cfr. Johnston T., Fire at Sea, «Sight and Sound», July 2016, 26, 7, p. 60. ↑
- Definito da Rosi stesso un “rap-gospel” (cfr. Boille, op. cit.). ↑
- Un esempio per tutti: nel documentario di Rosi è il regista stesso a documentare in diretta una delle tante missioni portate a termine dalle imbarcazioni della locale Guardia Costiera. Autorizzato a salire a bordo di una di esse, al suo secondo viaggio Rosi si trova impegnato in prima linea proprio mentre un barcone carico di migranti allo stremo viene avvicinato dal natante della Guardia Costiera. Pensando che si tratti soltanto di un gruppo di rifugiati in attesa di toccare terra, Rosi sale a bordo del gommone che viene inviato in accosto al barcone, ignaro di quel che si sarebbe trovato di fronte di lì a poco. E cioè il dramma autentico — documentato nel film — di cadaveri ammassati nella stiva. Colto di sorpresa e non sapendo bene cosa fare (cfr. Boille, op. cit.), ma con la telecamera pronta in mano, il regista decide di agire optando per una documentazione fredda e asettica di quanto il suo occhio sta effettivamente vedendo, trasformandosi quindi in tramite oggettivo tra l’essenza stessa della tragedia della migrazione (ormai abusata in TV perché depotenziata nel suo manifestarsi dai troppi passaggi e dall’abitudine dello sguardo all’immagine cronachistica divenuta di routine) e il pubblico in sala impreparato a ricevere quel colpo senza preavviso. In Terraferma Crialese propone una situazione similare: Filippo, nella débacle notturna di quella che doveva essere una romantica uscita in barca con una bella turista trasformatasi però in tragedia all’avvistamento in acqua di migranti allo stremo, li allontana con violenza a colpi di remi per evitare rogne con le autorità marittime. In preda a forti rimorsi e dopo essersi frettolosamente liberato della ragazza, non ha il coraggio di tornare a casa ma si accascia stremato su una spiaggia. La mattina successiva si sveglia ed è testimone di uno spettacolo surreale: il punto di litorale nel quale è crollato vittima di un sonno ristoratore dopo la notte di tregenda è proprio il tratto di spiaggia che lo zio Nino gestisce intrattenendo i turisti con la sua barca da pesca. Ma, come se non bastasse, non appena gli occhi gli si liberano dalle nebbie del risveglio, Filippo si accorge che la risacca sta spiaggiando dei corpi senza vita. Ovvero proprio quei migranti cui la notte prima ha rifiutato di offrire aiuto allontanandoli a colpi di remi e decretandone indirettamente una sorta di condanna a morte. Se la scena terminasse qui e lo spettatore fosse testimone del tutto attraverso il personaggio di Filippo, anche l’occhio di Crialese potrebbe assolvere alla funzione di distacco oggettivo che Rosi affida alla sua telecamera mentre si trova a filmare la processione di cadaveri estratti dalla stiva del barcone. Ma non è così. In un attimo l’attenzione si sposta sulla reazione dei bagnanti, divisi tra lo slancio solidale verso quanti morti non sono ma giacciono stremati sull’arenile e la morbosa attrazione di girare un video che immortali l’autenticità della morte e possa catalizzare l’attenzione morbosa su qualche brandello di social media. In questo modo l’assurdo teatro della morte in diretta che Rosi mostra con asciutto rigore facendosi occhio neutrale per chi non avrà mai, bontà sua, l’occasione di testimoniare l’orrore dal vivo viene subito rimpiazzato dall’attenzione al dettaglio di contorno. Il che implica che l’oggettività neutrale della rappresentazione cessi di essere tale lasciando spazio a un crocevia depotenziante di forze centrifughe che spingono verso l’indignazione per il comportamento irresponsabile del turista che filma la morte per gusto malato o il paradosso della convivenza tra la realtà vacanziera e quella della tragedia delle migrazioni. ↑
- Marmiroli A., Nessun uomo è un’isola, «Film TV», 37, 13 settembre 2017, pp. 18-19 (intervista a Marco Pontecorvo in occasione della messa in onda dello sceneggiato su Rai1). ↑
- Queste e altre informazioni sulle riprese e sui set utilizzati sono desunti da Pontecorvo M., Note di regia di “Lampedusa dall’orizzonte in poi”, http://www.cinemaitaliano.info/news/37745/note-di-regia-di-lampedusa-dall-orizzonte.html ↑
- Ben altro approccio hanno mostrato di avere a questa stessa e delicatissima materia Stefano Liberti e Andrea Segre in Mare chiuso, doloroso ma necessario documentario di denuncia e impegno civile nel quale si affronta con coraggio un argomento tabu di cui gli organi di informazione e la TV non hanno mai voluto parlare molto. E non lo hanno fatto proprio perché rappresenta un pagina di vergogna nazionale legata ad alcune scelte di intransigenza radicale in materia di politica dell’immigrazione adottate dal Ministero dell’Interno del governo Berlusconi, ma anche alla scellerata e contestatissima amicizia tra l’ex Primo Ministro e l’ormai defunto Raís libico. E cioè il respingimento forzato sulle coste libiche di quasi 2000 migranti che tra maggio 2009 e settembre 2010 cercarono di approdare in Italia per richiedere asilo, ma che furono rispediti al mittente con violenza inaudita finendo poi risucchiati in un vortice di follia detentiva e persecutoria da cui molti non sono più riusciti ad emergere. A monte di tutto c’è il cosiddetto trattato di amicizia italo-libica siglato a Bengasi il 30 agosto 2008 dall’allora Primo Ministro Berlusconi e dal colonnello Gheddafi. Un trattato che, tra le pieghe di complessi accordi legati a questioni di risarcimenti post-coloniali, prospettava anche l’impegno reciproco da parte dei due paesi di abbracciare una politica comune di polso fermo nei confronti dei cosiddetti occhi chiusi di fronte alle emorragie di migranti in uscita (Libia) e delle braccia aperte verso l’accoglienza indiscriminata (Italia). In applicazione degli accordi siglati, l’Italia si dimostrò fin troppo solerte in una serie di respingimenti di barconi affollati da disperati in fuga da realtà socio-politiche di persecuzione e negazione di ogni diritto. Migranti che speravano di trovare in Italia un paese pronto ad applicare la normativa internazionale in materia di asilo politico e che invece cozzarono contro il muro ottuso e feroce della repressione militarizzata. Il documentario di Andrea Segre e Cesare Liberti ricostruisce in maniera efficacemente dolorosa le odissee di molti di questi migranti, ripercorrendone i viaggi della speranza dalle lande più inospitali dell’Africa in costante subbuglio fino all’incontro/scontro con le forze dell’ordine italiane, chiamate a contenere l’emorragia degli approdi col ricorso a ogni forma di dissuasione quasi mai improntata al dialogo ma sempre impostata sulla violenza del contatto fisico, l’intimidazione, l’uso di strumenti elettrici di persuasione fisica, il sequestro dei documenti e il rimpatrio forzato verso le inospiti coste della Libia. Di qui il simbolismo contenuto nel titolo stesso del documentario che con l’idea di una chiusura del mare vuole puntare il dito contro l’atteggiamento di chiusura politica e umanitaria da parte del Governo italiano dell’epoca di fronte al grido disperato di aiuto di chi chiedeva solo di vedere accolta la propria giustificatissima richiesta di asilo. Di questa indegna sequenza di violazioni e delle modalità in cui essere vennero portate a termine forse non si sarebbe mai saputo molto perché i giornalisti non erano ammessi sulle navi con cui la Marina Militare Italiana rimpatriava i profughi intercettati nelle acque territoriali, ma soprattutto perché le vittime di tanta barbarie venivano riconsegnate alle autorità libiche pur non essendo libiche ma risultando per la maggior parte dei casi profughi provenienti da Etiopia, Somalia ed Eritrea. Ed è stato solo a seguito del collasso del regime del colonnello Gheddafi che la situazione ha avuto uno sblocco: grazie infatti al trasferimento di molti ospiti delle carceri libiche nei campi allestiti dall’ONU in aree extralibiche durante le fasi più drammatiche della guerra civile che ha insanguinato il paese cirenaico, i due cineasti — e con loro molti giornalisti internazionali — hanno finalmente potuto parlare coi protagonisti di questa pagina indegna mettendo a punto l’ossatura di base del loro documentario. Girando nel corso dell’estate del 2011 nel settore somalo-etiope-eritreo del campo Shousha dell’UNHCR allestito ai confini tra Libia e Tunisia per i profughi della guerra libica e arrivando anche a utilizzare frammenti di video girati dalle vittime specifiche dei respingimenti in acque mediterranee, Segre e Liberti hanno messo insieme quanto basta per sbattere in faccia allo spettatore un condensato di un’ora di pene senza fine che fanno ancora più male perché sono raccontate dai diretti protagonisti di questi viaggi nell’allucinazione, ma anche perché aprono il coperchio su una botola mefitica in cui è finita una pagina vergognosa del nostro recentissimo passato prossimo che a ben pochi fa piacere venga messa in pubblico. ↑
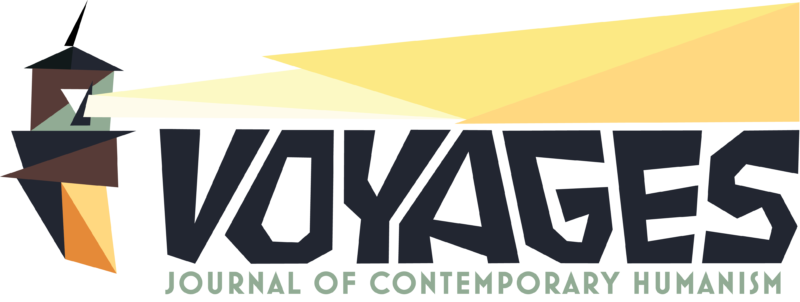

You must be logged in to post a comment.