
Photo Credit: Alessandra Capodacqua
«La natura umana», continuai, «ha i suoi limiti; può sopportare gioia, sofferenza o angoscia solo fino a un certo punto, oltre il quale si soccombe. Qui non si tratta di stabilire se uno è debole o forte, ma se è in grado di sopportare la sofferenza che gli è imposta, tanto morale che fisica; e trovo strano definire vile qualcuno perché si è tolto la vita, come troverei inconcepibile chiamare tale chi muore per una febbre maligna».
Goethe, I dolori del giovane Werther
Al liceo ero uno studente svogliato e ho pochissimi ricordi relativi alle lezioni, questo fa eccezione. Era l’ultima ora, l’aula era satura di anidride carbonica e oscillavo tra il sonno e la fame. Grattugiavo il banco con una punta di grafite, poi alzai la mano per una domanda. Era l’ora di Italiano e si parlava di Giacomo Leopardi; la professoressa ci aveva riportato la critica che alcuni coevi rivolgevano al suo pessimismo filosofico, riassumibile in «sei pessimista perché soffri». L’accusa mi sembrava crudele ma sensata, dunque domandai che cosa rispose il poeta. La professoressa rispose che Leopardi non negava che il suo stato avesse influito sul proprio pessimismo, ma che l’origine delle tesi non ne sconfessava la veridicità. Per quel che mi riguardava ero soddisfatto, il poeta aveva sistemato gli avversari. Il filologo e critico letterario Sebastiano Timpanaro parla della questione così:
Il Leopardi ha sempre protestato con piena ragione contro quegli avversari che credevano di potersi esimere dalla confutazione razionale del suo pessimismo presentandolo come il mero riflesso di una condizione patologica (pessimista perché gobbo!), privo quindi di ogni validità generale. Che questa tesi, nata dal livore clericale di Niccolò Tommaseo, ripresa poi dai positivisti alla Sergi e infine rintuzzata da Benedetto Croce, sia da respingere, non c’è dubbio. Ma il vero modo di respingerla non consiste nel negare, come pure si è fatto, ogni incidenza della malattia e della deformità fisica nella genesi della Weltanschauung leopardiana, di fare, quindi, del pessimismo leopardiano un fatto puramente «spirituale» o, seguendo un altro indirizzo, puramente politico-sociale. Bisogna invece riconoscere che la malattia dette al Leopardi una coscienza particolarmente precoce ed acuta del pesante condizionamento che la natura esercita sull’uomo, dell’infelicità dell’uomo come essere fisico. […] Il torto dei cattolici alla Tommaseo, dei positivisti alla Sergi, degli idealisti alla Croce non sta nell’aver affermato l’esistenza di un rapporto tra «vita strozzata» e pessimismo, ma nel non aver riconosciuto che l’esperienza della deformità e della malattia non rimase affatto nel Leopardi un motivo di lamento individuale, un fatto privato e meramente biografico, e nemmeno un puro tema di poesia intimistica, ma divenne un formidabile strumento conoscitivo. (pp. 150-182)
L’idea che il dolore sia un «formidabile strumento conoscitivo» oltre che nei filosofi del pessimismo risuona anche in molti artisti, tanto da aver contribuito al cliché dell’artista maledetto, l’unico dotato di sufficiente sensibilità e coraggio per scorgere la nuda essenza del cosmo. «Cos’è la sorte dell’uomo se non soffrire, e sorbire fino in fondo il calice della vita?» scrive Goethe nel Werther, e prosegue «perché io dovrei mostrarmi forte e dire che è dolce, se anche il Dio del cielo lo sentì troppo amaro per il suo labbro umano? Dovrei forse vergognarmi quando, in un attimo terribile, tutta la mia esistenza trema fra l’essere e il non essere, e il passato brilla come un lampo sull’abisso tenebroso del futuro, mentre tutto sprofonda intorno a me, e con me naufraga l’universo?».
Il filosofo norvegese Peter Zappfe, nel suo celebre e breve saggio L’Ultimo messia, sostiene che l’essere umano sia la sola creatura al mondo consapevole dell’inutilità e del continuo ripetersi della propria sofferenza ed è per questo che la sua condizione esistenziale è la “disperazione costante”. Contro l’evidenza che non tutte le persone al mondo manifestino segni continui di disperazione, il filosofo sostiene che la maggior parte di esse sia in grado di proteggersi da questo sentimento. Per Zapffe gli stati depressivi sono una falla in questi meccanismi protettivi, che nel suo scritto suddivide in quattro categorie: isolamento, ancoraggio, distrazione, e sublimazione. Descrivere il funzionamento di tali meccanismi ci porterebbe troppo lontano, ma è un tratto comune ai filosofi pessimisti la pretesa più o meno riuscita di individuare i metodi con cui ci accechiamo davanti all’orrore del cosmo. In La difficile condizione umana ne individua alcuni anche il filosofo sudafricano David Benatar, uno dei maggiori esponenti del pessimismo filosofico contemporaneo. Tra di essi, la breve durata dei piaceri rispetto a dolori, la maggior intensità del dolore rispetto alla gioia, la difficoltà nel realizzare tutti i propri desideri, la natura inesauribile del desiderio. Il filosofo parla inoltre di tre illusioni: il pregiudizio dell’ottimismo, grazie al quale si tende a sopravvalutare la qualità della propria vita; l’adattamento, per cui ci si abitua alla propria condizione, quale che sia; la comparazione, ovvero valutare la propria esistenza rispetto quella degli altri, con la conseguenza di elidere le condizioni negative comuni a chiunque. Ma la ricerca dei nostri autoinganni non si limita alla filosofia; in psicologia è celebre la cosiddetta sindrome di Pollyanna, ovvero la tendenza a ricordare e rievocare per lo più avvenimenti lieti, dimenticando quelli più sgradevoli e falsificando il computo reale. D’altra parte, secondo un mito tramandato da Eschilo, Euripide e Sofocle, già Sileno, quando fu catturato da Mida e costretto a rivelare la cosa più preziosa al mondo, disse: «Stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto» (p.31-32).
Come scrive il filosofo Claudio Kulesko,
Qualcuno potrebbe obiettare, a questo punto, che si tratta di due concezioni della natura morale del mondo mitiche, irrazionali, se non addirittura meramente religiose o ideologiche. La ragione, al contrario, sembrerebbe indicare un costante miglioramento della condizione umana, o quantomeno una placida neutralità del cosmo nei confronti della vita. Tuttavia, a differenza delle filosofie più rigorose, il pessimismo non ha bisogno di alcuna teodicea “inversa” ‒ capace di dimostrare scientificamente l’essenza malevola dell’universo.
La forza del pessimismo sta nel suo non dover giustificare un dato innegabile come la sofferenza, che da punto debole diventa un argomento a suo favore – chissà, forse anche il pessimismo fa parte del meccanismo della “sublimazione” individuato da Zappfe, data l’energia con cui lo difendono molte persone, al netto che dovrebbero preferire aver torto.
Più lontano nel tempo e nello spazio, anche la filosofia buddista era giunta a conclusioni analoghe, sebbene con esiti diversi da quelli dei pessimisti dell’occidente che pur ne erano edotti (penso a Schopenhauer e Cioran, ad esempio). Come scrive Gianluca Didino su L’Indiscreto,
Altrove ho provato a tracciare, molto sommariamente, i rapporti che legano pessimismo occidentale e Buddhismo; il tema del “dark Buddhism” richiederebbe ben altre investigazioni (al momento per quel che so il termine è applicato soltanto al lavoro di Morgan Rosenberg, che tenta una complessa ibridazione tra lo Zen e l’Oggettivismo di Ayn Rand) ma un punto fermo può essere sicuramente messo: se è vero che Siddharta Gautama assume la pillola nera al momento della sua illuminazione, altrettanto indubbio è questo “dark enlightenment” rappresenta soltanto il primo passo del suo insegnamento, la prima — e parzialmente la seconda — delle quattro Nobili Verità che costituiscono il fondamento del suo pensiero. Portandone il pensiero in Occidente, Schopenhauer si è soffermato sull’aspetto pessimistico del Buddhismo ignorandone il percorso soteriologico.
Il dolore è per il buddismo il punto di partenza di un percorso soteriologico che porta al suo superamento, una meta che generalmente non è prevista dai filosofi occidentali. Il pessimismo è dunque paragonabile a una diagnosi, che, con una grossa semplificazione, trova in disaccordo i medici d’Occidente e d’Oriente: per i primi la malattia è mortale, per i secondi curabile. Stabilire se esista o meno una medicina è un’impresa che non azzarderò adesso, anche perché la natura intrinsecamente soggettiva del dolore implica una fiducia cieca in chi si professa felice o infelice, dunque non potrei che esprimere un parere personale. L’argomento però si presta a un’altra speculazione: il pessimismo è davvero una lente più veritiera sulla realtà? E se anche fosse, che cosa conta di più, la verità o la liberazione dal dolore?
Sempre nell’articolo sopracitato, Didino scrive che:
C’è un aspetto che mi colpisce sempre quando mi imbatto nel tema del “realismo depressivo” e che la metafora della pillola nera (qui ben discussa da Claudio Kulesko) chiarisce perfettamente: l’idea che il pessimismo sia un modo più autentico di guardare alla realtà, una prospettiva più “oggettiva” sul Reale. Il depresso vedrebbe il mondo per quello che è, senza illusioni. In questo senso il ricorso al meme di Matrix è significativo: ingerire la pillola nera significherebbe “risvegliarsi” a una realtà più profonda — la consapevolezza, cioè, che il mondo è un luogo orrendo e che non possiamo fare nulla per renderlo migliore. Questa idea è alla base della locuzione stessa di “realismo depressivo”, coniata nel 1979 da due psicologhe statunitensi, Lauren Alloy e Lyn Ivonne Abramson, per descrivere la presunta capacità dei soggetti depressi di rapportarsi in maniera più realistica nei confronti del mondo rispetto ai non-depressi. Da un lato infatti, aspettandosi sempre il peggio, essi sarebbero meno portati a sottovalutare i rischi, mentre dall’altro sarebbero capaci di rapportarsi alla realtà in maniera più “distaccata”, senza edulcorarla.
Per scoprire se il pessimismo implica il realismo è necessaria una conoscenza certa della realtà, ma, sebbene molte persone ne vantino una, tali verità sono sempre da ascrivere a cornici metafisiche di riferimento (che si tratti di scienza, fede o altro). Il limite di queste cornici è che si fondano su assiomi che ne stabiliscono i criteri di veridicità (ad esempio il metodo scientifico o la fede) e dunque si accettano o rifiutano solo in base alla loro persuasività. A questo si aggiunge che il variegato mutare delle opinioni non solo divide le persone, ma anche la persona, in base al periodo, allo stato d’animo o al sopraggiungere di informazioni più o meno persuasive, come un miracolo o una scoperta scientifica.
A queste cornici inoltre si accompagna un valore assiologico: è un bene o male che la realtà sia così com’è? Se anche fosse possibile avere una conoscenza certa del cosmo, resterebbe da stabilire se questo stato di cose sia positivo o negativo per noi esseri umani. Se scoprissimo che gli gnostici avevano ragione, ad esempio, e che l’universo è retto da una divinità malevola, il valore assiologico sarebbe negativo.
Per chiarire cosa intendo, prendiamo il caso del “senso della vita”. Con una certa approssimazione, si può dire che sia la filosofia esistenzialista occidentale che la filosofia Zen concordano nel trovare la realtà priva di senso. Nel primo caso però la scoperta è causa di profonda angoscia, mentre nel secondo contemplare il vuoto è il culmine dell’illuminazione. Zen ed esistenzialismo concordano (più o meno) su una caratteristica del cosmo, ma non sul giudizio assiologico. Quale che sia la nostra posizione in merito dunque, il disaccordo palesa che il vuoto esistenziale non è un male di per sé, ma solo perché (e se) lo percepiamo come tale.
La medesima critica si può estendere a qualunque dolore, sebbene la cornice di riferimento di una martellata su un piede sembra trascendere la nostra volontà. Qui non si tratta più di interpretare il dolore, ma di percepirlo, e anche se ogni percezione è di fatto un’interpretazione, in questo caso è automatica e difficilmente eludibile. I confini però restano fluidi, tanto che quel che per una persona è un dolore per un’altra può diventare un dato neutro o addirittura un piacere – basta pensare a pratiche erotiche come il sadomasochismo, o all’uso di un anestetico.
Quale che sia la cornice di riferimento in uso, dunque, la sua più o meno efficace gestione del dolore non è necessariamente legata al proprio valore di verità. A corollario di quanto detto consegue che anche se esistesse una cornice di riferimento esatta, questo non implicherebbe che sarebbe la migliore per gestire il dolore.
Provo a fare un ulteriore esempio: immaginiamo due diverse cornici di riferimento attraverso le quali valutare il dolore umano, che indicherò tra parentesi quadre. Da una parte abbiamo la [religione] e dall’altra il [materialismo]. Per un/a materialista la religione è la cornice errata, ma ciononostante è innegabile che presenti pregi e difetti nel migliorare la qualità della vita di chi vi aderisce: un Dio che promette un paradiso dopo la morte a chi non mangia carne avrà il vantaggio di dotare il fedele della speranza di un aldilà e lo svantaggio di frustrare un determinato desiderio culinario. L’esempio si può ovviamente invertire, coi pregi e difetti del materialismo, come un gustoso piatto di carne e nessuna speranza di un aldilà. La cosa si complica se assumiamo come cornice di riferimento un’ipotetica anche se implausibile [verità su tutto], perché persino in questo caso non è detto che questa cornice sarebbe migliore o peggiore di altre nel lenire il dolore.
Tornando al pessimismo filosofico, sembra dunque che la pretesa di una maggiore veridicità sia infondata. Questo non toglie che il dolore possa essere un «formidabile strumento conoscitivo», ma ci apre alla possibilità che accada anche il contrario: così come esistono dei pregiudizi ottimisti possono esistere anche dei pregiudizi pessimisti. Il dolore, in breve, ci informa solo di se stesso. Chi come Avicenna intende la filosofia come uno strumento di guarigione capirà il sospetto del Buddha nei confronti della metafisica, o per meglio dire potrà innalzare a propria metafisica la guerra al dolore – ma in cosa consista questa lotta e come (e se) si possa vincere è un altro discorso.
L’ambientazione del romanzo Il mondo nuovo di Aldous Huxley esprime molto bene la difficoltà a cui siamo arrivati. Il racconto è ambientato in un futuro distopico (o utopico) in cui il mondo è governato da un regime totalitario dove viene fornito un medicinale chiamato “soma” alla popolazione , così chiamato in onore alla bevanda sacra dei Veda indiani. Il soma è in grado di garantire la totale beatitudine (o più precisamente una sorta di pace/ottundimento, il “vero” soma arriva ne L’Isola) di chi la assume. Senza soma, la società del Mondo Nuovo è senza dubbio distopica, perché implica il sacrificio di cose come la libertà, l’amore, la diversità culturale, l’arte, la religione, la letteratura, la filosofia e la scienza. Eppure il soma ribalta la lettura, perché garantisce la felicità senza alcun effetto collaterale che non sia lo stare al gioco. Un po’ come nel film Matrix , la conoscenza della realtà implica la perdita della felicità, ma resta il dubbio se ne valga la pena. Davanti alla scelta se perseguire la felicità o la verità, è raro trovare persone che scelgono la prima senza la certezza (o l’autoconvinzione) che questa implichi anche la seconda. In alcuni casi la fede fa parte dell’efficacia, come per la religione, e purtroppo non mi viene in mente alcun caso realmente esistente di “soma” o “pillola blu” da poter valutare.
Il pessimista sostiene di accettare una verità dolorosa anche se questo va a discapito della propria felicità, ma metà della sua scelta si allinea a quella di chiunque, ovvero la convinzione di avere una percezione corretta della realtà. Pessimista, materialista, religiosa o mistica che sia, ogni persona confida nella cornice di riferimento che adotta al momento, sebbene l’unica certezza che può vantare è una credenza, a cui si aggiunge un giudizio assiologico. Per superare il problema ci si potrebbe affidare a delle assiologie scettiche, che apparentemente non si espongono sulla natura della realtà, ma di fatto anche lo scetticismo è una cornice di riferimento, sebbene con l’inusuale caratteristica di essere la [cornice che rifiuta le cornici]. Che il pessimismo sia un formidabile strumento conoscitivo o un ennesimo (e contorto) meccanismo protettivo, dunque, è indecidibile: l’unica garanzia che ci lascia è l’esistenza del dolore. Resta da capire se quest’ultimo sia curabile o meno, ma chi crede nella finitezza dell’uomo può sempre consolarsi con l’idea che è in ogni caso destinato a finire – è una buona o una cattiva notizia?
Bibliografia
Benatar, David, La difficile condizione umana, Giannini, Napoli, 2020
Dogen Zenji, Aldo Tollini, Pratica e illuminazione nello Shobogenzo, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 2001
Dogen Zenji, Aldo Tollini, Buddha e natura di Buddha nello Shobogenzo, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 2004
Nietzsche, Friedrich, La nascita della tragedia, considerazioni inattuali, I-III, Adelphi, Milano, 1972, pp. 31-32
Goethe, Johann Wolfgang, I dolori del giovane Werther, Feltrinelli, Milano, 2014 (consultato in digitale)
Huxley, Aldous, Il mondo nuovo, Mondadori, Milano, 2016
Timpanaro, Sebastiano, Il pessimismo «agonistico» di Leopardi, da Classicismo e illuminismo, Nistri-Lischi, Pisa, 1965, pp. 150-182
Zapffe, Peter, The last Messiah, originally published in Janus #9, 1933, Philosophy Now, issue 45 (disponibile online su https://philosophynow.org/issues/45/The_Last_Messiah)
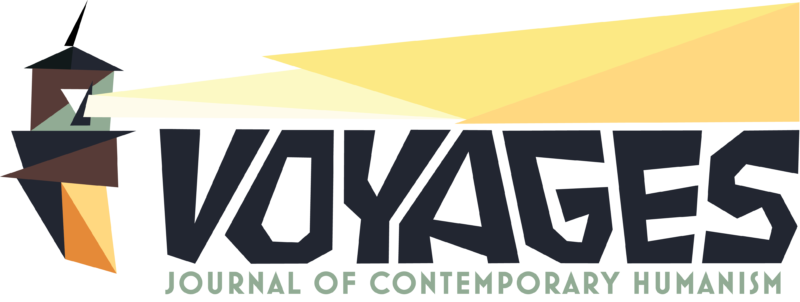

You must be logged in to post a comment.